Brasile/Si è spento il cineasta PAULO CÉSAR SARACENI

Paulo César Saraceni, regista brasil/italiano, è scomparso sabato 14 aprile 2012 all’Hospital Federal di Lagoa, zona a sud di Rio de Janeiro, città dov’era nato il 5 novembre 1933. Da giovane si dedicò allo sport con buoni risultati, ma gli esperti sanno che è stato uno dei grandissimi protagonisti del “cinema novo”, fenomeno cinematografico brasiliano degli anni Sessanta. Il suo primo film di “cinema novo” fu “Porto das Caixas” (1962), e in alcune pellicole le musiche sono del maestro Tom Jobim. Scrive il critico de Il Manifesto Roberto Silvestri: “ I suoi film, gioioso mix di rivoluzione e tropicalismo, hanno sfidato ogni regola”. Leggete l’importante omaggio di Silvestri che riprendiamo dal quotidiano romano, e che ringraziamo.
Marxe samba di Roberto Silvestri
Nel «cinema novo» l’oriundo italiano di Ipanema portò leggerezza gioia e spietato «senso del gol». L’ex centravanti del Fluminense mise a nudo infatti gli orrori del sottosviluppo.Il neorealismo, Roberto Rossellini («Meu deus»), padre Arpa, Sandro Franchina, il Centro Sperimentale di cinematografia di Roma, Gianni Amico, Lea Massari («quell’incredibile brasiliana nell’anima»), il festival di Santa Margherita Ligure che aprì l’Italia al mondo normale, l’operatore e direttore della fotografia Guido Cosulich, Marco Bellocchio, Bernardo Bertolucci… Non solo perché era di antiche origini milanesi (nonno) e senesi (nonna) e forse ancor più antiche molisane, ma è molto intrecciata all’Italia e al cinema italiano, anche se da noi pochi lo ricordano, forse per aver scoperto su Fuori orario il suo documentario su uno spicchio aureo di Estate romana nicoliniana, Bahia do todos os sambas, la vita avventurosa e l’opera del filmmaker brasiliano, dandy, biondo e rivoluzionario, del marxista festivo come si definiva, Paulo Cezar Saraceni, morto sabato a 79 anni.
 L’ex centravanti delle giovanili del Flumeniense, la riserva del numero 10 Vavá nel 1952, che creò assieme a Glauber Rocha e un manipolo di visionari il cinema novo, aprendo il mondo a cose mai viste e riprese prima, al cinema puro, al cinema totale, al cinema «meraviglioso», basta generi basta convenzioni basta divismo… In Italia era di casa, con Moravia Antonioni e Vitti al bar Rosati di piazza del popolo a Roma, ha vinto festival, era molto stimato da Rossellini, ha presentato i suoi film nei festival (Natal da Portela a Riminicinema, dove impazzì per la retrospettiva di Tatsumi Kumashiro), collaborato con Bellocchio al suo corto L’alba romana, con Franchina al suo unico, mirabile lungo road movie Morire gratis (1966) e con Gianni Amico, superambasciatore dei novisti nel mondo, a Tropici.
L’ex centravanti delle giovanili del Flumeniense, la riserva del numero 10 Vavá nel 1952, che creò assieme a Glauber Rocha e un manipolo di visionari il cinema novo, aprendo il mondo a cose mai viste e riprese prima, al cinema puro, al cinema totale, al cinema «meraviglioso», basta generi basta convenzioni basta divismo… In Italia era di casa, con Moravia Antonioni e Vitti al bar Rosati di piazza del popolo a Roma, ha vinto festival, era molto stimato da Rossellini, ha presentato i suoi film nei festival (Natal da Portela a Riminicinema, dove impazzì per la retrospettiva di Tatsumi Kumashiro), collaborato con Bellocchio al suo corto L’alba romana, con Franchina al suo unico, mirabile lungo road movie Morire gratis (1966) e con Gianni Amico, superambasciatore dei novisti nel mondo, a Tropici.
La frase-manifesto che ben sintetizza il cinema novo (Il mio viaggio nel cinema novo è il titolo della sua autobiografia del 1993), quel movimento poetico, rabbioso, dolcissimo e cannibale – perché i tre mondi dovevano divorare Hollywood&Mosfilm e il cinema borghese d’autore in un sol boccone – «un’idea in testa e una cinepresa in mano», che molti attribuiscono a Glauber Rocha, fu in realtà inventata proprio del regista carioca, erede dell’arte di arrangiarsi con l’equipaggiamento leggero, che nacque a Gavéa, Ipanema, il 5 novembre del 1933 e che nel 1959 avrebbe decolonizzato il cinema brasiliano strappandolo alle sue ossessioni subcommerciali della pornochanchada di Atlantida e del modello Vera Cruz «clonato dall’estero». Gli riuscì in un solo colpo e con un solo corto (su una comunità di pescatori intrappolati nella rete delle grandi compagnie), firmando assieme al montatore Mario Carneiro, Arraial do Cabo, omaggio a Eisenstein e al neorealismo. «È stato il primo segno di vita del documentario brasiliano, Humberto Mauro a parte» commenterà Rocha sul Jornal do Brasil (1960). «Il regista-autore per manifestarsi – dirà lo stesso Saraceni in linguaggio tropicalista su quella esperienza – deve diventare una entità, un orixa, o un caboclo, o anche un pomba-gira, e penetrare nella testa di ogni componente del cast e dell’equipe. Tutti devono essere lui, in modo manifesto ma occulto, più è occulto meglio è. Falconetti non era forse Dreyer che brucia sul rogo in Giovanna d’Arco? Meglio dunque essere attore e regista nello stesso tempo. Il regista diventa così la mano occulta di dio, ha il potere di creare, ma non per usarlo arbitrariamente o autoritariamente o per mettersi in mostra e affermarsi: il regista è lì per dire una cosa, per suggerire un’emozione, deve buttare fuori il demonio di quel suo sogno, il cinema è la più complessa delle arti, se non fosse così difficile lo scrittore Guimaraes Rosa, che è il John Ford di Minas, farebbe cinema».
 Come e perché Saraceni sia passato al giornalismo, alla militanza nei cineclub, alla critica (1954-1955), al teatro (1956) fino a esordire nel cinema con il pluripremiato cortometraggio Caminhos che lo portò al Centro Sperimentale di Roma nel 1961, dove conosce Gustavo Dahl, abbandonando una promettentissima doppia carriera sportiva di nuotatore e pallanuotista, da una parte e di attaccante al fianco di Pelé e Garrincha, e senza soluzione di continuità, è dunque facilmente comprensibile. Porto da Caixas e O desafio (La sfida) i due suoi primi lungometraggi, oggi considerati classici della nouvelle vague brasiliana, firmati nel 1963 e nel 1965, in realtà sono una sfida coraggiosa al capitalismo selvaggio imposto al ricco e rapinato paese, una prosecuzione naturale della sua agonistica natura di «regista del centrocampo», di giocatore di squadra, come si nota anche dal suo secondo titolo.
Come e perché Saraceni sia passato al giornalismo, alla militanza nei cineclub, alla critica (1954-1955), al teatro (1956) fino a esordire nel cinema con il pluripremiato cortometraggio Caminhos che lo portò al Centro Sperimentale di Roma nel 1961, dove conosce Gustavo Dahl, abbandonando una promettentissima doppia carriera sportiva di nuotatore e pallanuotista, da una parte e di attaccante al fianco di Pelé e Garrincha, e senza soluzione di continuità, è dunque facilmente comprensibile. Porto da Caixas e O desafio (La sfida) i due suoi primi lungometraggi, oggi considerati classici della nouvelle vague brasiliana, firmati nel 1963 e nel 1965, in realtà sono una sfida coraggiosa al capitalismo selvaggio imposto al ricco e rapinato paese, una prosecuzione naturale della sua agonistica natura di «regista del centrocampo», di giocatore di squadra, come si nota anche dal suo secondo titolo.
Il primo è un dramma femminista assolutamente sconvolgente e imprevedibile nello smontare disinvoltamente il catechismo della suspense «hitchcockiana». Il film è il grido di rivolta della donna brasiliana. La sua situazione la porta al crimine. Per quel crimine lei non verrà punita. «Un film rivoluzionario – spiegò Saraceni – non può essere organizzato e pamphlettistico con parole d’ordine come riforma agraria, etc. Dovrà essere una ribellione anarchica, mistica, incosciente, per arrivare alla coscienza del popolo. Io volevo una rivoluzione e non una riforma agraria che il popolo affamato e analfabeta non sapeva che cos’era. Il film, tratto da un romanzo di Lucio Cardoso, attaccava Hollywood in due punti. La donna criminale rimane libera, illuminata da un sole redentore. Resta pura, non arriva la polizia. Niente prigione e niente morte dell’assassino come vorrebbe «la legge del cinema». Secondo. Lo spettatore capisce dalla prima inquadratura che la donna ucciderà il marito, non c’è nessun gioco col pubblico. In breve ho ribaltato tutta la logica del film commerciale corrotto e discriminatorio». Il secondo film, La sfida, è una riflessione sugli errori madornali della sinistra brasiliana (cui dedica anche il polemico doc anti razzista Integrazione razziale nel 1964), paralizzata dalle proprie origini di classe borghese e incapace di anticipare e fermare la rovina del paese, tra l’autogolpe di Quadros del 1960 (il presidente anticomunista che proibì i bikini in spiaggia ma decorò per antiamericanismo Ernesto Che Guevara) e il vero colpo di stato militare del 1964. Perse per questioni di mesi le Olimpiadi di Helsinki del 1952 (avrebbe superato di poco, maledettamente, i 18 anni), Saraceni continuò a giocare a calcio con i suoi amici cineasti (nel 1967 in piana dittatura Castelo Branco nella sua squadra giocavano Julio Bressane (difesa), Mario Carneiro, Eduardo Coutinho, Luis Carlos Barreto, e Rui Solberg (in attacco)… e considerò il cinema (e anche la politica) un’arte che aveva molto a che fare con il calcio, dell’azzardo e della passione giocosa, non del dogma quaresimale, .
In fondo il team del cinema novo aveva una forza, una compattezza e un immaginario «da spogliatoio» colto, ed era una formazione davvero stellare, panchina e riserve comprese : Glauber Rocha, Ruy Guerra, Leon Hirzman, Walter Lima Júnior, Zelito Vianna, l’amicissimo Joaquim Pedro de Andrade, David Neves, Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues e in effetti i loro film, nelle sale, fecero lo stesso effetto di Gilmar, Garrincha, Pelé, Didi e Nilton Santos in campo.
 Gli altri film di Saraceni, una dozzina, fino all’ultimo, O gerente, che Muller rifiutò a Venezia 2011, Amor, carnaval e sonhos, Ao sul do meu corpo, Capitu, A casa assassinada, Anchieta José do Brasil, Newton Cavalcanti, Banda de Ipanema, O viajante, realizzati sempre superando difficoltà terribili, che ebbero sempre come «grande sostenitore» il dirigente cinefilo del Fluminense, Octavio de Farias, furono considerati dal regista una maniera per liberarsi: «il nostro carnevale è nato sotto questo sole di pura energia grazie ai numerosi immigrati neri gialli bianchi rossi… ed è un mélange continuo di ricordi d’infanzia, di sentimenti, di storie vere e inventate, di sesso, di piacere, di storie ritagliate dai giornali, di calcio per strada, questa unione per l’organizzazione che ha in mente come obiettivo la vittoria ma principalmente lo scontro ludico, la poesia del piacere. Il carnevale, il calcio era una democrazia ideale e totale. Il sogno era perfetto. Ma il mondo degli adulti era l’oppressione totale, l’ingiustizia, l’anti gioco, la violenza. Nelle sale oscure del cinema il sogno rinasceva. La sensazione era che si poteva trasformare quella suddetta realtà con l’inconscio, col sogno. Rossellini era la capacità di essere sempre pronti a inventare, a creare, a improvvisare, era di nuovo il samba o la fantasia operativa senza alcun limite. Che nostalgia per chi ci ha lasciato… Otavio de Farias, Lucio Cardoso, Humberto Mauro, Paulo Emilio Salles Gomes, André Bazin, Pasolini, Langlois, Grande Otelo, Joaquim Pedro de Andrade, Gianni Amico, Sandro Franchina, Glauber Rocha, Gustavo Dahl, Rogerio Sganzerla…».
Gli altri film di Saraceni, una dozzina, fino all’ultimo, O gerente, che Muller rifiutò a Venezia 2011, Amor, carnaval e sonhos, Ao sul do meu corpo, Capitu, A casa assassinada, Anchieta José do Brasil, Newton Cavalcanti, Banda de Ipanema, O viajante, realizzati sempre superando difficoltà terribili, che ebbero sempre come «grande sostenitore» il dirigente cinefilo del Fluminense, Octavio de Farias, furono considerati dal regista una maniera per liberarsi: «il nostro carnevale è nato sotto questo sole di pura energia grazie ai numerosi immigrati neri gialli bianchi rossi… ed è un mélange continuo di ricordi d’infanzia, di sentimenti, di storie vere e inventate, di sesso, di piacere, di storie ritagliate dai giornali, di calcio per strada, questa unione per l’organizzazione che ha in mente come obiettivo la vittoria ma principalmente lo scontro ludico, la poesia del piacere. Il carnevale, il calcio era una democrazia ideale e totale. Il sogno era perfetto. Ma il mondo degli adulti era l’oppressione totale, l’ingiustizia, l’anti gioco, la violenza. Nelle sale oscure del cinema il sogno rinasceva. La sensazione era che si poteva trasformare quella suddetta realtà con l’inconscio, col sogno. Rossellini era la capacità di essere sempre pronti a inventare, a creare, a improvvisare, era di nuovo il samba o la fantasia operativa senza alcun limite. Che nostalgia per chi ci ha lasciato… Otavio de Farias, Lucio Cardoso, Humberto Mauro, Paulo Emilio Salles Gomes, André Bazin, Pasolini, Langlois, Grande Otelo, Joaquim Pedro de Andrade, Gianni Amico, Sandro Franchina, Glauber Rocha, Gustavo Dahl, Rogerio Sganzerla…».
Che nostalgia per Paulo Cesar Saraceni. Il cinema è più vivo che mai. Su You tube ho appena trovato Botafogo, allegria del popolo, Garrincha, versione completa…
(Il manifesto 17 aprile 2012)
Le foto inserite nel testo provengono dalla rete.



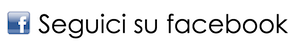






 Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.
Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.












 presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.
presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.