Jazz non per un giorno

Il giornalista Filippo Bianchi, che ha diretto per undici anni Musica Jazz, d’ora in poi regalerà i suoi illuminanti editoriali ai lettori di PAN -Performing Arts Network . Riprendiamo dal n.2, giugno 2012, in distribuzione da pochi giorni e disponibile anche per il download, su www.erjn.it/pan, il pezzo “Jazz non per un giorno“. Chiunque voglia potrà pubblicare i suoi editoriali alla condizione di non apportare modifiche al testo e di citare la fonte. Grazie Filippo!
“It’s not exclusive, but inclusive, which is the whole spirit of jazz.” Herbie Hancock **
Per la prima volta da quando, più di un secolo fa, Buddy Bolden cominciò ad abbozzare una musica che poi si sarebbe chiamata jazz, la necessità di promuovere questa forma d’arte ha avuto lo scorso 30 aprile un riconoscimento planetario, con la proclamazione da parte dell’Unesco della “Giornata del jazz”.
E, come purtroppo spesso accade, viene da domandarsi se l’Italia aderisca allo spirito di quel lodevole consesso internazionale…
Le motivazioni addotte per la celebrazione di questa data potranno magari parere scontate a chi di jazz si occupa più o meno approfonditamente, ma vale la pena riportarle perché rappresentano ciò che ormai tutto il mondo dà per acquisito.
“Scopo di questa giornata è quello di far crescere nella comunità internazionale la consapevolezza delle qualità del jazz, come mezzo formativo, come forza di pace, di unità, di dialogo e di più stretta cooperazione fra le persone. Molti governi, associazioni, strutture didattiche e privati cittadini attualmente impegnati nella promozione del jazz coglieranno quest’opportunità per incoraggiare un maggiore apprezzamento non solo per questa musica, ma per il contributo che può dare allo sviluppo di società più inclusive”.
 Ed è su quest’ultima parola che conviene ragionare brevemente. La struttura stessa dei nostri magnifici teatri è una rappresentazione di divisione sociale concepita per escludere (ricordiamo che una volta i palchi erano privati: la loro gestione era affidata a società di palchettisti, che annualmente li affittavano agli aristocratici; alla plebe erano riservati loggioni e platee senza posti a sedere). Oggi non è molto diverso: il destinatario sociale dei teatri d’opera e di tradizione è formato dai cittadini più abbienti, e a loro è devoluto quasi per intero il finanziamento statale della musica. Perché? Perché lo stato riconosce al loro andare a teatro un’“utilità sociale”, in larga misura negata a chi predilige invece altre musiche, fra cui il jazz occupa il posto di maggior rilievo.
Ed è su quest’ultima parola che conviene ragionare brevemente. La struttura stessa dei nostri magnifici teatri è una rappresentazione di divisione sociale concepita per escludere (ricordiamo che una volta i palchi erano privati: la loro gestione era affidata a società di palchettisti, che annualmente li affittavano agli aristocratici; alla plebe erano riservati loggioni e platee senza posti a sedere). Oggi non è molto diverso: il destinatario sociale dei teatri d’opera e di tradizione è formato dai cittadini più abbienti, e a loro è devoluto quasi per intero il finanziamento statale della musica. Perché? Perché lo stato riconosce al loro andare a teatro un’“utilità sociale”, in larga misura negata a chi predilige invece altre musiche, fra cui il jazz occupa il posto di maggior rilievo.
Cosa significa “riconoscimento”? Il pubblico il jazz lo ha riconosciuto di certo, visto che si è moltiplicato col moltiplicarsi dell’attività. E infatti di jazz in Italia se ne fa molto. Solo poche decine d’anni fa, a cavallo fra gli anni ’70 e ’80, era un fenomeno “stagionale”, al pari delle ciliegie e dei cocomeri: qualche raro festival estivo (Umbria, Pescara, Ravenna) per togliersi il pensiero, e si tornava alla musica “seria” relegando il jazz a rarissimi piccoli club (privati). Poi questo “virus benefico” (per usare una metafora cara a Steve Lacy) ha preso a diffondersi: è entrato nei programmi dei teatri d’opera e di tradizione, in parte per via di direzioni illuminate, in parte per far numeri, impinguando incassi di botteghino altrimenti carenti; i festival e le rassegne promossi da enti locali si sono moltiplicati all’inverosimile in ogni angolo della penisola, da Clusone a Roccella Jonica.
Ma le istituzioni? Lo schema generale è rimasto invariato e quindi il jazz continua ad essere un “abusivo”, ingombrante finché si vuole, ma mai “riconosciuto” nella sua specificità. Il termine jazz, per dire, non è mai comparso in nessuna delle proposte di legge di riforma dell’attività musicale presentate, e abortite, in questo trentennio.
Qui la dignità del jazz dipende, in termini di sostegno pubblico, da chi lo propone. In pratica se un concerto, poniamo, di Paolo Fresu lo organizza una fondazione lirica ha diritto a un finanziamento x, se invece lo organizza un’associazione specializzata in jazz il finanziamento è molto inferiore. Perfino nelle trasmissioni Rai il costo di acquisizione e perfino il diritto d’autore variano a seconda che il soggetto organizzatore sia di estrazione classica o jazz.
Si sarebbe tentati di definirlo razzismo, ma forse è parola fin troppo “nobile”: somiglia piuttosto al buon vecchio clientelismo all’italiana, fatto di privilegi incomprensibili fondati sull’appartenenza a una qualche casta, più che sulla competenza.
C’è chi dice che la battaglia per un maggiore riconoscimento al jazz sia settaria e assurda. Sarà utile ricordare loro quanto mi ha detto una volta Chick Corea: «Sai, nel mondo combattiamo continuamente per delle libertà per cui non parrebbe davvero necessario dover lottare. La tematica dei diritti umani, ad esempio, diventa tale solo perché quei diritti vengono negati. I diritti degli artisti e la libertà d’espressione rientrano fra le libertà per cui combattiamo». E fra i diritti del contribuente rientra quello di vedere il tipo di musica che preferisce incluso fra quelli che lo stato finanzia, con diritti uguali a quelli delle altre musiche d’arte… Forse in occasione di una prossima “giornata del jazz” sarebbe opportuno non solo organizzare qualche apprezzabile concerto, ma far presente a chi ci governa che esiste anche il jazz. E siccome esiste da più di un secolo, ed è nel cuore di molte persone, sarebbe ora che se ne accorgessero.
** Non è esclusivo ma inclusivo, che è giusto lo spirito del jazz.



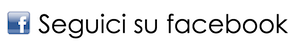






 Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.
Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.












 presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.
presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.