Il sentire comune di Annie Whitehead

L’intervista alla trombonista britannica curata dal giornalista Filippo Bianchi è stata pubblicata sul n.1- Febbraio 2015 di PAN Performing Arts Network, periodico quadrimestrale diretto da Sandra Costantini.
Se è un suonatore di fiati inglese, di solito ci sono pochi dubbi sul retaggio: la tradizione delle brass bands da quelle parti è più radicata e diffusa che da noi la lirica. Nel nord del Paese questo è probabilmente ancor più vero, e infatti Annie Whitehead viene da Oldham, nel Lancashire. Individuata la sorgente, geografica e culturale, il flusso che ne è disceso è quanto di più vario e ramificato. La sua prima prova da leader risale al 1984, ma la voce rotonda del suo trombone ha investito contesti tanto vari quanto la Brotherhood of Breath, i National Health, Carla Bley, Robert Wyatt, John Stevens, Joan Armatrading, la Penguin Cafe Orchestra, Chris Rea, Bill Wyman, Elvis Costello, Dudu Pukwana, Jah Wobble, Working Week, per citarne solo alcuni…
Per dare un’idea ulteriore dell’ampiezza dei suoi orizzonti, la colonna sonora di questa intervista consta di Skatalites, Chris McGregor solo, Jelly Roll Morton, Dudu Pukwana & Zila, Abdullah Ibrahim, Jonas Gwangwa, Duke Ellington, Antibalas, Ali Farka Touré e Ry Cooder…
 Certamente avrai risposto a questa domanda un migliaio di volte, ma puoi raccontarci come è nato il progetto Soupsongs?
Certamente avrai risposto a questa domanda un migliaio di volte, ma puoi raccontarci come è nato il progetto Soupsongs?
È stata un’idea di Dave Groom, che è un promoter e grande fan di questa musica attivo nell’area di Newark. Avevo già fatto un progetto simile, che aveva avuto un certo successo, con John Etheridge, sulle musiche di Frank Zappa. Così Dave ha chiesto a Robert se l’idea di un progetto live basato sulle sue musiche gli piaceva e se si sarebbe fatto coinvolgere. A Robert piacque molto, ma non aveva intenzione di suonarci, né di assemblare lui l’organico. Esaminarono alcuni nomi, e sono felice di dire che infine la scelta cadde su di me! In un primo momento pensai di dover fare in qualche modo solo il direttore musicale per conto di Robert, ma quando ci incontrammo fu chiaro che mi lasciava completamente carta bianca. Abbiamo discusso della band e Robert, che aveva da poco sentito il mio quintetto al Grimsby Jazz Festival, suggerì di usare quello come base: Jennifer Maidman, Janette Mason, Steve Lamb e Liam Genockey. Successivamente abbiamo coinvolto George Khan, Didier Malherbe, Harry Beckett, Phil Manzanera e Julie Tippetts. Ero del parere che Jennifer dovesse anche cantare e che la sua voce sarebbe stata un bel contraltare per quella di Julie. L’organico continua a mutare, dipende anche da chi è disponibile al momento, ma c’è un “nocciolo duro”, composto da Jennifer, Cristina Donà, Sarah-Jane Morris e Liam Genockey, senza il quale non mi troverei a mio agio. A Ravenna ospiteremo per la prima volta Theo Travis, e devo dire che l’idea mi affascina molto e non vedo l’ora.
Una volta Robert Wyatt ha detto che quando ragiona su come completare l’organico per una canzone appena abbozzata non pensa a degli strumenti ma a delle persone. Tu hai un approccio simile?
Certamente è stato così per questo progetto: non abbiamo pensato tanto in termini di strumentazione bensì di persone, tessuto, sentire comune e spirito. Ma anche più in generale seguo quel criterio. Ovviamente io ho fatto più lavoro dal vivo di Robert, quindi per me una band deve funzionare soprattutto sul palco. Nel lavoro di studio c’è più libertà di scelta. Nelle mie band ho preferito lavorare per anni con le stesse persone, intanto perché mi piace il loro stile e mi stimola suonarci insieme, ma anche perché mi piacciono come individui, mi ci trovo bene. A volte mi irrita quando la gente mi chiede nuove formazioni: penso di suonare meglio quando sono a mio agio coi partner, specialmente la sezione ritmica; Liam, Jennifer e Steve Lodder sono stati a lungo le persone con cui volevo suonare, più o meno in ogni progetto che ho sfornato nell’ultimo ventennio. Per quanto riguarda i fiati, ho privilegiato il quartetto pianoless Rude, con Harry Beckett, dal 1990 fino al 2010 (data della sua scomparsa, non posso pensare che sono già passati cinque anni). Suonare con Harry era un’esperienza che amavo molto: aveva uno stile talmente insolito e personale, era veramente un pezzo unico, e, di nuovo, una splendida figura. Ma anche quando suono con altri fiati, adotto il medesimo criterio: la risposta alla tua domanda è decisamente affermativa; contano le persone. La questione importante è: trattasi di gente con cui posso connettermi con agio, e che vuole connettersi con me?
 La contaminazione fra linguaggi diversi è uno dei tratti più interessanti della musica britannica fine anni Sessanta. Come mai, secondo te, questo processo è iniziato nel Regno Unito (ben prima di Bitches Brew)? Tu stessa sei stata e sei ancora attiva in una miriade di linguaggi…
La contaminazione fra linguaggi diversi è uno dei tratti più interessanti della musica britannica fine anni Sessanta. Come mai, secondo te, questo processo è iniziato nel Regno Unito (ben prima di Bitches Brew)? Tu stessa sei stata e sei ancora attiva in una miriade di linguaggi…
Credo che la mia esperienza personale di tutto ciò sia piuttosto “innocente”: i musicisti tendono ad ascoltare qualsiasi cosa capiti loro e sedimentarla dentro; almeno a me capita così. Sono cresciuta in una città del nord, negli anni Cinquanta-Sessanta, e la mia esperienza musicale si formava con ciò che sentivo alla radio (musica pop), ciò che ascoltava mia nonna (Ray Charles e big band di jazz); coi parenti si cantava alle feste, e mio fratello ed io imparavamo molte canzoni a memoria. E fin qui tutto normale. Ma c’era anche una gran quantità di attività sociali in città: parate e marce di vario tipo, suonate dalle bande di ottoni, e per me quelli erano i suoni più eccitanti al mondo, oltre che la sola musica che ascoltassi dal vivo (a parte le feste di cui sopra e i cantanti dei club). Poi arrivarono dei vicini di casa provenienti dalle Barbados, che ballavano e suonavano ska e lovers rock (sottogenere della musica reggae, ndr). I miei genitori ballavano swing, jive, rock and roll, la qual cosa molto mi eccitava… e poi sono arrivati la Motown e il soul, che io stessa ballavo!
Comunque, quel che sto cercando di dire è che tutto ciò per me era ugualmente meraviglioso – non è che lo ordinassi secondo una scala gerarchica di valori – volevo solo nutrirmi di quanta musica possibile. Quando ho iniziato a suonare nella banda cittadina, avevo la consapevolezza che il suono del trombone, e degli ottoni in generale, era presente in tutta la musica che girava all’epoca, e volevo misurarmi con tutto ciò: non pensavo che un genere fosse migliore, o anche solo più facile o difficile, di un altro; ero musicalmente onnivora.
Quando ti trasferisti a Londra, negli anni Settanta, la scena della free improvisation era molto viva e attiva. Per quanto ne so, hai collaborato a lungo con John Stevens. Altri musicisti di quella generazione con cui hai suonato o che hanno in qualche modo influenzato la tua musica?
La ragione per cui mi trasferii a Londra, da Jersey, dove abitavo allora, fu proprio il fascino che la scena musicale di quel tempo esercitava su di me. Avevo da poco cominciato ad ascoltare molto jazz – i miei beniamini erano Roswell Rudd, Don Cherry, Gato Barbieri (con la JCO), Jimmy Knepper, Eric Dolphy con Mingus – e mi fu chiaro che quella era la città in cui avrei potuto mescolarmi con quell’ambiente… Avevo anche acquistato il primo album della Brotherhood of Breath e volevo ascoltarli in concerto, vedere che tipi erano. A quel punto non mi sognavo nemmeno di suonare con personaggi così, volevo solo essere in quel giro. Trovai qualche lavoretto a Londra come musicista (anche se mi guadagnavo da vivere in una panineria del West End), ma si trattava soprattutto di turni e gruppi funk (che pure era magnifico), e il jazz era per me ancora un hobby. Comunque, presi a frequentare gente nell’ambiente e (con terrore) ad essere invitata a suonare con loro. Uno dei primi musicisti che ho conosciuto è stato Paul Rogers, che mi chiese di entrare nella sua band, 9RPM. Poco dopo conobbi anche Harry Beckett e John Stevens. Cominciavo a sentirmi un po’ più a mio agio, a verificare se quel che suonavo si potesse inserire in quelle situazioni e magari farsene influenzare. Di certo fui molto colpita da Harry, anche se non potevo certo pretendere di suonare come lui, che aveva uno stile assolutamente unico. Un’altra personalità di cui sicuramente subii l’influenza fu Dudu Pukwana, soprattutto in termini di sostanza emotiva, la qualità così “vocale” della sua voce strumentale. Ecco, era più un fatto di approccio che di stile, l’aspetto emotivo del suonare, quasi un urlo, e una forte necessità di connessione reciproca. Spesso apprezzo anche un approccio di tipo intellettuale alla musica, ma non più di tanto.
A quel tempo in cui chiunque suonasse tre note in fila che vagamente somigliavano a una melodia era considerato un traditore (o un agente della CIA), i Blue Notes irruppero sulla scena britannica, portando con sé un corredo di melodie incredibili e molto originali. Immagino che tu ti sia molto divertita con gli “Azanians”, ma come faceva la Brotherhood of Breath a tenere insieme e amalgamare così tanti retaggi e orientamenti diversi (una fra tante ragioni che la rendevano così interessante)?
Al tempo della prima Brotherhood vivevo ancora a Jersey, quindi sono arrivata quando l’impatto dei Blue Notes era già avvenuto. Piuttosto si era sviluppata una musica “crossover” più mainstream, e c’era una miriade di band di ska e reggae, e la prima generazione di world music. La scena della salsa non era ancora alla moda come poi diventò: le band erano piuttosto sul versante “alternativo”, e non era nemmeno facile procurarsi i dischi; conservava un sapore molto “etnico”. Mi affascinava quella prevalenza dell’elemento ritmico che per me era del tutto inedita. Facevo anche parte di un gruppo di nove elementi chiamato Onward International All Stars, formazione inter-culturale che suonava un misto di musiche cubane, sud-africane, reggae e funk. Capisco che ora tutto ciò sembri “normale”, ma allora aveva ancora un sapore molto fresco. Ma tornando agli “Azanians”, il mio approccio parecchio emotivo rendeva la collaborazione con loro facile e feconda. Oltretutto mi apprezzavano ed erano sempre incoraggianti e aperti, c’era un evidente sentire comune. Ho suonato con Dudu e Pinise Saul, ma anche con Harry, e con Evan Parker nei Fast Colour di John Stevens. Al tempo stesso, con Lucky Ranku e Pinise, mi misuravo con la musica sudafricana più classica, quindi, di nuovo, per me non contano tanto i generi quanto il sentire comune che riesco a stabilire con gli altri musicisti… Lavorare con la Brotherhood of Breath di Chris McGregor, poi, è stato un grande privilegio e una vera gioia! Ero una grande fan dell’orchestra dal primo momento che li ho sentiti, e direi che suonare insieme a Chris è stato l’apice di quell’esperienza. Ovviamente mi affascinava molto anche come persona: uomo generoso, aveva un grande cuore ed era anche divertente; il suo talento era evidente in qualsiasi cosa facesse! Per quanto riguarda l’ultima parte della tua domanda, Chris aveva incamerato così tanti stili diversi quante erano le sue passioni: Ellington, la musica per big band in generale, l’innodica protestante scozzese, la musica sudafricana con cui era cresciuto a Transkei. (È la prima volta che cito gli inni protestanti, ma credo che scorrano quasi in tutte le musiche che mi hanno influenzato).
La tua opinione su tre grandi trombonisti inglesi della generazione precedente la tua: Paul Rutherford, Nick Evans e Alan Tomlinson.
Chiaro che sono tre musicisti magnifici, e nonostante con me siano stati sempre gentili e generosi, mi sono sempre sentita in soggezione davanti a loro! Davvero, ho suonato diverse volte con Paul e Alan (meno con Nick, che a un certo punto è finito ai margini della scena) ed è sempre stata un’esperienza unica. Abbiamo approcci molto differenti sul piano strumentale, ma si è sempre stabilita una connessione dell’anima e una totale predisposizione all’ascolto.
Hai anche lavorato in parecchi gruppi al femminile. Ho sempre pensato che esista una sorta di estetica femminile all’improvvisazione, anche se non saprei definirla. Puoi darmi una mano a farlo?
Ho lavorato in quattro formazioni “all-female”: la band di Ivy Benson negli anni Settanta; negli Ottanta, la Lydia D’Ustebyn Orchestra, che era una sorta di pastiche femminista, le Guest Stars, più radicali, e la Vortex Foundation Big Band, che ho diretto per un po’… Attualmente non sono molto a favore dei gruppi di sole donne, anche se per me sono stati politicamente importanti negli anni Ottanta. Ho sempre pensato che altri Paesi – Germania, Olanda, Svizzera, Francia soprattutto – fossero più avanzati nella definizione di un’estetica femminile della musica improvvisata: figure come Irene Schweizer, Joëlle Léandre, Anne-Marie Roelofs… Penso comunque che le connessioni pan-europee siano state molto importanti per tutte noi. È interessante notare che quest’enfasi sull’essere donne e musiciste sia adesso molto presente, e in qualche modo da questa parte dell’oceano ci pare “roba vecchia”, con tutto ciò che abbiamo fatto nel campo a Londra, e in tutta Europa, trent’anni fa. Non riesco a definirlo meglio di così, ma quel tempo ha intagliato le nostre coscienze creando spazio per ogni tipo di approccio: politico, emotivo, intellettuale, artistico…
Quali sono i tuoi trombonisti preferiti nella storia del jazz, e quelli che ti hanno più influenzato? (mi vengono in mente nomi tanto diversi quanto J.J. Johnson e Roswell Rudd)…
Oh, sono una pletora: forse tutti!! Più profondamente di certo Roswell, Jimmy Knepper, JayJay, e fuori dal jazz Don Drummond (incredibilmente importante per me) e Wayne Henderson. Adoro anche Tricky Sam Nanton (e chi non lo ama?)…
 Lascia che ti racconti una storia. Nel 1980 invitai Chris McGregor, Radu Malfatti, Harry Miller e Louis Moholo a Roma, a suonare con la Big Band della radio. Il clima fra loro e alcuni componenti della Big Band non era proprio idilliaco. Questi ultimi ritenevano i primi cattivi lettori, sai, quel tipo di antagonismo. Suonarono anche due brani in settetto, dal repertorio di Spirits Rejoice di Moholo (Amaxesha Osizi e Wedding Hymn): l’organico consisteva dei quattro ospiti più un trombone, una tromba e un tenore della Big Band. Così si consumò la vendetta degli improvvisatori sui lettori: Louis & Co. entravano e uscivano dai temi e dal tempo con totale agio, mentre i musicisti italiani spesso si smarrivano in tanta libertà e le loro fronti si imperlavano di sudore. Esperienza interessante. Tu hai suonato sia con la Brotherhood che con Spirits Rejoice. Come avvengono quegli improvvisi cambi di clima? Segni? Gesti? Posture? O è semplicemente l’umore della musica che guida i passaggi da una situazione all’altra?
Lascia che ti racconti una storia. Nel 1980 invitai Chris McGregor, Radu Malfatti, Harry Miller e Louis Moholo a Roma, a suonare con la Big Band della radio. Il clima fra loro e alcuni componenti della Big Band non era proprio idilliaco. Questi ultimi ritenevano i primi cattivi lettori, sai, quel tipo di antagonismo. Suonarono anche due brani in settetto, dal repertorio di Spirits Rejoice di Moholo (Amaxesha Osizi e Wedding Hymn): l’organico consisteva dei quattro ospiti più un trombone, una tromba e un tenore della Big Band. Così si consumò la vendetta degli improvvisatori sui lettori: Louis & Co. entravano e uscivano dai temi e dal tempo con totale agio, mentre i musicisti italiani spesso si smarrivano in tanta libertà e le loro fronti si imperlavano di sudore. Esperienza interessante. Tu hai suonato sia con la Brotherhood che con Spirits Rejoice. Come avvengono quegli improvvisi cambi di clima? Segni? Gesti? Posture? O è semplicemente l’umore della musica che guida i passaggi da una situazione all’altra?
Nella mia esperienza personale non abbiamo mai prestabilito segnali o cenni di alcun tipo. È soprattutto la capacità di ascoltare, e la volontà di stare insieme, di rispondere a ciò che viene offerto. È sempre preferibile essere pronti a tutto: è così che diventa veramente eccitante.
Filippo Bianchi
(PAN, n.1/2015)



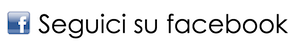






 Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.
Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.












 presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.
presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.