Aruán Ortiz: gagà, tumba francesa e avant-garde

Intervista. Il pianista e compositore di Santiago de Cuba da un decennio si muove con successo nel panorama jazzistico newyorkese. Il suo pianismo, seppur distaccandosi nettamente dagli schemi del jazz afrocubano, incorpora in forme inusitate alcuni elementi della tradizione folklorica cubano-haitiana. Nell’ultimo disco, “Hidden Voices”, approccia in modo ironico diversi stili cubani, ne frantuma i pattern ritmici e ricombina il tutto ispirandosi ai linguaggi dell’avanguardia internazionale.
L’intervista è stata pubblicata da Musica Jazz (giugno 2016), che ringraziamo per consentirne la diffusione su questo portale.
Partiamo con un tuo breve ritratto.
Mi chiamo Orlando Aruán Ortiz Vizcay, sono nato nel popoloso barrio Los Hoyos di Santiago de Cuba il 22 agosto 1973 e quando la gente all’estero mi chiede da dove provengo rispondo prima di tutto che sono di Santiago de Cuba e poi cubano. Sono super campanilista, ma il mio regionalismo è un modo per dire che sono orgoglioso delle mie origini e delle tradizioni santiagueras. Ora ho la residenza negli Usa e la cittadinanza spagnola. Ho cominciato a studiare musica classica all’età di sette anni con violino e viola nel conservatorio Esteban Salas della mia città; a nove studiai pianoforte complementare; a quindici, oltre a studiare, iniziai a suonare con gruppi di musica popolare; a diciotto, dopo essermi diplomato in viola, mi trasferii all’Avana per capire cosa succedeva musicalmente nella capitale.
Soffermiamoci un po’ a Santiago. Come molti santiagueros anche tu avrai qualche goccia di sangue afrohatiano derivato dall’insediamento di coloni francesi con i loro schiavi fuggiti da Hispaniola verso la fine del Diciottesimo secolo?
Sì, mia nonna paterna aveva lontane discendenze haitiane, ma fino all’inizio del Ventesimo secolo a Cuba non era ben visto chi diceva di avere origini afrohaitiane: c’era razzismo e allora si evitava di parlarne. Poi, con il passare del tempo, certe situazioni sono cambiate, ma le tradizioni sono rimaste e…
… e per fortuna, dico io: come El Cocoyé, la Conga o la Comparsa che sono alcuni dei protagonisti del rutilante carnevale santiaguero.
Esatto. Io mi sono nutrito di queste manifestazioni sociali e folkloriche e sono cresciuto proprio dove si è sviluppata la tradizione di canto e ballo chiamata El Cocoyé e a un isolato dalla famosa conga de Los Hoyos. Stiamo parlando di una zona operaia con molti discendenti di africani impiegati nei lavori della ferrovia. Altre entità importanti sono la conga di San Pedrito e i famosi focos culturales, una sorta di circoli culturali e musicali tra cui il Carabalì Isuama e quello dei tamburi del gruppo social-musicale della Tumba francesa.
Immerso in quell’ambiente di ritmi, tamburi e danze folkloriche perché scegliesti la strada della musica classica? Ricordi quando, come e cosa suonavi al tuo esordio sul palcoscenico?
Ero attratto dalla grande musica e quindi l’unico modo per conoscerla era il conservatorio e decisi in libertà assoluta perché in famiglia non c’erano tradizioni musicali. Il mio debutto fu a tredici anni suonando il pianoforte: assieme a un bassista co-fondammo un gruppetto del conservatorio e andavamo a suonare in altre scuole o in manifestazioni culturali. Il repertorio comprendeva brani scritti e arrangiati da noi più un corposo mix di pezzi di son e musica ballabile di orchestre famose di Santiago e della zona orientale di Cuba come Son 14, Tierra Caliente, Los Tainos, Típica Juventud, Ritmo Oriental e Original de Manzanillo.
 Santiago de Cuba vuol dire Trova con i pionieri Pepe Sanchez e Sindo Garay; Son con i leggendari Compay Segundo e Trio Matamoros oppure Harold Gramatges, importante compositore. Ma la seconda città cubana, contrariamente a L’Avana, Santa Clara o Camagüey, non ha mai espresso nessun jazzista, è così?
Santiago de Cuba vuol dire Trova con i pionieri Pepe Sanchez e Sindo Garay; Son con i leggendari Compay Segundo e Trio Matamoros oppure Harold Gramatges, importante compositore. Ma la seconda città cubana, contrariamente a L’Avana, Santa Clara o Camagüey, non ha mai espresso nessun jazzista, è così?
Effettivamente Santiago non ha una storia di jazz e approfitto però per dire che abbiamo una tradizione ricchissima nell’assimilare diversi stili e vi sono alcuni episodi, poco raccontati ma ben documentati, che in qualche modo ci legano alla musica nordamericana. Uno ad esempio risale alla guerrra cubano-ispano-nordamericana (la seconda guerra d’indipendenza contro l’impero coloniale spagnolo iniziata nel 1895- nda) quando nella battaglia della Loma de San Juan (roccaforte spagnola nelle vicinanze di Santiago de Cuba) del 1898 i soldati statunitensi e i patrioti cubani costrinsero gli spagnoli a ritirarsi verso la città di Santiago. Nei momenti in cui non si combatteva, ci furono dei soldati-musicisti afroamericani che intrecciarono rapporti con colleghi cubani e così quando i primi ritornarono in patria iniziarono a sviluppare, soprattutto a New Orleans, l’accentazione del quattro, tipico del cosiddetto tango (non quello argentino). Da questa accentazione scaturì un modo di suonare molto singolare che produsse motivi molto simili alla famosissima canzone La Paloma o al Latin Tinge di Jelly Roll Morton.
In due parole. puoi descrivere questa modalità?
Tecnicamente voleva dire suonare il pianoforte con la mano sinistra scandendo una specie di tumbao, uno specifico giro, e con la destra il blues. Questo innovativo contributo musicale influì poi armonicamente sul processo evolutivo della Trova, che viene dalla Serenata e sulle prime forme di Son. E’ chiaro, non era jazz, ma questa novità portò una certa tendenza alla libertà dentro vari stili e fu assimilata anche dai gloriosi artisti che hai citato. Il fenomeno prese poi maggior vigore grazie alla ferrovia che permise così al Son e ad altri generi santiagueri di arrivare all’Avana; quindi il treno ebbe un ruolo fondamentale nella diffusione della nostra musica popolare.
Parliamo invece di informazione jazzistica a Cuba. Nel Paese non esiste stampa jazzistica e Chucho Valdés mi disse che nella capitale circolava qualche copia di Down Beat e Jazz Hot. A Santiago invece come andavano le cose? E tu come hai scoperto questo linguaggio?
Io sono di un’altra generazione rispetto a Chucho ma noi santiagueri siamo sempre stati tagliati fuori da certe realtà e francamente non sapevo nulla di quelle testate. Negli anni del conservatorio appresi qualcosa del jazz cubano grazie a un mio amico bassista che aveva dischi di Gonzalo Rubalcaba, uno dei miei idoli, degli Irakere di Chucho Valdés ricordo “Tierra en Trance” e l’album registrato dal vivo che vinse un Grammy con Paquito D’Rivera suonando Mozart; poi di Emiliano Salvador, di Afrocuba, dove suonava l’ottimo Oriente Lopez, dei Fervet Opus, un gruppo eccellente di Camagüey in cui militava il pianista Gabriel Hernandez. Un paio di momenti fondamentali che mi avvicinarono al jazz li devo a mia nonna la quale ascoltava moltissimo la radio: tra un programma e l’altro ogni pomeriggio trasmettevano Night Streets dall’album di Chick Corea, “My Spanish Heart“, uno dei miei dischi preferiti di sempre, e quel brano aveva qualcosa di nuovo per me. Sto parlando del 1988 e ogni volta che sentivo quel brano cercavo di tirarne giù un pezzetto e alla fine lo imparai tutto. Inoltre verso le 23 ascoltavo La Esquina del Jazz, programma della radio cubana condotto da Miriam Ramos e lì scoprii l’esistenza di un altro Herbie Hancock rispetto al suono che avevo nella mente di quell’artista, e cioè quello di Rockit. Conobbi i pezzi di ” The Prisoner” e di “Inventions & Dimensions” ma senza sapere i titoli degli album perché non li dicevano e fu così che incominciai a conoscere il primo periodo di Hancock con la Blue Note e un nuovo tipo di jazz, almeno per me era nuovo. Un evento che contribuì poi ad appassionarmi ulteriormente fu l’incontro con il pianista Gabriel Hernandez dei Fervet Opus: la band trascorse due settimane a Santiago per concerti, conferenze, master class e fu la prima volta che vidi dal vivo un pianista di jazz o pensando che fosse tale perchè suonava ad un livello molto avanzato rispetto alle mie conoscenze. Da autodidatta quindi iniziai ad imitarlo, ma senza sapere niente di armonia jazz, di tecniche dell’improvvisazione, di fraseggio eccetera. Ma quando arrivai all’Avana per frequentare l’Istituto Superior de Arte (ISA), l’Università della musica, rimasi scioccato dall’impressionante livello musicale, professionale e tecnico dei ragazzi dell’ISA. Lì conobbi Gonzalo Rubalcaba, Ramon Valle (ora residente in Olanda) che suonava come Keith Jarrett e mi resi conto che se volevo diventare un vero pianista dovevo dedicarmi soltanto al pianoforte. Fu così che abbandonai per sempre le corde della viola per i tasti bianchi e neri.
Nel periodo avanero maturasti qualche esperienza jazzistica?
Sì, per qualche mese collaborai con il multistrumentista e cantante Bobby Carcassés, che un giorno mi disse: “muchacho, non sei ancora pronto e devi studiare di più”. Carcassés (vedi intervista su Speciale Latin, Musica Jazz) è un’istituzione del jazz cubano, ha svezzato moltissimi giovani e questo suo brusco suggerimento mi convinse a tornare, anche se con amarezza, a Santiago de Cuba per prepararmi in modo adeguato nella stessa scuola dove mi ero diplomato con la viola. Mi dedicai quindi al pianoforte classico perché volevo dominare lo strumento e questo obiettivo diventò la mia ossessione per alcuni anni: studiavo circa dieci ore al giorno, moltissima tecnica, esercizi di ogni tipo finchè giunse il momento che me ne andai all’estero.
Dove, perché e in che modo?
Tutto accadde nel 1996 grazie ad una iniziativa promossa da spagnoli che si chiamava La Isla de la Musica. Questo progetto culturale e discografico consisteva nel selezionare talenti in tutta l’Isola, da Pinar del Rio fino a Guantanamo, per rompere uno stereotipo e dimostrare al mondo che Cuba non era solamente salsa, timba e guaguancò. In ogni città facevano audizioni e quando arrivarono a Santiago mi fecero la proposta ma dissi che non ero interessato, poi dietro insistenza suonai e i dirigenti spagnoli rimasero tanto affascinati dal mio modo di suonare che mi prepararono subito un contratto di artista esclusivo per la loro etichetta. E così andai a Madrid per registrare il mio primo disco di piano solo: Impresión Tropical (Magic Music), album n.10 della collana La Isla de la Musica, una mia rivisitazione di pezzi di son, feeling, trova e altri generi cubani. Ora con sorpresa scopro che il cd è anche nel catalogo della discografica cubana Bis Music.
 Ti recasti in Spagna per registrare il disco ma poi, se ho ben capito, non sei rientrato a Cuba. Come sei riuscito a ottenere il visto dal Governo dell’Avana, che non li concedeva con tanta facilità?
Ti recasti in Spagna per registrare il disco ma poi, se ho ben capito, non sei rientrato a Cuba. Come sei riuscito a ottenere il visto dal Governo dell’Avana, che non li concedeva con tanta facilità?
Diciamola tutta: fui invitato da La Isla de La Musica ma nel frattempo avevo contattato, attraverso una fidanzata spagnola, il Conservatorio Profesional de Musica di Vila-Seca in Catalogna dove insegnava il maestro cubano Cecilio Tieles Ferrer, importante pianista, pedagogo, persona influente il quale mi aiutò moltissimo inviando una lettera al Ministero della Cultura dell’Avana spiegando che sarei stato suo alunno per alcuni anni e realmente andò così, ma fino a un certo punto. Infatti pensavo di dedicare tutta la mia carriera al piano classico, ma ero sempre più attratto dal jazz pur masticandolo poco. Mi comprai tutti i dischi di Keith Jarrett e cominciai a imitarlo, ma alla fine decisi di frequentare un corso di jazz e da lì iniziò il mio nuovo vero percorso.
Quindi incontrasti la strada del jazz in Spagna?
Mi iscrissi a una scuola di Barcellona, l’Aula de Musica Moderna y Jazz, dove ebbi la fortuna di scoprire il jazz attraverso Horacio Fumero, un importante musicista argentino, contrabbassista che suonò per circa vent’anni nel trio del bravissimo pianista cieco catalano Tete Montoliu, e in questo contesto collaborò con Freddie Hubbard, Johnny Griffin, Benny Golson, James Moody eccetera. Fumero (http://horaciofumero.com/web/?page_id=2) è stato fondamentale per la mia crescita jazzistica. Una volta assimilata bene la grammatica e la sintassi del jazz iniziai a suonare nel suo gruppo imparandomi quasi tutto il repertorio di Charlie Parker, Nat King Cole, Red Garland, Bud Powell, Wynton Kelly, John Lewis. Con Horacio mi si aprirono le porte del jazz a Barcellona, spesso ero al club Jamboree e per me era il massimo, come fosse la Carnegie Hall. La mia piccola carriera jazzistica in Barcellona durò fino al gennaio 2002 quando andai alla Berklee School di Boston dove studiai con Joanne Brackeen. Rimasi quattro mesi poi ritornai in Spagna perché avevo vinto un’altra borsa di studio e quando decisi di ripartire per gli Usa mi negarono il visto di studente e non so il perché. Così un po’ frustrato per via del permesso che non arrivava presi la via di Parigi e lì suonai con vari gruppi fino al momento dell’arrivo del sospirato visto per gli Stati Uniti dove mi trasferii definitivamente. Studiai privatamente con Hal Crook, trombonista, che mi insegnò improvvisazione avanzata e nozioni di musica creativa; poi presi lezioni di tecnica, strutture, composizione eccetera per tre anni da Charlie Banacos, un pianista che ha avuto allievi come Danilo Perez, Mike Sterns e Michael Brecker. A Boston passavo il tempo studiando moltissimo con questi due maestri e poi ogni tanto suonavo.
Immagino che quelle lezioni private fossero costose. Allora come riuscivi a far quadrare i conti?
Effettivamente è un aspetto che molti non si pongono, ma quello economico era un problema serio e per fronteggiare le varie spese guadagnavo qualcosa dando lezioni private di musica cubana, sul tumbao, la tradizione afrocubana; inoltre suonavo il pianoforte in una compagnia di balletto e facevo concerti con un quartetto di latin jazz assieme al batterista e band leader Francisco Mela. Successivamente me ne andai a New York.
E lì si può dire che è avvenuta la rottura con il latin jazz per intraprendere nuove direzioni?
Il mio sound si diresse verso l’avant-garde, un free vicino a The Fringe di George Garzone. Pubblicai il mio primo disco da leader negli Stati Uniti con il titolo “Aruán Ortiz Trio, vol.1” e con me c’erano il bassista Peter Slavov e il batterista Francisco Mela (2003). Dimentico spesso di dire una cosa importante: a Barcellona avevo conosciuto il sassofonista Antoine Roney, un ottimo musicista influenzato da Junior Cook, Pharoah Sanders e John Coltrane, con uno sviluppo stilistico molto personale ma non si è mai proiettato a dovere nell’ambiente rimanendo sempre sotto l’ala del fratello, il trombettista Wallace Roney. Quindi appena arrivato a New York contattai Antoine e lui mi raccomandò a suo fratello con il quale lavorai per circa sei anni. Ricordo che il mio primo concerto con Wallace fu senza prove né sound check: tre giorni prima del concerto mi mandò gli spartiti dei brani del suo ultimo disco “Prototype” e alcuni del disco precedente che imparai in tre giorni e tre notti senza dormire un minuto. Il debutto con il suo quintetto a Detroit andò alla grande e debbo dire che l’esperienza musicale con Wallace Roney è stata finora la mia più importante scuola jazzistica.
 Parliamo del tuo ultimo album. Come nasce e quali sono le ‘voci nascoste’ che ispirano questo nuovo progetto?
Parliamo del tuo ultimo album. Come nasce e quali sono le ‘voci nascoste’ che ispirano questo nuovo progetto?
L’idea di fare “Hidden Voices” mi venne nel 2013 e in particolare dopo la lettura del libro di Iannis Xenakis, “Musica e architettura”, titolo che mi affascinò per capire come funziona la musica o come puoi tradurre o integrare parametri o pattern che per alcuni aspetti potresti incontrare nell’architettura. Prendendo spunto da questo realizzai una serie di concerti con lo stesso titolo del volume e contemporaneamente ebbi la fortuna di suonare a Los Angeles con i musicisti che poi hanno partecipato a questo disco, cioè Eric Revis e Gerald Cleaver. “Hidden Voices” è il mio secondo album in trio e avrei preferito chiamarlo Aruán Ortíz Trio, vol. 2 ma Intakt Records decise diversamente. Sostanzialmente il lavoro è frutto di esperienze fatte con alcuni fondamentali pilastri per me, cioè quelli che mi hanno ispirato e che in gran parte vengono dal jazz d’avanguardia. Ne cito un paio: Muhal Richard Abrams, uno dei miei riferimenti più importanti degli ultimi anni con il quale si è sviluppato un ottimo rapporto e abbiamo suonato assieme. Poi ho lavorato poi con un batterista come Francisco Mora Catlett che suonò molto con Sun Ra Arkestra: assieme abbiamo realizzato tre dischi con il progetto Afro Horn, una trilogia che unisce free jazz, musiche di Sun Ra, improvvisazione e ritmi Yoruba interpretati da Roman Diaz, percussionista che a Cuba suonava con Yoruba Andabo. Afro Horn ha condiviso il palcoscenico con musicisti fantastici tra cui Oliver Lake, Bob Stewart, Marshall Allen e Steve Turre, ma non è mai riuscito a decollare come invece meriterebbe. Però mi piace continuare a lavorare con questo gruppo.
 Debbo dirti che “Hidden Voices” necessita di ripetuti ascolti prima di assimilare qualcosa dell’insieme del progetto e di scoprire che gli ingredienti cubani sono talmente camuffati da renderli di difficile riconoscibilità anche ai cultori del mondo afrolatin. Per esempio, Caribbean Vortex/Hidden Voices presenta ben due claveros, o suonatori di claves, fatto atipico nella tradizione cubana e per di più utilizzando in modo inedito, per non dire eterodosso, i basilari legnetti sonori cubani scandendo pattern insoliti.
Debbo dirti che “Hidden Voices” necessita di ripetuti ascolti prima di assimilare qualcosa dell’insieme del progetto e di scoprire che gli ingredienti cubani sono talmente camuffati da renderli di difficile riconoscibilità anche ai cultori del mondo afrolatin. Per esempio, Caribbean Vortex/Hidden Voices presenta ben due claveros, o suonatori di claves, fatto atipico nella tradizione cubana e per di più utilizzando in modo inedito, per non dire eterodosso, i basilari legnetti sonori cubani scandendo pattern insoliti.
Sono contento di rispondere a queste tue precise osservazioni. Intanto diciamo che i vortex sono movimenti circolari di differenti velocità che in un certo punto si toccano. Ci sono momenti in cui questi vortici si allineano come i pianeti e poi ognuno segue la propria rotazione. Da questo punto di vista io faccio utilizzare le quattro claves come un catà (idiofono della musica folklorica cubana percosso con bacchette -nda), però in modo più complicato e assolutamente insolito come dici: infatti i due claveros disegnano il ritmo gagà.
Ah, gagà, cubano ma di origine afro-haitiana.
Esatto, il gagà è molto popolare nella comunità cubano-haitiana di Santiago de Cuba. Tutto questo è frutto di ricerche sui ritmi afro-haitiani che esplorai per alcuni progetti precedenti come “Santiarican Blues Suite”, in cui mescolavo musica contemporanea e cicli ritmici della tumba francesa. In Caribbean Vortex/Hidden Voices, una percussione (claves) marca il ritmo gagà e l’altra cambia ma comunque sempre attorno a questo ritmo in una forma di vortice; diciamo che il gagà è l’anima, il centro e gli altri iniziano a disegnare diversi ritmi provenienti dal medesimo gagà. Infatti anche i miei tasti ritmano in questa direzione, prima sbriciolo e poi ricostruisco il pattern in modo personale: è una modalità che mi affascina e la pratico spessissimo nella mia musica. Dirò di più: il trio si muove in forma di vortice, il basso porta avanti la melodia ma l’ascoltatore non lo percepisce perché prima sente le claves (una acuta e una grave), poi il piano e la batteria. Quindi bisogna fare molta attenzione per capire che il basso guida la melodia. Questo è il concetto delle hidden voices, le voci nascoste di questo brano. Ma in generale per me le hidden voices sono le persone, soprattutto quelle rimaste nell’anonimato, che hanno influenzato la nostra vita, la nostra carriera con i loro suggerimenti, le loro idee, sono coloro che ci hanno appoggiato per la nostra crescita, voci occulte che stanno dentro di noi. Questo è un mio tributo a tutti costoro.
Le composizioni sono tutte a tua firma tranne “Open & Close/The Sphinx” di Ornette Coleman e “Skippy” di Thelonious Monk. C’è un motivo particolare che ti lega a loro?
Beh, questi sono due dei miei primi grandi maestri di riferimento. Di Ornette c’è quasi sempre un tema nei miei dischi; mi affascina la sua musica, il suo modo di comporre e questo amore per Coleman viene da quando studiavo con Joanne Brackeen che era sua amica e mi parlava molto della teoria musicale dell’armolodia, un sistema geniale che permette alla melodia di funzionare in qualsiasi contesto. In questo disco ho unito due suoi temi come un medley, nel primo volume ci infilai The Invisible.
E arriviamo a “Uno, dos y tres que paso mas chevere”: è la guaracha-rumba, famosissima, del compositore cubano Rafael Ortiz di Cienfuegos?
Il pezzo è quello ma l’autore non è mio parente. Ho rivisitato questa notissima canzone carnevalesca facendone una parodia, ovviamente per riconoscerla bisognerebbe dominare bene l’originale. In più gli ho fatto un trattamento speciale per renderla musica contemporanea e mi piace che la gente si metta a pensare se si tratta di quel motivo di musica ballabile o meno. Se l’ascoltatore fa questo ho raggiunto il mio obiettivo.
 Su quest’ultimo punto potremmo aprire un ampio dibattito ma ora non è possibile. Invece vorrei chiederti se la musica contemporanea è un altro di quei pilastri fondamentali che ispirano la tua creatività?
Su quest’ultimo punto potremmo aprire un ampio dibattito ma ora non è possibile. Invece vorrei chiederti se la musica contemporanea è un altro di quei pilastri fondamentali che ispirano la tua creatività?
Certo, sono attratto dalla musica contemporanea da concerto del XX secolo e da artisti come Schonberg, Boulez, Ravel, Stravinsky, Sostakovic, Varèse, Stockhausen, Bartok, Hindemith e Berio. A questo conglomerato di artisti aggiungerei rappresentanti di arti visive come Alberto Lescay, Manuel Mendive, maestri del cubismo come Picasso, Braque, Chagall, Juan Gris, adoro il pittore astrattista Julio Girona, un cubano che ha mostrato la sua cubanità attraverso altre influenze ricevute a Parigi, New York e in Messico; scrittori cubani come Alejo Carpentier, Rogelio Martinez Furé, Nicolas Guillen, Lezama Lima, ma mi piacciono anche Rafael Alberti, Thomas Mann, Umberto Eco (di cui ho tutti i suoi libri). Questo è un altro pilastro ancora che sta dentro la mia opera; tutte queste realtà alimentano il mio processo creativo. E già che parliamo di creatività non posso dimenticare oltre a Muhal Richard Abrams, Andrew Hill, Monk, Herbie Nichols, Paul Bley, Anthony Davis, Roscoe Mitchell, Andrew Cyrille. Insomma il movimento jazzistico d’avanguardia.
Hai chiamato in causa molti artisti e intellettuali cubani. Ma a Cuba la tua musica mi sembra poco presa in considerazione. Sei mai tornato nella tua terra a suonare ufficialmente?
E’ vero quello che dici ma questo è dovuto al fatto di non aver sviluppato una carriera a Cuba e quindi non mi conoscono. Non sono ancora andato al Jazz Plaza Festival dell’Avana, ma spero che prima o poi accada. Ho suonato una sera qualche pezzo con un gruppo che si esibiva al circolo Bertolt Brecht della capitale solo perché alcuni amici mi riconobbero tra il pubblico e mi spinsero a forza sul palco. Quando ritorno a Santiago passo all’Iris Jazz Club, un bellissimo locale per il jazz, finalmente, dove c’è un pianoforte a coda, e qui se capita mi lascio coinvolgere in descargas. Mio desiderio sarebbe invece di suonare al Festival del Caribe organizzato dalla Casa del Caribe, una realtà che frequentavo spesso quando vivevo a Santiago.
Con la promettente ripresa delle relazioni tra Cuba e Usa non hai pensato di ritornare a vivere a Santiago? Non hai nostalgia delle comparsas, del carnevale, del clima caraibico?
Non so, ho moglie e figli a New York, vivo bene lì quindi non ho fatto pensieri di questo tipo, ma aspettiamo di vedere in che direzione si muoverà concretamente la realtà cubana anche se devo ammettere che grossi cambiamenti sono in atto.
E nemmeno di spostarti in Florida, più vicina geograficamente, climaticamente e culturalmente a Cuba?
No, mi sono già abituato alla mentalità nordamericana, ho molti amici e mi piace l’ambiente newyorkese. Riguardo al clima più rigido oramai mi difendo benissimo con cappotti e giacconi.
Come definiresti il tuo pianismo jazz?
Preferirei dire che la mia musica è un insieme di generi che coabitano in modo egualitario, nessun stile predomina sugli altri.
Uno dei dischi che ti hanno fatto consumare la puntina del giradischi?
“Levitando” di Ramon Valle (PM records di Pablo Milanés), lo ascoltavo in continuazione quando vivevo a Cuba.
E del jazz italiano e dell’Italia che ne pensi?
Avete degli artisti fantastici e li conosco perché dal 2008 vengo in Italia almeno due volte all’anno. Inoltre visito spesso il vostro Paese anche perché mia moglie, che è di Boston, ha una zia che vive in Toscana da circa trent’anni.
Gian Franco Grilli



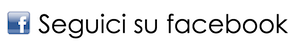






 Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.
Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.












 presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.
presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.