Michel Camilo. Segreti per fare musica senza confini

Il poderoso pianista dominicano ha pubblicato nei mesi scorsi uno dei più bei dischi della sua brillante carriera,«Essence», alla testa di una big band zeppa di grossi nomi e di giovani dal talento assicurato. Ne parliamo proprio con lui. Articolo/intervista di GIAN FRANCO GRILLI (pubblicato parzialmente su Musica Jazz, settembre 2019. Quello che segue è il testo completo).
Gian Franco Grilli
Michel Camilo. Segreti per fare musica senza confini
A due anni da Live in London il vulcanico pianista e compositore dominicano convoca in studio una nuova big band per incidere «Essence», il suo terzo album come bandleader di una formidabile compagine di talentuosi strumentisti (molti dei quali, giovani e totalmente sconosciuti in Italia).
Non è un cambio di direzione e né un abbandono del suo formato preferito, il trio, ma è soltanto una parentesi aperta da Michel Camilo per festeggiare in grande e alla grande, mezzo secolo di musica, quarant’anni dal suo sbarco definitivo a New York e la sua venticinquesima creatura come leader. E il risultato ottenuto è davvero entusiasmante e nostro avviso ha tutte le carte in regola per conquistarsi i favori delle giurie dei maggiori premi discografici internazionali.
Si farebbe prima a dire con chi non ha suonato Michel, ad esempio Chick Corea e Stefano Bollani tanto per citare due nomi noti. Ma le sue collaborazioni sono infinite, trasversali e di grandissimo prestigio e tanto per fare un primo elenco, escludendo il mondo della classica e sinfonica, diciamo Dizzy Gillespie, Paquito D’Rivera, George Benson, Tito Puente, Herbie Hancock, Tomatito, Mongo Santamaria, Joe Lovano, Arturo Sandoval, Juan Luis Guerra, Chucho Valdés, Carnegie Hall Jazz Band, Cachao, Hiromi, David Sánchez , Jon Faddis, George Wein, Jaco Pastorius, Gloria Estefan, Celia Cruz, Tania Maria, Katia e Marielle Labèque, Airto Moreira & Flora Purim, Anthony Jackson, Dave Weckl, Gonzalo Rubalcaba, Stanley Turrentine, Giovanni Hidalgo e tantissimi altri.
Sessantacinque anni, pianista, compositore, arrangiatore, eccellente concertista, direttore artistico, Michel Camilo è una persona di grandissima simpatia, un tipo allegro, divertente, solare, solidale e disponibilissimo come pochi altri a spiegare e ad arricchire la conversazione di particolari musicali e storici. Nel suo dna c’è il codice ritmico dei caraibici. Una volta sbarcato nella patria del jazz, era il 1979, ha conquistato letteralmente tutti i migliori jazzisti del mondo e nella sua quarantennale carriera newyorkese ha ottenuto Grammy, Latin Grammy e lauree honoris causa a raffica. Forse, per rimediare sensi di colpa nei confronti dei figli che se ne vanno dalla propria terra e toccano traguardi internazionali, governi e presidenti della Repubblica Dominicana gli hanno conferito le più importanti onorificenze che si riservano ai grandi della Patria. Ma sarebbe poi riduttivo pensare a Camilo solo come il migliore di sempre dei musicisti dominicani, perché si tratta di una delle figure più importanti del Latin Piano mondiale degli ultimi quarant’anni. E tra gli estimatori c’è anche il regista spagnolo Fernando Trueba che ritiene “Michel Camilo uno dei migliori musicisti in tutto, sia che si tratti di musica jazz, classica, musica latino-americana o musica da film. Ogni volta che lo vedo suonare, mi sento come se fossi testimone di un miracolo”. Altri paragonano le sue esibizioni ad allegre tempeste tropicali sugli ottantotto tasti bianchi e neri. Indubbiamente Michel trasforma le performance dal vivo in un trionfo di gioia, entusiasmo e allegria contagiosa riscuotendo dal pubblico interminabili ovazioni. Come è accaduto puntualmente anche a Umbria Jazz 2019 in piano solo sul repertorio «Live in London», il suo penultimo album.
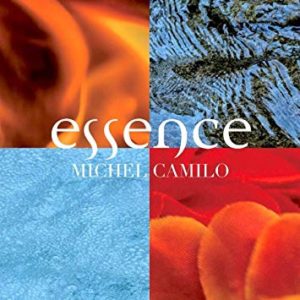 Noi partiamo invece dal tuo più recente progetto alla testa di una big band con la premiere del tour mondiale al North Sea Festival. Giusto?
Noi partiamo invece dal tuo più recente progetto alla testa di una big band con la premiere del tour mondiale al North Sea Festival. Giusto?
A Rotterdam, in effetti, c’è stata la premiere mondiale con la big band per presentare «Essence». Un grande concerto unendo la mia sezione ritmica (Ernesto Simpson, Kiki Rodriguez e Eliel Lazo) e la band di fiati olandese New Cool Collective dove suona una gran sassofonista come Benjamin Herman. Questo è avvenuto all’interno del mio tour europeo saltando qua e là non solo geograficamente, dalla Spagna all’Italia (ancora prima di Perugia ero stato in Puglia per paio di concerti con l’ Orchestra della Magna Grecia suonando il Divertimento for piano and orchestra di Leonard Bernstein e la celeberrima Rhapsody in Blue di Gershwin), dalla Germania all’Olanda, ma anche musicalmente, dal flamenco al jazz alla classica. In Germania sono stato premiato al Klavier-Festival Ruhr, uno dei festival più importanti di piano, una rassegna immensa (dura circa cinquanta giorni, un po’ meno del vostro Crossroads in Emilia Romagna, nel senso che si sposta da un luogo all’altro da Bochum a Essen eccetera) e lì suonano i più grandi pianisti del mondo. Poi nel cartellone del festival c’è una serie di concerti chiamata JazzLine. Tra l’altro sono di casa avendo partecipato a quel festival già quindici volte e come artista in residence, tenendo Master Class, workshop eccetera. Ma recentemente ero a Hong Kong con la Filarmonica locale presentando il mio Piano Concerto n.1.
Insomma hai sempre il trolley in mano! Dopo parliamo dei vari progetti. Intanto affrontiamo il cd edito con Resilience Music. La tua poetica si è sviluppata soprattutto nel formato «triangolare»», quindi a cosa si deve questa nuova compagine per «Essence», disco dove spicca il tuo pianismo potente nonostante un organico così vasto e ricco di talentuosi musicisti in gran parte sconosciuti?
E’ vero, molta della mia musica l’ho realizzata e vista come un triangolo e mi fa piacere che tu l’abbia evidenziato poiché mi consente di ricordare anche un album che si chiamava appunto «Triangulo». Ma non mi sono limitato soltanto al trio pur rimanendo il formato preferito. Inoltre bisogna aggiungere che ho sempre pensato al trio come a una mini-orchestra, quindi la big band era il modo migliore per celebrare tappe della mia professione e il mio lungo viaggio con un gruppo di vecchi e nuovi amici che arricchiscono la mia tavolozza sonora e come hai sottolineato il mio pianismo rimane inventivo, quello di sempre. Per «Essence» ho scelto delle composizioni che rappresentano cambiamenti nella mia carriera, il mio punto di vista e mostrano, almeno me lo auspico, come ho sviluppato il mio suono nel corso degli anni.
Ci sono anche brani che risalgono a produzioni di molti anni fa, tra cui uno, se non sbaglio, da «Why Not?».
Certo, Hello & Goodbye viene da lì, registrato nel lontano 1985, ma volevo rivisitare qualcosa con un nuovo sguardo, esplorare tutte le nuove idee scoperte in quei brani nel corso degli anni applicando una nuova concezione orchestrale. D’altra parte sono convinto che l’evoluzione passa attraverso il cambiamento di sé. Detto questo sono contentissimo del tuo apprezzamento e della efficacissima e tempestiva recensione di «Essence» su Musica Jazz, e questa francamente ci sarebbe poco da aggiungere se non ricordare che il numero «25», in questo mio progetto celebrativo ad ampio raggio, è polisemico, cioè ha più significati: è il mio venticinquesimo disco; sono trascorsi venticinque anni dal mio ultimo disco con una big band; celebro quarant’anni di vita newyorchese e di jazz. Cosa importante e che voglio ribadire, anche se tu l’hai evidenziato nella recensione, si tratta della terza opera in studio al comando di una big band, mentre le altre due produzioni erano del 1994: sia «One More Once» sia «Caribe», che fu registrato a Santo Domingo nello stesso periodo ma che io e Fernando Trueba decidemmo di pubblicare soltanto nel 2009.
E cosa puoi dirci della sorprendente contraltista Sharel Cassity finita sotto i riflettori con un paio di assoli davvero elettrizzanti? Poi parlaci anche degli altri nuovi acquisti.
Confesso che non la conoscevo!, Me l’ha presentata Michael Mossman, trombettista e arrangiatore del disco, suggerendomi di darle spazio per assoli perché la riteneva un’ottima solista. Così le affidai uno dei pezzi più difficili come On Fire ottenendo il fantastico risultato che hai potuto ascoltare, e soprattutto a fianco di autorevoli strumentisti, anche se a mio avviso non sufficientemente premiati dal pubblico internazionale, come Ralph Bowen, tenorsassofonista geniale e di cui molti non conoscono le mille attività. Ralph è un docente di altissimo livello della Rutgers University del New Jersey, è il decano degli insegnanti di improvvisazione, ha avuto molti allievi che sono diventati poi grandissimi musicisti tra cui David Sanchez. Bowen è di poche parole ma quando imbocca il sax mostra un talento portentoso. La big band è composta da musicisti eccellenti: tra i nuovi arrivi cito il bassista Ricky Rodriguez, il trombettista Kali Rodriguez Peña, il conguero Eliel Lazo e, a prescindere dall’età, il grande Diego Urcola, poi una potente sezione di tromboni con Michael Dease, Steve Davis e Jason Jackson.
Nell’album spicca l’omaggio ad alcuni maestri del ritmo afro-latino con i quali hai condiviso il palco. Tra questi i percussionisti Sammy Figueroa (cui ha dedicato And Sammy Walked In, brano di apertura) e Mongo Santamaria (Mongo’s Blues). Invece dietro Repercussions mi sembra ci sia un altro storico percussionista: è giusto?
Effettivamente io ho sempre lavorato con i più grandi maestri della percussione afro-cubana, afro-portoricana, brasiliana eccetera, artisti che ho apprezzato tantissimo. Nel caso di Mongo Santamaria, che poi diventò un mio grande amico essendo anche vicini di casa, lo ricordo perchè fu uno dei primi con il quale condivisi il palcoscenico del Blue Note. Lui era con il suo gruppo, io con il mio trio e finimmo a suonare assieme in una memorabile descarga. Perché tanta attenzione ai percussionisti? Avrai certamente notato che il mio modo di suonare il piano è percussivo, poiché al conservatorio ho studiato a fondo tutti gli strumenti a percussione. La mia ritmicità è legata anche all’aver lavorato con molte orchestre sinfoniche, il che richiedeva un grande suono e il modo per far emergere la mia parte. Comunque l’omaggio alla percussione è riuscito anche grazie a due talenti come il cubano Eliel Lazo e Cliff Almond, drummer incredibile che suona con me da tantissimi anni e che più di altri poteva immedesimarsi nel mio Repercussions dedicato a Art Blakey. Lazo non è solo un magnifico percussionista ma anche un abilissimo cantante e conoscitore dei rituali afro-cubani. Vive a Copenhagen, dove ha un suo gruppo e in duo abbiamo suonato al Blue Note di Milano, a Tokyo e in Germania; qualcosa di simile al bel progetto di Alfredito Rodriguez e Pedrito Martinez anche se noi non abbiamo registrato da soli. Lo convoco soprattutto per la big band e per il quartetto.
Puoi spiegarci meglio la ragione della tua dedica ad Art Blakey?
 Pochi sanno che all’inizio della mia esperienza newyorkese suonavo con il sestetto e anche in trio (con Anthony Jackson e Dave Weckl) in un club famoso che si chiamava Mikell’s. Be’, in quel locale si esibiva anche Art Blakey con i Jazz Messengers ed era il periodo in cui erano appena arrivati Wynton e Brandford Marsalis. Il Mikell’s, dove suonai anche con Paquito D’Rivera, non era un jazz club puro, ma presentava anche r&b e varie miscele sonore: infatti lì conobbi George Benson, Chaka Khan, David Sanborn. Insomma tutti passavano da quel club, che circa quindici anni fa è fallito. Ma una di quelle serate rimane tra le più importanti della mia vita: Art Blakey, cui piaceva scovare musicisti tra il pubblico presente ai suoi concerti, seppe una sera da un mio amico che suonavo e venne al mio tavolo per invitarmi a fare una jam session. Puoi immaginare la mia emozione! Addirittura Art mi fece scegliere il repertorio su cui suonare assieme a Woody Shaw, James Williams, Bennie Green, una serie di «tremendos musicazos», veri grandi, come diciamo noi caraibici.
Pochi sanno che all’inizio della mia esperienza newyorkese suonavo con il sestetto e anche in trio (con Anthony Jackson e Dave Weckl) in un club famoso che si chiamava Mikell’s. Be’, in quel locale si esibiva anche Art Blakey con i Jazz Messengers ed era il periodo in cui erano appena arrivati Wynton e Brandford Marsalis. Il Mikell’s, dove suonai anche con Paquito D’Rivera, non era un jazz club puro, ma presentava anche r&b e varie miscele sonore: infatti lì conobbi George Benson, Chaka Khan, David Sanborn. Insomma tutti passavano da quel club, che circa quindici anni fa è fallito. Ma una di quelle serate rimane tra le più importanti della mia vita: Art Blakey, cui piaceva scovare musicisti tra il pubblico presente ai suoi concerti, seppe una sera da un mio amico che suonavo e venne al mio tavolo per invitarmi a fare una jam session. Puoi immaginare la mia emozione! Addirittura Art mi fece scegliere il repertorio su cui suonare assieme a Woody Shaw, James Williams, Bennie Green, una serie di «tremendos musicazos», veri grandi, come diciamo noi caraibici.
Ma cercasti di latinizzare standard di jazz o di jazzificare brani caraibici? E il montuno?
Li portai sulla mia sponda poiché frequentando quel club anche come spettatore avevo già capito in altre occasioni che Blakey amava i ritmi latini: così quella sera infilai una paio di montuno alla mia energica maniera. Suonammo pezzi come Blue Bossa con ritmo moderatamente latin e brani un po’ più tosti. Art si entusiasmò al punto di innamorarsi della cáscara, un pattern ritmico molto utilizzato nella musica afro-cubana e che poi iniziò a incorporare nelle sue performance. Con Blakey ci incontrammo nuovamente al Village Gate (che oggi non c’è più) perché se lui non aveva impegni e si trovava a New York, quasi sempre il lunedì sera lo incontravi al Village Gate per il «Salsa Meets Jazz», che rappresentava un momento importante, di creatività musicale tra jazz e salsa-jazz.
Stiamo parlando del «Salsa Meets Jazz» degli anni Ottanta, e mi sembra giusto evidenziarlo, perché sempre al Village ma oltre dieci anni prima c’erano stati degli incontri (poi interrotti per ragioni economiche) simili dove spiccavano Tito Puente, Charlie Palmieri e altri.
Giusta precisazione: non ci avevo pensato ma la storia è quella. Comunque erano gli anni Ottanta e da poco mi ero stabilito a New York. Debbo dirti che ai concerti di «Salsa Meets Jazz » io ero invitato come solista di jazz e non di Latin, perché c’erano già gruppi di salsa-jazz con nomi fissi tipo Eddie Palmieri, Conjunto Libre, Papo Lucca e si facevano grandi descargas di Latin jazz.
A proposito di Tito Puente e di grandi percussionisti con cui hai lavorato, vorrei chiederti se sei in contatto con Giovanni Hidalgo la cui attività purtroppo è stata in qualche modo ridotta per le conseguenze dovute all’amputazione di due dita.
Con Giovanni abbiamo fatto performances indimenticabili, lui è davvero un genio del ritmo. Purtroppo soffre di diabete da tempo ma per molti anni si è trascurato, tanto che durante il tour con Volcán di Gonzalo Rubalcaba ha avuto problemi molto seri ad alcune dita della mano destra, ferite sanguinanti per difficoltà di circolazione. Le dita stavano andando in cancrena e so che a Portorico hanno fatto tutto il possibile per salvargliele, ma era troppo tardi. Tra l’altro recentemente ho parlato proprio di lui con Zakir Hussain, il quale mi ha riferito che adesso Giovanni suona con le bacchette.
Sì, già a Ferrara qualche anno fa, e proprio con Volcán, tentò di ritmare con le bacchette (con sorpresa inspiegabile, allora, di congueros presenti in teatro), ma a mio modestissimo avviso non può funzionare perché mani e polpastrelli hanno segreti e possibilità inacessibili alle bacchette su pelli di congas o bongos. Forse dovrebbe trasferire tutto il suo sapere tecnico e creativo sui timbales.
E’ condivisibilissimo il tuo pensiero e ho pensato anch’io a quell’alternativa perché Hidalgo è anche un grandissimo timbalero. Hai fatto bene a ricordarmi di questa vicenda e appena posso parlerò proprio con Giovanni suggerendogli di concentrarsi soprattutto sui timbales. Intanto speriamo tutti che la malattia venga tenuta sotto controllo, è un momento difficile. Pensa che una vicenda così amara, sempre causata dal diabete, è toccata anche al contrabbassista Andy González cui hanno dovuto amputare una gamba: per questo suona molto poco oltre ad aver perso di recente il fratello Jerry, con il quale aveva fondato il meraviglioso gruppo Fort Apache Band incidendo dei dischi molto belli. Loro sono stati dei pionieri nel fondere il jazz con musiche afro-cubane e afro-portoricane.
Non c’è dubbio, fantastici nel mescolare bebop, hard bop e ritmiche afro-cubane. Inoltre dei grandi ammiratori e fanatici di Monk, tanto che Jerry González affermò più volte che «Monk è il più grande rumbero del jazz».
Sì, sì… Verissimo, Monk influenzò molto il lavoro dei fratelli González, e questo si percepiva nella loro musica.
Poc’anzi raccontando di Blakey ha citato il montuno. Da tempo per fare maggiore chiarezza ai lettori su argomenti che spesso suscitano confusione, stiamo raccogliendo opinioni da musicisti soprattutto Latin, e allora ti chiedo: per un pianista dire tumbao o montuno è la stessa cosa o ci sono differenze? Inoltre quali sono le basi del montuno, che tra l’altro discende dalla chitarra tres?
Infatti per molti è la stessa cosa, ma per me il tumbao è espressione del contrabbasso e la sincope che porta la riconosco come tumbao; il montuno è il disegno del pianoforte, quella parte ritmico-armonica ripetuta, quel modo di arpeggiare con il pianoforte che infatti viene dal tres. Normalmente il montuno è composto da tre note, ma ultimamente trovi montuno di quattro note oppure montuno di accordi, invenzione questa – è bene ricordarlo – dei fratelli Eddie e Charlie Palmieri, due musicisti che un tempo furono l’avanguardia del salsa-jazz. Debbo ammettere di essere stato un po’ influenzato da loro su questo versante. Ma se diciamo tumbao dovremmo parlare anche di timba.
 Beh, la timba cubana è un altro capitolo: chiariamo ai nostri lettori che si tratta di uno stile esploso durante il periodo especial di Cuba (anni Novanta), musica ballabile ma anche da ascoltare, una fusione di son e rumba afro-cubana intrecciata a elementi di black music nordamericana, una miscela di jazz, funk, hip hop, salsa e dai testi abbastanza duri, ossia canzoni che parlano di razzismo, dollari, sesso e critiche al potere e in alcuni casi espressi con slang giovanili cubani scaturiti dai barrios più degradati, più neri. E ha perso un po’ di popolarità con l’arrivo del reggaeton.
Beh, la timba cubana è un altro capitolo: chiariamo ai nostri lettori che si tratta di uno stile esploso durante il periodo especial di Cuba (anni Novanta), musica ballabile ma anche da ascoltare, una fusione di son e rumba afro-cubana intrecciata a elementi di black music nordamericana, una miscela di jazz, funk, hip hop, salsa e dai testi abbastanza duri, ossia canzoni che parlano di razzismo, dollari, sesso e critiche al potere e in alcuni casi espressi con slang giovanili cubani scaturiti dai barrios più degradati, più neri. E ha perso un po’ di popolarità con l’arrivo del reggaeton.
Mi piace il quadro sintetico che hai fatto, e per quanto mi riguarda apprezzo la timba perché è una bella evoluzione moderna delle musica afro-cubana. Io entro ed esco da quel mondo acquisito attraverso gli artisti cubani che sono transitati nei miei gruppi e che mettevano timba a loro piacimento nelle nostre performances. Poi si sa bene che ho avuto con me batteristi come Horacio “El Negro” Hernandez e Dafnis Prieto, e bassisti come il compianto Charles Flores. Adesso ho il portoricano Ricky Rodriguez che è grande conoscitore di timba. Secondo me la timba continua la sua evoluzione a un altro livello all’interno del latin jazz e lo dico pensando a progetti di Miguel Zenón, David Sánchez o anche di Danilo Pérez.
In una delle nostre conversazioni mi hai detto che per te non esistono confini musicali, e che riesci sempre a coniugare con il jazz qualsiasi tipo di musica. In questa fase oltre a classica, jazz e Latin, ti stai cimentando con altro?
Con la musica spagnola, con il flamenco. Poco fa ero a Malaga con Tomatito, musicista con cui ho inciso tre album. Vent’anni fa realizzammo «Spain», poi «Spain Again» e «Spain Forever» altro Grammy. Abbiamo ottenuto grandi soddisfazioni e riconoscimenti in tutto il mondo fondendo jazz, flamenco e altri accenti Latin. Il repertorio di quest’ultimo concerto era ispirato soprattutto a «Spain Forever», ma ho inserito un omaggio anche a Ennio Morricone con Nuovo Cinema Paradiso. Insomma indaghiamo l’anima latina.
Ecco, a luglio Musica Jazz parlava proprio di anima latina a proposito del nuovo disco di Chick Corea con la Spanish Heart Band, «Antidote», dove il flamenco ha una parte significativa. So che tornando a Santo Domingo dal tuo primo viaggio newyorkese. portasti casa dei dischi di un pianista che a quei tempi ti era sconosciuto, ovvero Chick Corea. Vuoi farci un breve riassunto di quel viaggio?
Claro, e con piacere. Tutta colpa di Gordon Gottlieb, il percussionista di Leonard Bernstein, che nel 1974 mi ospitò nel suo appartamento newyorchese e mi fece scoprire l’ambiente musicale di New York, il Village Vanguard e altri locali. Prima di ritornare nella mia terra andai con Gordon a comprare dei dischi: lui mi suggerì «Maiden Voyage» di Herbie Hancock e «Return To Forever» di Chick Corea, che io non avevo mai sentito nominare in quanto le mie conoscenze arrivavano a McCoy Tyner. A Santo Domingo cominciai così a lavorare su alcuni brani di quei dischi e organizzai il mio primo grande concerto in un teatro della capitale. Ammetto che all’inizio Chick mi influenzò abbastanza, come del resto anche Herbie Hancock, con il quale poi durante la mia carriera ho fatto jam sessions assieme in Giappone assieme all’Orquesta de La Luz.
Ah, non hai mai suonato con Corea?
Strano ma vero! Ho avuto la fortuna di conoscerlo, siamo amici e nei festival ci incontriamo spesso, con me è sempre molto cordiale. Lo scorso anno al festival di Saint Mortiz con Béla Fleck e al termine del concerto mi ha chiamato nel camerino per dirmi che era entusiasta della mia versione con Tomatito del suo pezzo Armando’s Rhumba. E visto che lì c’era una tastiera iniziò a mostrarmi la sincope speciale e il significativo aspetto che avevamo dato alla sua rumba, che gli era piaciuta così tanto da fargli incorporare i nostri accenti nel suo arrangiamento originale. Mi auguro proprio di poter far qualcosa assieme a lui.
Stiamo ancora un po’ in Andalusia, patria del flamenco. Non si è parlato tanto nelle tue interviste di un vecchio progetto con il gruppo Ketama, un mix di flamenco e rock pop che riscosse un grande successo. Ricordo bene?
Sì, e grazie per ricordarmelo. Ruotò tutto attorno al disco «Pa’ Gente con Alma» album che si trasformò in un hit di nuevo flamenco, poiché Ketama era un gruppo diventato noto mescolando ritmi latini e flamenco e sold out negli stadi e nei grandi festival. I fratelli Antonio e Josè Carmona, leader della band, erano rimasti tanto affascinati dal mio primo disco con big band, «One More Once» e così mi chiesero di co-produrre un disco in bilico tra latin e flamenco. In quel momento io stavo scrivendo una colonna sonora per il film spagnolo «Los peores años de nuestra vida» del grande regista di commedie Emilio Martínez Lazaro e alla fine lo convinsi di concludere la pellicola con un brano del disco che stavo producendo appunto con i Ketama. In più lui realizzò un video musicale ai Ketama che spopolò. Dopo facemmo una grande tournée negli stadi spagnoli creando una All Stars Band per sostenere le voci dei Ketama con dei miei arrangiamenti: in quell’ensemble c’erano Giovanni Hidalgo, Arturo Sandoval, Paquito D’Rivera, Ignacio Berroa eccetera, insomma una formidabile orchestra. Lo spettacolo era diviso in un due set: una parte era di latin jazz e la seconda parte con i Ketama di Antonio, Josemi e Juan Carmona. Dopo quel progetto il gruppo si sfaldò, ognuno intraprese un proprio cammino e quest’anno hanno deciso di riunirsi per concerti e sono di nuovo in auge. Comunque quella fu un’esperienza grandiosa, meravigliosa.
Qual è il segreto per andare avanti e indietro, in continuazione e con successo, tra i generi musicali dal Latin al jazz, dal flamenco alla classica? Sei un instancabile viaggiatore, in tutti i sensi, sempre in movimento: in un anno quanto tempo trascorri all’estero?
Guarda, non saprei risponderti. Certo è che tutto questo andirivieni mi mantiene fresco con la mente, mi rinnova i neuroni per continuare a crescere. Praticamente sono in tour per nove mesi all’anno, ma ricordo quello che mi disse una volta un mio grande amico al festival pianistico di Monaco di Baviera: «Ascoltami: il momento di suonare così e di dare il massimo è adesso, tira avanti il più possibile perché quando arriverai alla mia età dovrai fare tutto con più cautela». Questo mio amico era Oscar Peterson! Ho sempre in mente quella frase, che ritengo contenga in parte il segreto del mio agire costante, di fare, lanciare nuove sfide, cercar di non vivere sugli allori di traguardi raggiunti ma di buttarsi sempre in nuovi progetti. Tutto questo sembra mantenermi in salute.
Possiamo dire che sei agevolato dal fatto di non avere figli e quindi più libero di viaggiare con tua moglie, che è anche il tuo manager?
Certamente, ma questa è solo una parte della verità. L’altra è una questione genetica: mio padre ha centotré anni e mia madre ne ha novantacinque, entrambi lucidissimi e con molta vitalità. Quindi spero di avere ancora molto tempo davanti per fare musica; d’altra parte tu prima mi parlavi di Compay Segundo e di Candido Camero, ma io ti ricordo che anche Arthur Rubinstein ha suonato fino a circa novant’anni. Io sono un ottimista, inoltre penso che noi latinos abbiamo il vantaggio di essere persone allegre e divertenti, e l’allegria ti mantiene giovane.
 A proposito di persone allegre, chiamo in causa Paquito D’Rivera, un jodedor tremendo, (divertente e burlone), che nel suo libro “Ser o no Ser, !Esa es la jodienda! ti copre di elogi e ti mette assieme a Felix Varela, Desi Arnaz, Daniel Barenboim tra le figure di cultura ispanica di tutti i tempi che hanno fornito un enorme contributo alla società nordamericana e affermando che “Michel Camilo è l’unico musicista di mia conoscenza che ha disegnato un inimitabile tipo di jazz latino, con un timbro particolarissimo…e dovrebbero concedergli il regno di una isola nei Caraibi e con la musicale nazionale firmata da lui”. Enorme stima, no?
A proposito di persone allegre, chiamo in causa Paquito D’Rivera, un jodedor tremendo, (divertente e burlone), che nel suo libro “Ser o no Ser, !Esa es la jodienda! ti copre di elogi e ti mette assieme a Felix Varela, Desi Arnaz, Daniel Barenboim tra le figure di cultura ispanica di tutti i tempi che hanno fornito un enorme contributo alla società nordamericana e affermando che “Michel Camilo è l’unico musicista di mia conoscenza che ha disegnato un inimitabile tipo di jazz latino, con un timbro particolarissimo…e dovrebbero concedergli il regno di una isola nei Caraibi e con la musicale nazionale firmata da lui”. Enorme stima, no?
Davvero? No lo sapevo. É un grande elogio riceverlo da un musicista incredibile, meraviglioso e anche un bandleader fantastico: quando suonavamo nel suo quintetto lo chiamavamo “la escuelita” perché tutti noi, cioè io, Claudio Roditi, Portinho, Lincoln Goines, Sergio Brandão, imparavamo moltissimo al suo fianco.
Ma era un interscambio poiché Paquito sostiene di aver appreso da te moltissime cose della musica venezuelana e di Aldemaro Romero, musicista poco conosciuto al pubblico italiano.
E’ vero e tutto perché nella Repubblica Dominicana la “onda nueva” di Aldemaro era molto popolare e così imparai queste combinazioni moderne di joropo, jazz e altri ritmi folklorici del Venezuela, si suonava moltissimo con questa modalità. Quando poi Paquito mi disse che era affascinato da quel mix gli dissi che era tutto molto facile e incominciammo a registrare qualche pezzo con il clarino, in stile joropo era il pezzo Seresta di Howard Levy, un brano che lui portò nel repertorio della Dizzy Gillespie & The United Orchestra. Inoltre ti racconto un altro aneddoto che ti dà la misura di Paquito: stavamo esibendoci in un jazz club di New York e Carmen McRae, che era tra il pubblico, venne invitata a cantare da Paquito e su due piedi mi disse molto semplicemente: “Michel, nel mio gruppo io non sono geloso dei miei musicisti, tu non devi preoccuparti per me come leader, se ti applaudano più di me e a scena aperta, fregatene, suona senza paura, vai avanti”. Que te parece? Che ne pensi? È molto bello e raro che un bandleader ti dica questo e non ti imponga solo di accompagnarlo, ma ti lascia la massima libertà senza timore di rubargli la scena, di fare la prima donna nello show. Paquito è un tipo molto generoso, con noi era molto aperto ad accogliere i suggerimenti dei suoi musicisti e tutte queste esperienze mi hanno aiutato a formarmi anche come leader. Con il nuovo disco ho messo in pratica questi apprendimenti con dei grandi solisti perché è importante condividere la musica e non pensare che il progetto è di uno e del bandleader. Sono felicissimo di «Essence» perché tutti i musicisti hanno dato il meglio di sé e i giorni delle registrazioni si respirava allegria e entusiasmo, e questo spirito di collaborazione e stima tra di noi ha reso questo album molto speciale.
Ma con Paquito non è finita qui, perché, chiamando in causa Jelly Roll Morton e l’importanza del “colore spagnolo” nella creazione del jazz, scrive che “Manuel Perez, Fats Navarro, Alberto Socarrás, Tito Puente, Chucho Valdés, Tom Jobim, Luis Bonfà, Astor Piazzolla, Lalo Schifrin e Michel Camilo sono stati di cruciale importanza in ogni periodo della storia del jazz”. Insomma mica male no?
Allora a questo punto, dovrò comprare questo libro. Paquito, comunque al di là di simpatia ed elogi forse esagerati, è una persona eccezionale prima di essere il sassofonista strepitoso che sappiamo, lui ha contribuito davvero e più di altri allo sviluppo del jazz latino e non c’è ombra di dubbio di essere stato finora il miglior sassofonista cubano di tutta la storia. Nell’epoca del quintetto con Paquito, e a proposito del suo amore per le altre musiche latinoamericane con in testa la musica brasiliana, accadde che Tania Maria, gran cantante e pianista, realizzava delle soirée a casa sua riunendo moltissimi musicisti e una notte incontrai Tom Jobim e Deodato. A volte ci capitava anche Airto Moreira, notti meravigliose di musica e di noi giovani artisti che stavamo crescendo.
Tra le molteplici idee e attività non hai ancora pensato a una autobiografia?
In effetti ci sarebbero tante storie, tanti aneddoti e cose interessanti da raccontare con momenti magnifici e preziosi che a volte escono solo in interviste come questa. Ricordo, per esempio, un concerto speciale di tutte stelle a New York con Jaco Pastorius e una band da sogno: c’erano Paquito, Airto Moreira alla batteria, Tooth Thielemans, Randy Brecker, Flora Purim e altri. Suonavamo composizioni di Jaco. Credo che il tutto sia stato anche registrato, il produttore era uruguayano ma non ho mai visto nulla di quella notte meravigliosa.
Tutto ciò, forse, non sarebbe successo senza lo sbarco definitivo a New York quarant’anni fa per suonare jazz. Ma quando e come scopristi l’amore per la musica afroamericana?
Credo che tu abbia profondamente ragione. L’amore per il jazz: stavo studiando il pianoforte classico quando fui folgorato da Art Tatum su Tea for Two, una interpretazione superlativa, impressionante, con un controllo assoluto e armonie complicatissime. Per me era un gran virtuoso, improvvisava stupendamente e scoprii che quello era jazz: avevo quattordici anni, vivevo nella Repubblica Dominicana. Ascoltai successivamente tanti altri brani di Tatum e mi innamorai così del jazz a cui poi mi avvicinai più concretamente a sedici anni attraverso la Berklee di Boston, ma da casa mia con un corso per corrispondenza studiando teoria, arrangiamento, armonia e improvvisazione jazz.
La stessa accademia che poi ti ha conferito il Dottorato Honoris Causa. Una storia abbastanza curiosa, non credi?
Lo è davvero e ti dirò che tra i tanti riconoscimenti ricevuti da prestigiose università, città e istituzioni governative, onorificenze della mio Paese, il dottorato della Berklee è certamente il riconoscimento preferito, e di cui mi vanto. Oltretutto è divertente questa storia che racconto spesso ma la ripeto volentieri: alcuni anni fa seppi dal grande Gary Burton che anche lui aveva fatto lo stesso corso per corrispondenza. Ma la cosa ancora più curiosa fu appunto quando nel 2000 lo stesso Gary mi conferì il dottorato invitandomi a tenere delle Master Class al Berkley. La mia prima visita al Berklee di Boston la devo però all’invito del vibrafonista Victor Mendoza, che era stato allievo di Burton, per tenere un concerto agli studenti. Un grande onore fu poi ricevere il Dottorato Honoris Causa, a San Juan di fronte a quattromila persone nello scenario dell’Heineken Jazz festival di Portorico, la commissione aveva deciso quella come sede per la consegna. Un riconoscimento della più prestigiosa accademia di jazz esistente in quel momento significava e significa moltissimo e soprattutto negli Stati Uniti nel campo della musica che io amo.
Insomma gli Stati Uniti nel bene e nel male hanno incrociato la tua vita e anche quella di tanti dominicani. Infatti ricordiamo che ci furono anche momenti duri da digerire quando i marines agivano come guardiani nei Caraibi e anche la Repubblica Dominicana ha pagato il suo prezzo.
Questa è storia e a tal proposito ti racconto un aneddoto che è legato poi anche alla mia vicenda musicale personale. Da ragazzo a Santo Domingo avevo un trio che una volta la settimana suonava nel club La Carreta, di fianco alla Cattedrale e arrivai a suonarci grazie a un nordamericano che prestava servizio nel Corpo di Pace degli Stati Uniti nella Repubblica Dominicana e costui amava come un loco, un pazzo, la musica di Miles Davis. Quando seppe che io suonavo un po’ di jazz mi presentò ai proprietari di quel locale, che era un ritrovo di poeti, pittori e intellettuali. Ma alle nostre spalle c’era chi criticava la mia scelta di suonare jazz perché nel Paese esisteva in quel momento un sentimento anti-nordamericano dopo l’invasione dei Marines del 1965. Secondo loro avrei dovuto suonare musica latina ma a me piaceva improvvisare e suonare jazz e ho tirato dritto per la mia strada. Qui ho ricevuto tantissimo, sono stato un musicista dominicano fortunato e quindi mi è sembrato giusto restituire un po’ della mia fortuna, istituendo delle borse di studio per giovani strumentisti della Repubblica Dominicana.
Ma come avviene e chi cura nel dettaglio questo aspetto? Torni spesso nella Repubblica Dominicana e nel tuo villaggio di Ojo de Agua, Salcedo dove sei nato?
Esatto, sono cresciuto lì dal 1954, anno della mia nascita, ma raramente ci vado perché quando rientro in Patria mi fermo a Santo Domingo dai miei genitori anziani. Parlando delle borse di studio, esiste una commissione e un gruppo di esperti che seguono tutto il percorso. Noi diamo un grande aiuto economico e culturale a tutti gli studenti e questo è una speranza per le nuove generazioni a proseguire il nostro cammino preparandosi bene nel campo musicale, jazzistico o meno. Si è formato un grande livello di giovani musicisti nel conservatorio di Santo Domingo, ogni quattro anni facciamo gli esami per assegnare le borse e collaboriamo con chi promuove molto il jazz da quelle parti. Un punto di riferimento importante è Javier Vargas, chitarrista, docente del Conservatorio di Santo Domingo e direttore di una Big band jazzistica, una persona che merita tutto il nostro appoggio.
Prima di girare pagina e per fare chiarezza su tante “leggerezze” che circolano (ne ho letto una non molto tempo fa su un quotidiano importantissimo dove un noto cantante-pianista italiano, trentottenne avrebbe collaborato anche con Duke Ellington!), vorrei sapere se è vero, secondo quanto pubblicato su alcuni mezzi, che hai duettato con Stefano Bollani. Inoltre, qual è la tua opinione del jazz italiano.
Conosco Bollani ma non ho fatto duetti con Stefano Bollani, invece ho duettato con Danilo Rea a UmbriaJazz Winter 2011 di Orvieto, al Teatro Mancinelli, un concerto meraviglioso, suonammo molto bene assieme e tu lo puoi confermare come presente al concerto.
Del jazz italiano posso dirti che mi piace molto Paolo Fresu, ma vi sono altri musicisti bravissimi, uno per tutti Enrico Pierannunzi, pianista molto interessante. In particolare ci terrei ad evidenziare un ragazzo giovane che conobbi la prima volta a Boston quando studiava al Berklee College, e non so se lo conosci: è Marco Pacassoni, un bravissimo vibrafonista, grande talento e assieme abbiamo inciso Michel, un brano di sua composizione che mi ha dedicato. Abbiamo fatto anche un concerto in duo in un festival jazz di Ancona sullo stile più o meno Chick Corea-Gary Burton. Comunque sono contento di vedere che Marco sta riscuotendo consensi a livello internazionale e quando posso cerco di segnalarlo ad alcuni direttori di festival, ad esempio di Lugano, dove poi ha suonato, ora è appena tornato dal Giappone, insomma si sta muovendo benissimo e, forse, è più conosciuto all’estero che in Italia ma sono certo che farà strada, avrà un futuro per realizzare i suoi sogni.
Parliamo di sogni: ne hai qualcuno cui tieni in particolar modo?
Per la verità il mio grande sogno, adesso, sarebbe di poter registrare gli altri due miei concerti per pianoforte, il secondo e il terzo che ho scritto da tempo. Il Concerto n.3 è per trio jazz e orchestra sinfonica e qualche spezzone della prima assoluta si dovrebbe trovare su youtube L’ho scritto su commissione della Detroit Symphony Orchestra Sinfonica e del suo direttore Leonard Slatkin. Il Concerto n.2 «Tenerife» è molto più classico e mostra l’altro mio versante, quello sinfonico. Mi sono ispirato a Bartok, Prokofiev e Stravinskij e l’ho scritto su incarico dell’Auditorium e dell’Orquesta Sinfónica di Tenerife, la città delle Canarie che frequento spesso.
 Ma noto che hai un legame stretto con la terra spagnola dove peraltro torni spesso: è un omaggio a una parte delle tue origini famigliari?
Ma noto che hai un legame stretto con la terra spagnola dove peraltro torni spesso: è un omaggio a una parte delle tue origini famigliari?
Alcuni dei miei antenati venivano da lì, ma questo incarico è scaturito dal fatto che andavo molto spesso alle Canarie e a Tenerife. Inoltre quel luogo è importante perché lì c’erano le origini dei nonni di Ernesto Lecuona il quale trascorse poi lì gli ultimi giorni della sua vita.
Scusami se ti interrompo, ma a chi è curioso di storia diciamo che Ernesto Lecuona morì a Santa Cruz de Tenerife (1963) e nonostante la sua volontà di essere sepolto a Cuba i suoi famigliari residenti negli Stati Uniti disobbedirono e trasportarono le sue spoglie nel cimitero Weschester di New York.
Una parte di quella vicenda non la conoscevo ma… tornando a noi dicevo che in quell’Auditoirum di Calatrava io ho suonato di tutto e con ogni formato, piano solo, trio, quartetto, in duo con Tomatito , molte volte con la Sinfonica.
Cosa dici quando Fernando Trueba (regista di Calle 54) ti paragona al leggendario cubano sia dal punto di vista melodico che per la potenza della mano sinistra?
Beh, tutti siamo stati influenzati dalla mano sinistra di Ernesto Lecuona con una tecnica davvero portentosa. La leggenda narra che suonava molto Chopin, Listzt molta musica romantica virtuosa, classica e su questo punto non dobbiamo mai dimenticare che Listz e Chopin vissero a Parigi e la scuola che seminarono fu molto importante. Discepoli come Karol Mikuli, poi Paderewsky e insegnarono a grandi maestri che poi si trasferirono nel Caribe.
E questa è stata una benedizione per il Caribe perché la tecnica di piano caraibica viene direttamente da Chopin e Listzt e senza quelle influenze la poderosa mano sinistra di Ernesto Lecuona non sarebbe esistita. Lecuona poi trascorse molto tempo a Parigi e si racconta che la pianista Nadia Boulanger, che fu maestra di Piazzolla, di Gershwin e di tanti altri , essendo una sorta di guru musicale, gli disse: “Ernesto, perché non riprendi le tue radici popolari, il folklore, nella tua musica e sembra che lì decise di adattare le sonorità dei tamburi afrocubani alla tastiera e ovviamente con la mano sinistra. Ma era stato influenzato anche da Saumell e Cervantes; ma da quelle parti c’era anche Louis Moreau Gottschalk. Comunque Lecuona è stato importantissimo, pianista, compositore, promotore, scriveva anche moltissima musica per film, compose molte zarzuelas , musiche per teatro, canzoni e famose le sue danze afrocubane.
Per completezza aggiungo che nel suo catalogo delle opere appaiono ben cinquantasei stili differenti e tra i tanti racconti e aneddoti sul cubano ricordo di averne letto uno in particolare che mi colpì: George Gershwin, presente a un concerto di Lecuona a Parigi si avvicinò al pianista cubano mettendogli sul leggio la partitura di Rhapsody in Blue e Lecuona che non l’aveva mai vista prima gliela interpretò magnificamente tanto che Gershwin si emozionò. Diventarono amici e si incontrarono all’Avana, era il 1928. E oggi per similitudini di approccio alla musica africana Lecuona viene considerato il Gershwin cubano. Sei d’accordo?
E’ tutto verissimo e sono d’accordo. Stupendo poi quello che ci hai ricordato e che merita di essere conosciuto perché stiamo parlando di due autori di grande musica del Novecento. Ora pensando alla stima di Trueba nei miei confronti e alle similitudini da lui rimarcate tra Lecuona e il sottoscritto c’è del vero ma con le debite proporzioni. Trueba non sapeva però, ma lo aggiungo io, che nei miei primi anni a New York lavorai per cinque anni nei musical di Broadway, suonai in alcuni progetti di Bob Fosse, ho scritto molte musiche per il cinema, musica da concerto, ho tre concerti per piano e orchestra, musica da camera, ho scritto musica per le sorelle Labeque, grandi concertiste francesi. Insomma senza paragonarmi a tale gigante qual è stato Lecuona, un po’ di verità c’è in quelle similutidini trovate da Trueba quando penso al mio mondo musicale molto ampio, e in questo senso il mio lavoro un po’ si relaziona a quello di Lecuona ma anche di Gershwin. Con Lecuona però condivido senz’altro il fatto di essere un grande viaggiatore e di girare tutto il mondo. E questo si riversa anche nella mia musica,
Concordo, perché assistere a un tuo concerto anche di piano solo è come fare il giro del mondo in circa ottanta minuti, e non è abilità di tutti.
Ti ringrazio infinitamente di questo enorme stima e complimento. E grazie ancora anche alla importantissima rivista Musica Jazz.
Gian Franco Grilli




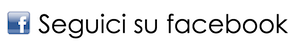






 Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.
Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.












 presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.
presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.