RAY MANTILLA, conguero morbido del jazz

Il 21 marzo 2020 a New York si è spento il percussionista RAY MANTILLA. Nato il 22 giugno 1934, Raymond Mantilla Maldonado, da diversi mesi era in terapia per combattere il tumore ai polmoni che solo negli ultimi due mesi ha fiaccato tutta la sua volontà ed energia. Lo ricordiamo con gratitudine con l’intervista integrale che segue, raccolta a Bologna nel settembre 2017 e in parte già pubblicata sul mensile Musica Jazz (marzo 2018).
«Non sono il migliore conguero, ma ho suonato con i migliori jazzisti della storia». Così Ray Mantilla, ottantatre primavere, percussionista latin con uno stile molto americanizzato, morbido e non comparabile con gli ortodossi maestri del livello di Mongo Santamaria, Armando Peraza, Tata Güines, Carlos Patato Valdés o Sabu Martinez ha concluso la nostra chiacchierata a Bologna in occasione del recente concerto con il gruppo EuroSpace Station diretto dal sassofonista Gaspare Pasini. Siamo partiti proprio dall’ultratrentennale collaborazione tra Pasini e Mantilla prima di parlare di «High Voltage» (Savant – distr. Ird), il nuovo album che riporta l’attenzione sul leggendario percussionista newyorkese di origini latine che è cresciuto sotto le ali protettive di giganti del drumming come Max Roach e Art Blakey o a fianco di jazzisti come Charles Mingus, Dizzy Gillespie, Herbie Mann, Gato Barbieri, Muhal Richard Abrams, o di salsa jazz come Tito Puente e Ray Barreto, per citarne alcuni. Insomma, una lista di nomi che farebbe invidia a molti percussionisti, che non possono vantare altrettante collaborazioni in registrazioni storiche come «We Insist! Freedom Now Suite», «Cumbia & Jazz Fusion», «Chapter 3 – Viva Emiliano Zapata», o «El Watusi». Ecco cosa ci ha raccontato il Nostro, uomo di rara sensibilità, comunicativo, che notiamo subito desideroso di farci sapere chi c’era prima di lui, ovvero il suo albero genealogico che svela radici italiane, e mostrarci il suo passato, interessante, ancorché pieno di ostacoli, per capire il suo presente.
Ray, tu che hai suonato con grandissimi maestri del jazz e dell’afro-latin quando suoni in Italia, spessissimo, ti fai accompagnare da musicisti locali. Sinceramente, gli artisti italiani rispondono bene alle tue esigenze estetiche o…
E’ vero, ho lavorato con musicisti che hanno scritto pagine musicali formidabili nella storia del jazz e del latin jazz. Detto questo, i musicisti italiani sono latinos e quindi c’è affinità e basta spiegare loro alcune cose per trovare l’intesa, anche se anni fa con i batteristi le cose erano un po’ più difficili per trovare gli incastri giusti, ma poi alla fine si riesce a trovare la combinazione magica. Con Gaspare Pasini ci conosciamo da vecchia data, era il 1986, e lui padroneggia molto bene la nostra cultura musicale, il fraseggio, gli accenti del latin: iniziammo a lavorare assieme quando era un ragazzo con il progetto EuroSpace Station (ma l’ho chiamato anche in altri contesti , ad esempio quando al piano mi accompagnava il colombiano Eddie Martinez) e il repertorio si basava soprattutto sul disco «Hand Of Fire», credo uno dei miei lavori più belli, uscito nel 1984 e prodotto da Alberto Alberti con Red Records, l’etichetta milanese di Sergio Veschi, con cui ho inciso molti album. Pertanto, quando non posso portare il mio gruppo americano del momento mi rivolgo a collaudati musicisti italiani come Gaspare che conosce la mia musica, organizza una band, come è avvenuto stasera per presentare l’ultimo disco «High Voltage».
Allora parliamo del tuo nuovissimo album, di latin mainstream e piacevole da ascoltare, dove oltre ad alcuni fedelissimi come Eddie Martinez e Cucho Martinez, c’è anche un batterista italiano con cognome ispanico, più noto all’estero che nella Penisola.
Il mio primo disco da leader fu «Ray Mantilla» della Inner City (1978) e ora pubblico «High Voltage», il quattordicesimo da solista, registrato in cinque giorni e nonostante fosse un periodo terribile per me: tra una session e l’altra dovevo assistere mio figlio Roberto in ospedale, che soffriva da tempo e purtroppo ci ha lasciati mentre stavo tornando da una tournée. Con questo dolore nel cuore non so come ho potuto incidere l’album, che ho dedicato ai miei due figli (l’altro si chiama Drayden), a mia madre Ramona (la traccia 8 è in suo onore, e di cognome faceva Maldonado). E anche al mio caro amico Walton con il suo Cedar’s Blues, che apre l’album, e ho voluto ricordare il meraviglioso personaggio che era Cedar, i tempi in cui suonavamo con Art Blakey, ossia la prima metà degli anni Sessanta. E’ vero, alla batteria c’è l’italiano Diego López, che lavorato a lungo con Gato Barbieri, Dave Valentin, con importanti bluesmen americani, e lo interpellai quando si ammalò il mio batterista su suggerimento di alcuni amici: ne apprezzai subito qualità, groove, swing e notai che possedeva i fondamentali del jazz en clave, caratteristiche che non sempre è facile trovare anche in batteristi blasonati. Inoltre, Diego sa ritmare come un timbalero, quindi una spalla importante per le mie improvvisazioni.
Lane Change, è il brano che spicca su tutto, sconfina dal latin classico e affida il comando a ritmiche lontanissime e complicate come quelle indiane. Insomma, una festa di tamburi e ritmi del mondo guidata dalle tablas che si intrecciano al cajón peruviano e alle congas.
Sono contento di questa fotografia musicale. Molti gruppi latin non fanno che cimentarsi con la rumba aperta, guaguanco, columbia eccetera; io non abbandono la clave, ma voglio anche percorrere altre strade e in questo caso trovo similitudini tra le culture religiose dell’India e alcuni sincretismi caraibici, ad esempio la Santería. Inoltre, Maytrey Padukone, indiano, che di professione fa il dentista, domina bene la sintassi metrica indiana, le tablas e così ho deciso di creare nuove atmosfere world ricorrendo all’estro e alla sapienza di Eddie Martinez.
Mi sembra di capire che sei interessato ai sincretismi: pratichi la Santería cubana o altre realtà magico-religiose? Hai partecipato a riti di iniziazione o coronato qualche Ocha (divinità)? Ti sei sottoposto a sedute di “purificazione”?
Un mondo molto interessante, ma l’ho solo sfiorato: nel senso che credo nel cattolicesimo, però seguo i suggerimenti di una santera cubana, ossia la madrina che mi ha indicato una strada e consigliandomi di portare sempre con me una collanina, simbolo di benedizione e protezione del Santo per evitare le invidie degli altri percussionisti. Sono solo un elementare discepolo di questa mescolanza di cattolicesimo e spiritualità africana, dico le mie preghiere però non ho fatto un percorso completo di rituali con la cerimonia per ottenere la protezione dell’orisha. Eppoi, diciamolo, questa ufficiale “benedizione dei santi” è molto costosa, e a me non va.
Santeria, orisha e Cuba mi richiamano alla mente il maggio 1977 con lo storico Crucero del Jazz, M.S. Daphné, che sbarca all’Avana. Sei uno dei pochi protagonisti, ancora viventi, di quella delegazione statunitense guidata da Dizzy Gillespie e che tra gli altri comprendeva anche Ry Cooder e Leonard Feather: cosa ricordi di quell’evento che riportò sotto i riflettori del mondo il nuovo jazz cubano? E nella culla dei ritmi e della conga afrocubani come ti accolsero i colleghi di strumento locali?
Io facevo parte del gruppo di David Amram e alla batteria c’era Billy Hart, che durante il viaggio verso Cuba mi chiedeva continuamente di spiegargli il concetto di clave. Il giovane Arturo Sandoval, capetto-anfitrione, ci portò nei loro luoghi preferiti, ossia il Tropicana, l’hotel Habana Libre, ma Dizzy a un certo punto gli chiese che volevamo incontrare dei percussionisti, e allora andammo nel quartiere Pogolotti dell’Avana: erano specialisti di tamburi batá e ricordo che mentre stavano suonando arrivò la Polizia per vedere che cosa stava succedendo, chi eravamo eccetera. Bellissimo poi fu il concerto al Teatro Mella con Irakere e il gruppo di rumba Los Papines. Infine ci fu anche una jam session tra la nostra band diretta da Amram, Los Papines , Oscar Valdés, Paquito D’Rivera, Arturo Sandoval e rammento che Ricardo Papín Abreu, il leader dei Papines, si comportò come la star della serata e non voleva smettere di suonare: notai, inoltre, un atteggiamento tiepido nei miei confronti durante l’esibizione ma io presi i miei assoli, e il tutto si può ascoltare (con ben sei percussionisti) nel brano En Memoria de Chano Pozo pubblicato nel disco di David Amram, «Havana/New York». Tra l’altro appresi da David di questa memorabile registrazione, che lui aveva comprato pagando un po’ di diritti agli artisti cubani, solo poco prima dell’uscita dell’album avvenuta nel 1978. Comunque, a parte la freddezza di Papín (ma posso capire la rivalità), l’esperienza di quell’interscambio culturale con Cuba fu molto importante e lì suonai con tutti, da Gillespie a Earl Hines a Stan Getz. Quella fu l’unica mia volta nell’isola di Cuba: ricevetti altri inviti ma voleva dire non prendere un centesimo di compenso e…

Bologna, La Torinese, 2017, ultimo concerto in Italia di Ray
Hai parlato poc’anzi di Alberti, bolognese che non c’è più da una decina di anni e una persona a cui sei stato molto legato: come l’hai conosciuto?
Alberto Alberti è stato uno dei principali promotori di festival jazz in Italia e a lui debbo tutto se sono così apprezzato in questo Paese. Oltre che un grandissimo amico è stato per me un grande fratello e lo conobbi a New York grazie a Cedar Walton: da quel momento è nato un rapporto straordinario, bellissimo, indimenticabile e quando ritorno da queste parti mi ricarico perché sento l’energia di Alberto e poi ho tantissimi amici, musicisti e non. Inoltre nelle mie vene, c’è un po’ di sangue italiano e ogni volta che ritorno penso ai miei antenati.
Tra un po’ ne parliamo, ma ricordi la prima volta che sei venuto in Italia?
Sono venuto tantissime volte ma non ricordo la prima in assoluto. Probabilmente, a metà degli anni Settanta, con la band di Tito Puente quando andammo in Sardegna invitati da Isio Saba, altro grande promoter e produttore di eventi culturali. Poi sono venuto con la M’Boom Percussion di Max Roach a Ravenna nel 1980; con la mia band Space Station nel 1984; due anni dopo è certa la mia presenza con la citata European Space Station. Altro appuntamento importante fu con M’Boom di Roach al Palasport di Bologna, il 30 gennaio 1989, come leggo dalla foto che mi stai mostrando, e tra gli ospiti speciali c’era Mongo Santamaria, mentre Art Blakey non riuscì a venire perché bloccato a Londra per problemi di salute.
A proposito di salute e benessere, noto che nonostante gli oltre sessant’anni di intensa carriera sulle spalle, sei resistente e sembra non sia ancora giunto il momento di tirare il bilancio perché invece di goderti la pensione, o almeno rallentare la marcia con l’attività musicale, tu continui ad affrontare lunghi e faticosi viaggi intercontinentali, spostamenti da una città all’altra. Perché?
Il motivo è allo stesso tempo semplice e complesso: questa è la mia vita e senza lavorare morirei, inoltre guadagno qualcosa in quanto vivere a New York è troppo costoso. Parlando dell’Italia, lo ripeto , qui ci vengo con mucho gusto da molti anni con la Space Station, con The Jazz Tribe, con Bobby Watson, Jack Walrath, Steve Grossman, Steve Berrios eccetera, perché ritrovo l’entusiasmo dei vecchi tempi e il vostro pubblico è sempre attento al mio lavoro. In generale però ritengo che un musicista debba stare sul palcoscenico fino all’ultimo: se Dio vorrà, mi piacerebbe andarmene da questo mondo mentre sono in scena, come accadde a Miguelito Valdés, con il quale ho lavorato, e la stessa sorte toccò a Machito (Frank Grillo).
Come finirà non si sa, quindi meglio cambiare tasto e fare un salto indietro, quando sei arrivato su questa Terra. Direi di tracciare un tuo ritratto preciso per smentire chi ti vuole portoricano, chi cubano, chi peruviano . E invece?
Sono statunitense. Ma la mia storia è questa: mio padre Carlos Mantilla Ghilardi, nato a Anchas, Trujillo (Perù) nel 1909, all’età di otto anni, rimasto orfano dei genitori grazie allo zio Gustavo Ghilardi di Lima studiò presso un collegio di Lima, poi a diciannove anni lo mandò a vivere dalla zia Maria Mantilla (figlia dell’Apostolo cubano José Martì) a New York. Qui Carlos diventa ingegnere, conosce e sposa Ramona, mia madre, che era stata la sua insegnante di inglese, e dall’unione nacqui io, . Mio padre che era un inventore lavorava come ingegnere nel Dipartimento della Guerra degli Usa, e nel 1942 come membro del Servizio Segreto statunitense viene inviato in Perù per smantellare una rete la rete di spie naziste che hanno ucciso due autorità militari Usa. Alla fine della guerra mio padre resta a vivere in Perù, si risposa, ha cinque figli, fonda la prima accademia di studi linguistici Mantilla’s Teaching System, pubblica libri, poi dovrà andarsene dal Perù per problemi di sicurezza e va a Miami con la nuova famiglia. Ma io avevo perso le sue tracce da oltre ventidue anni, quando un giorno dopo un annuncio che cercavo mio padre apparso su un giornale del Perù ci ritrovammo. Avevo ventinove anni. Ci sono articoli su questo, non sono balle.
Una vicenda da “Chi l’ha Visto?” (e spiego a Ray che si tratta di un programma televisivo)?
Sì, perché nessuno sapeva dell’uno e dell’altro: mio padre mi scriveva ma senza raggiungermi perché avevamo cambiato indirizzo e i vicini non sapevano nulla. Poi venne a cercarmi a New York, ma niente, poi il reincontro citato dopo il miracoloso annuncio sul giornale, e la scoperta di altri cinque fratelli, peruviani, meravigliosi. L’albero genealogico della mia famiglia è stato poi approfondito da mio fratello Lisandro Gilberto, che attualmente vive a Miami, scoprendo le nostre origini italiane: mia nonna, Eulalia Ghilardi, peruviana, nata da genitori italiani esiliati politici nella seconda metà dell’Ottocento a Trujillo, città della costa nord del Perù, sposò Lisandro Mantilla, i cui antenati invece provenivano dalla Spagna e transitando per New York, L’Avana si stabilirono in Perù mescolandosi anche con Inca. I nonni non li ho mai conosciuti perché morirono presto, e quando il loro figlio, mio padre Carlos, era piccolo.
Mentre In Italia sei venuto tante volte, in Perù sei stato a suonare?
Non ci crederai, ma la prima e unica volta in Perù è stato nel 2014 assieme ai miei fratelli per assistere a una funzione religiosa in memoria dei nostri cari. E poiché nel mio dna c’è anche qualcosa degli Incas, tra i miei sogni da realizzare in questa vita c’è un concerto a Machu Picchu: mio fratello Lisandro Gilberto ha già scritto al sindaco di Cuzco per studiare il progetto e la fattibilità.
Torniamo ancora sui tuoi passi iniziali. L’interesse per musica quando e come è maturato?
Io sono cresciuto nel Bronx dove c’era musica in ogni angolo di strada e in casa mia ogni domenica mio padre Carlos, che era chitarrista, suonava con il suo trio di musiche latine. Tra l’altro, mio padre fu l’organizzatore del primo Latin-American Folk Festival alla Town Hall di New York ( 23 giugno 1935) e si presentò come direttore del Peruvian Inca Art Group. Nonostante questo contesto musicale familiare, almeno fino al 1942 quando mio padre scompare, io pensavo allo sport, e soprattutto al baseball che praticavo con il sogno di diventare un grande campione di pelota. Poi a sedici anni mi capitò di ascoltare l’orchestra di Machito al Palladium dove andavo a ballare e lì rimasi letteralmente folgorato dal ritmo delle congas in Tanga: «Tangaaaaa, Machito llegò…» e su questo refrain con il tumbao di Luis Miranda si cancellarono in un attimo tutte le mie ambizioni da pelotero.
Quindi il tuo primo strumento fu la conga? Ti sei formato con insegnanti o da autodidatta?
Esatto, cominciai con la conga e successivamente mi dedicai allo studio anche degli altri strumenti della percussione afrocubana, ossia timbales, bongo, güiro eccetera. Comunque all’inizio presi lezioni private di solfeggio dal flaustista cubano Alberto Socarrás., poi il conguero Chonguito che suonava nella band di Tito Rodriguez mi consigliò di studiare piano con sua sorella … ma io volevo suonare subito senza passare per il solfeggio e imparare a leggere la musica, metodo che ritenevo noioso. Allora mi concentrai sulla conga facendomi aiutare da Johnny “La Vaca” Rodríguez (1930 – 2000), ottimo percussionista che lavorò con tante orchestre importanti tra cui quelle di Noro Morales, Miguelito Valdés, Tito Rodríguez ed era il padre di John ‘Dandy’ Rodríguez, mitico bongosero per trent’anni di Tito Puente. Inoltre frequentavo anche José Mangual, una leggenda del bongo che suonò anche con Charlie Parker. Insomma confrontandomi con questi artisti imparai moltissimo. Molti non lo sanno, ma anni dopo, durante un periodo di vita e lavoro a Porto Rico, studiai anche la batteria.
Ricordi la prima band con cui hai suonato?
Il mio primo lavoro professionale fu con l’orchestra che accompagnava lo show della grande cantante e ballerina Eartha Kitt nel 1955. Poi per vent’anni ho suonato con tutti i grandi artisti della salsa, o musica latina: Miguelito Valdés, Xavier Cugat, Monguito (il figlio di Mongo Santamaria), Playa Sextet, Tito Puente e naturalmente sono stato il timbalero di Ray Barreto con cui ho registrato diversi ellepì tra cui quello che lo rese famoso, «El Watusi». In quegli anni incisi anche con Lou Perez, poi Barreto mi mise in contatto con il grande jazzista Herbie Mann con il quale andai a suonare in Brasile e nel 1960 incidemmo un disco. Era uno scambio continuo di favori tra di noi e quindi fui io poi a creare il legame tra Barreto e Tito Puente.
 In quella fase maturarono esperienze di grande prestigio per la tua carriera: ad esempio, incontrasti Max Roach per registrare il celebre album «We Insist! Freedom Now Suite» assieme ad altri percussionisti tra cui il nigeriano Michael Olatunji.
In quella fase maturarono esperienze di grande prestigio per la tua carriera: ad esempio, incontrasti Max Roach per registrare il celebre album «We Insist! Freedom Now Suite» assieme ad altri percussionisti tra cui il nigeriano Michael Olatunji.
Sì, stavo suonando con Herbie Mann al Village Gate e quella esperienza mi aprì le porte importanti nel jazz. Infatti Roach mi veniva a vedere e una sera mi invitò a lavorare nel suo progetto discografico che rappresentò un manifesto per i diritti civili, tema che condividevo e condivido poiché ero attento alle iniziative del movimento dei diritti civili e alle battaglie per le libertà: io sono per l’integrazione e non la separazione. In quel disco suonavamo congas e tamburi africani di diverse fatture, era un beat africaneggiante con accenti anche afrocaraibici. Degli artisti che incisero quell’album, solo in due siamo ancora in vita, io e Julian Priester, trombonista che vive in California. Lavorare con M’Boom fu magnifico, una all stars di percussionisti, poi approfitto per citare altri artisti di prestigio con cui ho suonato: un altro gigante del jazz e del drumming come Art Blakey con i suoi Jazz Messengers e suonare al suo fianco era impegnativo, se non ce la facevi a stare al suo passo non rimanevi nel gruppo; riuscire a tenere il ritmo di Blakey era una bella impresa per chiunque e alla fine della performance aumentava la mia autostima; poi Charlie Mingus, Joe Farrell. Gato Barbieri.
A proposito di Mingus: come andarono le cose sulla storica incisione di «Cumbia & Jazz Fusion» visto che partecipasti assieme ad altri percussionisti?
So che dovevano esserci dei musicisti colombiani ma… Mingus era uno tipo molto volubile, cambiava sempre le carte: un giorno gli piaceva un pezzo come lo suonavi e il giorno seguente non gli andava bene. Il tenorsassofonista Paul Jeffrey, che abitava nel mio edificio mi aveva ascoltato nel periodo che lavoravamo assieme con la band di Sam Rivers, e allora mi segnalò a Mingus per la mia esperienza con i ritmi caraibici e sudamericani avendo suonato in orchestre di musica latina con repertori di merengue, cumbia, danzón eccetera, e quindi mi presentai e superai l’esame esigente di Mingus. Con Charles incisi anche altri album come «Something Like a Bird» e «Me,Myself an Eye».
 Prima di queste pagine jazzistiche ho letto ci fu una parentesi portoricana, se non sbaglio.
Prima di queste pagine jazzistiche ho letto ci fu una parentesi portoricana, se non sbaglio.
E’ giusto, dal 1963 a 1969 a intervalli, quando mia moglie e mio figlio si stabilirono lì e così in quella fase suonai con una grande orchestra nei club di San Juan, diversi spettacoli al giorno, e in quei locali suonava anche la band di Tito Rodriguez. Inizialmente lavorai con l’orchestra di Rafael Muñoz y Su Orquesta, poi con la band del Escambron Beach Club; nel ristorante Mesa del Capitain, suonavo la batteria nel trio che allietava gli ospiti ma lavoravo moltissimo anche alla televisione (suonando congas) e di sera in un altro gruppo. Ma mi spostavo ovunque in tournée con gli artisti cui collaboravo. Dagli anni Settanta in avanti abbandonai la salsa o la musica latina prettamente ballabile perché ero sazio della rigidità che impongono quelle musiche, cioè è un ostacolo ingombrante alla libertà ritmica quando devi pensare al ballerino, così mi dedicai a trovare un ruolo alla conga nel jazz. Poi se lavoro con il latin jazz, la clave diventa fondamentale, ma sempre cerco di offrire un beat morbido.
Quindi dovrei evitare questa domanda, ma te la faccio ugualmente: cosa pensi del virtuosismo vertiginoso, raggiunto con gli studi della “mano secreta”, cui tendono tutti i congueros delle ultime generazioni E c’è qualche nome che ti piace veramente?
La musica, per me, è un melting pot, è un arcobaleno, per questo da una certa data in poi ho scelto di creare pattern da ascoltare combinandoli con le sintassi del jazz. Per stare sulla domanda: credo che non sia giusto cercare di suonare come un cubano ad ogni costo, e per quanto mi riguarda ho sempre tenuto presente che vengo da New York, ho ascoltato percussionisti di tutto il mondo che animavano la capitale del jazz, ascoltavo dischi di musicisti che si muovevano in questo ambito, i cubani avevano un loro modo di rapportarsi al ritmo, un altro modo differente ce l’hanno i brasiliani e così via. I miei ritmi vengono dal mio cuore, da ciò che ho respirato, dalla cultura afrolatina newyorkese, caraibica, taino, peruviana, Inca. Il mio mondo ritmico e compositivo è stato influenzato dalle esperienze vissute liberamente senza pensare alle scuole percussive dominanti, io cerco di fondere con originalità tradizioni percussive diverse, jazz e improvvisazione, congas, cajon, timbal e claves. Francamente non so dirti se latinizzo il jazz o jazzifico i ritmi latini, è un confine labile, direi invisibile e quindi… Il numero uno della conga? Giovanni Hidalgo.
Per concludere: una giornata tipica quando non sei in tournée?
Ora vivo a Manhattan, sto lavorando con la Jazz Foundation, che mi aiuta mandandomi a suonare nelle scuole, negli ospedali con attività di tipo culturale e sociale. Mi spendo anche didatticamente per animare bambini con handicap e questo percorso l’ho iniziato dopo aver fatto esperienza con ragazzi affetti dalla sindrome di Down dell’istituto diretto da mio fratello Lisandro notando che questi ragazzi adorano il ritmo. Inoltre ho un trio con un vibrafonista, basso. In sintesi, ringrazio per questo interessante dialogo sulla mia carriera, su quello che sono riuscito a tirar fuori dalle pelli di congas, bongos e timbales facendo attrazione in quei grandi jazzisti che abbiamo nominato. Ribadisco, se non si è capito, che non sono il migliore conguero in circolazione, ma io ho suonato con i migliori jazzisti della storia.
Gian Franco Grilli
(da Musica Jazz, marzo 2018)
Foto: Euriolo Puglisi
.




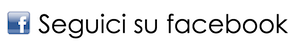






 Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.
Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.












 presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.
presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.