OSCAR HERNÁNDEZ: la mia gente e il Latin Jazz

Salsa e latin jazz per il riscatto dei latinos. Questo in estrema sintesi il succo che spicca dalla lunga e articolata intervista a Oscar Hernández, importantissimo pianista, compositore e bandleader della musica latina e del latin jazz. Nato a Manhattan, da qualche anno Oscar si è trasferito a Los Angeles dove continua a muovere i suoi progetti con il quintetto Alma Libre e con la favolosa SHO.
Oscar Hernández: il successo della mia gente passa dal Latin Jazz
Così titolava Musica Jazz (Novembre 2019) per presentare un estratto dell’intervista di Gian Franco Grilli che proponiamo nella versione integrale.
Pianista, compositore, arrangiatore, bandleader, Oscar Hernández è considerato uno dei virtuosi del Latin Piano e in possesso di un enorme talento che gli permette di padroneggiare non solo tutti gli stilemi del jazz, ma soprattutto il lessico latin dove spicca il montuno, che è la base fondamentale per animare le musiche di impronta afro-cubana e della salsa dura. Fondatore e direttore del quintetto Alma Libre e della Spanish Harlem Orchestra (SHO), oltre duecento dischi registrati per artisti di mezzo mondo, quattro Grammy Awards, il versatile artista nuyorican (newyorkese figlio di portoricani), cresciuto nei quartieri afro-latini della Grande Mela e al servizio dei grandi protagonisti del firmamento salsero, «incredibile, ma vero», all’età di sessantrè anni ha esordito discograficamente da solista con «The Art Of Latin Jazz» (Origin Records, 2017). E a distanza di due anni esatti, con la medesima etichetta e sempre con il quintetto Alma Libre è uscito il suo freschissimo e frizzante cd «Love The Moment» (recensito sul numero di ottobre). Da qui lo spunto per accendere i riflettori sul formidabile e generoso musicista che in quarantacinque anni di attività ha contribuito significativamente al successo di personaggi acclamatissimi della musica latina, della salsa jazz e anche pop tra cui Ismael Rivera, Ray Barreto, Rubén Blades, Willie Colón, Celia Cruz, Dave Valentin, Mongo Santamaria, Tito Puente, Juan Luis Guerra, Gloria Estefan e Paul Simon. L’intervista che vi proponiamo si è trasformata anche in una cronaca delle musiche urbane latinoamericane lunga mezzo secolo.
Oscar, da qualche tempo vivi nella tiepida Los Angeles ma tu sei cresciuto nella fredda New York latina, che frequenti ancora. E allora partiamo dalla Big Apple: raccontaci l’atmosfera sociale e culturale che si respira oggi tra i vicoli del mitico Spanish Harlem, nel Barrio, nel South Bronx , insomma di quei luoghi dove si sviluppò sviluppo il fenomeno della salsa.
Sì, sono nato a Manhattan e diciamo che El Barrio dista circa quindici minuti dai luoghi della mia infanzia, un quartiere molto popoloso dove la cultura latina si è manifestata nella sua interezza. Qui sono riuniti tutti gli aspetti della quotidianità delle comunità latine, dai negozi tipici al cibo, dalla musica ad altre espressioni culturali. Le cose sono cambiate da quando ero adolescente, nel corso degli anni tanti latinoamericani si sono trasferiti in altri quartieri e qui invece sono arrivati gruppi etnici di ogni dove. Parlando di musica latina, adesso esistono solo pochi e piccoli locali, il fermento degli anni della mia gioventù è solo un ricordo; tuttavia per uno straniero, amante della salsa e della musica latina, che visita New York, lo Spanish Harlem è ancora una tappa indispensabile.
Si racconta che nel Barrio c’erano conflittualità, concorrenza in campo musicale, rivalità di ogni tipo e soprattutto tra portoricani e cubani. Vero o falso? E che ricordi hai di quell’epoca?
Un po’ di verità c’è sempre quando si tratta di conquistarsi un posto di lavoro in momenti di crisi. Sì, esisteva un po’ di spirito conflittuale, o meglio, una sorta di gelosia o rivalità, ma niente di troppo serio, almeno per quanto riguarda la mia esperienza e i miei ricordi. Io ho collaborato con artisti di diversa provenienza e quindi con cubani, messicani, colombiani e venezuelani. Si faceva salsa ma non si conosceva ancora quella musica come salsa: era la musica di Willie Colón e di Héctor Lavoe, dei due fratelli Palmieri, Ismael Miranda, Tito Puente e altri ancora che sarebbe lungo citare.
Oggigiorno, da «losangelino», quali sono i locali newyorkesi dove maggiormente ti invitano a suonare?
Continuo a suonare a New York con progetti di jazz e latin jazz in questi club: Jazz Standard Music, Blue Note, Dizzy Club Coca Cola o al Birdland. Per la musica latina e salsa il posto ideale dove lavoro spesso con la SHO è il West Gate Lounge. Ma forse volevi sentirti dire Palladium, Conga, Blen Blen, Copacabana o qualcosa di simile? Scherzo, però quel mondo di club pieni di musica latina non esiste più o si è trasformato da tempo.
Certo, quelli erano locali dell’epoca d’oro della musica latina edulcorata. Tuttavia, e se non sbaglio, ha resistito un po’ il mitico The Village Gate e tu hai frequentato il secondo ciclo dello storico «Salsa Meets Jazz». Giusto?
Certo! Erano i fantastici lunedì con memorabili descargas e partecipai moltissime volte con diversi gruppi tra cui Ray Barreto, Rubén Blades e il Conjunto Libre di Manny Oquendo che incorporava i fratelli Andy e Jerry González. E’ stato un periodo indimenticabile, si viveva nell’attesa e con tante aspettative per quelle magiche serate dove grandi jazzisti di diverse esperienze si confrontavano. E’ stata una bella e lunga pagina musicale, ma le cose belle finiscono troppo presto.
 Facciamo un salto negli anni Cinquanta, la decade in cui sei nato e poi procediamo in avanti per chiarire alcuni punti man mano che li incontriamo. Per esempio sul tuo cognome: poiché è diffusissimo tra i musicisti latinoamericani (e c’è anche un omonimo, compositore cubano, già scomparso), presentaci i tuoi connotati. Poi correggiamo alcune inesattezze (davvero assurde) che circolano in rete sul tuo conto: ti hanno fatto nascere nel 1940 e addirittura suonare con Charlie Parker.
Facciamo un salto negli anni Cinquanta, la decade in cui sei nato e poi procediamo in avanti per chiarire alcuni punti man mano che li incontriamo. Per esempio sul tuo cognome: poiché è diffusissimo tra i musicisti latinoamericani (e c’è anche un omonimo, compositore cubano, già scomparso), presentaci i tuoi connotati. Poi correggiamo alcune inesattezze (davvero assurde) che circolano in rete sul tuo conto: ti hanno fatto nascere nel 1940 e addirittura suonare con Charlie Parker.
Prima di tutto grazie per questa opportunità di correggere questi errori attraverso la vostra prestigiosa rivista. E’ pazzesco leggere certe stupidaggini: Parker è morto nel 1955 e io sono nato il 22 marzo 1954 a New York, quindi sarei stato precocissimo. Comunque Oscar Antonio Hernández Blanco è il mio nome completo, sono figlio di genitori che emigrarono qui a New York da Puerto Rico. Quindi sono un nuyorican come si dice da queste parti, ma mi sento totalmente portoricano, più boricua che newyorkese nonostante utilizzi più l’inglese dello spagnolo. E questo aspetto lo manifesto nella mia musica, nella cultura, nel cibo, nei rapporti con le donne e – come ti dicevo prima di iniziare questa intervista – sogno con spirito latino. Ma per me è abbastanza facile passare mentalmente da una realtà all’altra.
Nel febbraio del 1964 la Beatlemania sbarcò anche New York. Tu avevi solo dieci anni ma ricordi di aver fatto parte di quei settantatre milioni di spettatori che scoprirono il quartetto di Liverpool all’Ed Sullivan Show? Ti colpì quel fenomeno che, tra l’altro, mise in ombra nelle radio la musica latina in voga allora, cioè boogaloo, guaracha, mambo o bolero?
Io vidi quello spettacolo ma ero già interessato ad altre sonorità: mi piacevano Machito, Tito Puente, Tito Rodriguez, la musica tipica di Porto Rico o il bolero, che veniva trasmesso moltissimo nelle emittenti radiofoniche latine. Io però ero attratto dai linguaggi sonori del latin jazz e delle musiche latine, quel sound che poi mi ha formato artisticamente. Nessuno in casa mia si occupava di musica: di dieci fratelli io sono l’unico che ha scelto questa strada iniziando a dodici anni a studiare la tromba, che però abbandonai dopo due anni per dedicarmi al pianoforte, strumento più adatto alle mie possibilità fisiche. Sono autodidatta, suonavo a orecchio, leggevo un po’ di musica e solo più tardi mi applicai seriamente diplomandomi e prendendo anche una laurea.
Armonia, composizione e arrangiamento con chi li hai approfonditi?
Sempre da solo, osservando molto qua e là: debbo ammettere però che ho avuto la fortuna di ascoltare e lavorare con arrangiatori e musicisti molto bravi: Josè Febles, specialista nella salsa, poi Marty Sheller, Luis Cruz e Eddie Martínez sono stati un grande esempio per la mia crescita musicale.
Quali sono stati i tuoi primi idoli del pianoforte e i tuoi preferiti in assoluto oggi?
I pianisti che inizialmente mi influenzarono molto furono Eddie Palmieri e suo fratello Charlie, lo stesso Eddie Martinez, Sonny Bravo, Gilberto López (conosciuto artisticamente come Gil López) e Papo Lucca in ambito latino; poi jazzisti come Bill Evans, Bud Powell, Monk, Hancock, Corea e altri. Oggi, oltre ad alcuni di quelli appena citati, tra i musicisti davvero stratosferici ci metto Chucho Valdés, Michel Camilo e Gonzalo Rubalcaba.
Agosto 1969, al mega happening di Woodstock esplode il rock latino di Carlos Santana. Come hai vissuto quell’evento da apprendista musicista?
Io notai la pubblicità ma pensavo fosse unicamente un evento di musica rock pompato come sempre da chi manovrava l’industria discografica; eppoi Santana per noi non stava suonando musica latina, lui non aveva le radici nel Barrio come noi: il suo era un sound influenzato dalle musiche moderne «americane».
A onor del vero, la performance dei Santana e i loro primi dischi contribuirono a incuriosire tanti giovani di tutto il pianeta che poi vollero scoprire le origini di quelle sonorità sconosciute in occidente. Molti aspiranti percussionisti, tra cui diversi italiani, di lì a poco intrapresero viaggi verso Cuba, Puerto Rico o lo stesso Barrio e quei ghetti popolosi latini di New York per conoscere le radici e i segreti di quel mosaico musicale e culturale i cui protagonisti principali erano stati: Mongo Santamaria, Machito, Mario Bauzá, Pérez Prado, Tito Puente, Tito Rodriguez e poi Benny Moré, Arsenio Rodríguez e indietro fino al mitico Chano Pozo.
Onestamente non lo sapevo ed è una cosa molto interessante, ma qui non successe tutto ciò perché si viveva in diretta lo spirito della controcultura latina.
 Anche i fenomeni «occidentali» citati prima erano espressioni di controcultura, ma questa è un’altra storia. Hai lavorato con tante figure leggendarie della salsa e del Latin, tra cui Rubén Blades e Ray Barreto: parlaci dell’inizio e dei passaggi fondamentali della tua vicenda, che rileggendola oggi rappresenta una mini-enciclopedia della musica latina.
Anche i fenomeni «occidentali» citati prima erano espressioni di controcultura, ma questa è un’altra storia. Hai lavorato con tante figure leggendarie della salsa e del Latin, tra cui Rubén Blades e Ray Barreto: parlaci dell’inizio e dei passaggi fondamentali della tua vicenda, che rileggendola oggi rappresenta una mini-enciclopedia della musica latina.
Iniziai a suonare con un gruppo che si chiamava La Conquistadora, poi passai con l’orchestra di Joey Pastrana, portoricano ma cresciuto nel Barrio, e il primo artista importante della mia carriera è stato il cantante Ismael Miranda, soprannominato El Niño Bonito, popolarissimo a New York. Dopo arrivò Pete “El Conde” Rodriguez, il Grupo Foklorico e il Conjunto Libre, una gavetta che mi introdusse nell’orchestra di Ray Barreto (conguero, “el rey de la mano dura”), un’esperienza straordinaria registrando sei dischi e quasi tutti furono considerati i migliori di quegli anni come «Rican/Struction» ,«Rhythm of Life», «Giant Force», «Tremendo Trio: Celia, Ray, Adalberto.
Prima di un cenno veloce su Celia Cruz e altri importanti artisti con cui hai condiviso il palco, soffermiamoci su Ismael Miranda e sul «poeta della salsa» Rubén Blades.
Ismael era un artista del popolo, una persona con molti problemi personali, dipendente dalle droghe, ma a parte questo era un ottimo cantante e contribuì significativamente alla diffusione della cultura portoricana a New York con La Revelación di cui entrai a far parte nel 1973. Poi per tredici anni (1983-1996) sono stato direttore musicale e arrangiatore del panamense Rubén Blades portando musica in tutto il mondo e questi indimenticabili anni mi ha regalato molti riconoscimenti artistici. Blades era ed è ancora un cantante superlativo, e come compositore scrisse testi affrontando importanti aspetti sociali. Diventò estremamente popolare e con un gran seguito per il modo in cui denunciava certe situazioni: lo faceva tanto bene che la gente si identificava nella sua musica. L’ultima volta che abbiamo suonato assieme è stato circa sette o otto anni fa con un tour mondiale del Seis del Solar, eppoi l’ho avuto come special guest in quattro brani del secondo album della Spanish Harlem Orchestra (SHO). Oggi non condividiamo quasi più niente dal punto di vista professionale, lui ha altri progetti e quindi ci sentiamo raramente per telefono o via mail.
Già, Blades e i suoi messaggi! Ma oggi che valore danno i latinos statunitensi alla Salsa e al Latin?
Tutto cambia, però credo che salsa e Latin jazz stiano resistendo fortemente come modelli identitari: ci tengono legati alla nostra comune cultura e possiamo considerarli come forme di concepire la vita completa da un’ottica latinoamericana, nel senso che tutti noi parliamo, mangiamo, ridiamo e continuiamo a sognare dentro la tradizione ispanoamericana. Esteticamente la salsa è una sintesi dei generi musicali del Continente sudamericano che si sono abbracciatai nelle metropoli, è un’espressione che racconta il barrio, il quartiere latino nel suo insieme, tra lotte, mille difficoltà ma anche gioia di vivere con sabor, che è l’essenza dello spirito latino.
Quello spirito raccolto nell’identificativa «Azúcar», parola intonata migliaia di volte da Celia, la mitica Voz de Cuba e anche Regina della Salsa.
Bravissimo, proprio così! L’ho sentita gridare al mondo intero tutte le volte che ho avuto la fortuna di lavorare con lei. Una figura leggendario che mi è successo di accompagnare perché non ha mai avuto un suo gruppo fisso e quindi ogni tanto Celia mi chiamava al suo fianco.
E ci sono altri nomi prestigiosi che hanno fatto la storia della musica latina e ai quali hai prestato i tuoi tasti bianconeri o curato degli arrangiamenti?
Nomi di spessore con cui ho suonato e in contesti differenti sono stati anche Tito Puente, di ero pianista supplente; il flautista dominicano Johnny Pacheco, fondatore con Jerry Masucci della Fania, eppoi ho lavorato con il leggendario percussionista Mongo Santamaria, persona squisita oltre che grande conguero, ma anche compositore e tra le sue perle citiamo Afro Blue, che è diventato uno standard apprezzato da tantissimi jazzmen e ancora oggi pezzo molto attrattivo e la cui fortuna è legata anche alla versione di Coltrane. Questo, tra l’altro, è un esempio che mostra il contributo della cultura afro-latina al jazz e alla sua evoluzione.
 A proposito di evoluzione, anche il Latin ha tenuto il passo cominciando a prendere nuove direzioni per rinnovarsi. Infatti da qualche decennio il Latin, figlio dell’afrocuban jazz, si è liberato (ma non ancora del tutto e forse è un bene) dell’egemonia dei ritmi afro-cubana e della dittatura della clave trovando ispirazioni nel folklore e in tradizioni musicali minoritarie dell’America Latina. A questo punto ti chiedo: la Salsa dovrebbe muoversi nello stesso modo del Latin, imboccando nuove strade per incrociare linguaggi moderni afro-americani (come fece lo stesso Mongo beccandosi poi delle critiche dai puristi per questa americanizzazione) combinando ritmo afro-cubano, jazz e soul oppure restare inchiodata al son montuno, con il rischio di diventare poi la musica dei nonni, come lo è da noi il «liscio»?
A proposito di evoluzione, anche il Latin ha tenuto il passo cominciando a prendere nuove direzioni per rinnovarsi. Infatti da qualche decennio il Latin, figlio dell’afrocuban jazz, si è liberato (ma non ancora del tutto e forse è un bene) dell’egemonia dei ritmi afro-cubana e della dittatura della clave trovando ispirazioni nel folklore e in tradizioni musicali minoritarie dell’America Latina. A questo punto ti chiedo: la Salsa dovrebbe muoversi nello stesso modo del Latin, imboccando nuove strade per incrociare linguaggi moderni afro-americani (come fece lo stesso Mongo beccandosi poi delle critiche dai puristi per questa americanizzazione) combinando ritmo afro-cubano, jazz e soul oppure restare inchiodata al son montuno, con il rischio di diventare poi la musica dei nonni, come lo è da noi il «liscio»?
La trovo un’osservazione giusta, perché qualcosa di analogo al tuo pensiero lo si sente da più parti, e cioè che la salsa senza degli aggiornamenti potrebbe diventare una musica soltanto per vecchi. Ma sono confortato dal fatto che sia a New York sia a Los Angeles ci sono giovani musicisti molto promettenti che potrebbero riservarci delle sorprese e spero proprio che prima o poi spunti qualcosa di interessante. Mongo, come hai ricordato, fu un maestro nel creare fusioni e venne premiato. La salsa però (e non bisogna dimenticarlo) non voleva essere solo musica e ballo, ma una sorta di movimento e una forma di riscatto latino. Venivamo da un periodo abbastanza confuso, scontri sociali, una situazione internazionale in ebollizione, e perdita di ruolo della musica latina eccetera. Quindi come risposta si cercò di creare musiche ritmate e canzoni partendo dai problemi quotidiani e per unire la vasta comunità ispanoamericana del Barrio. Ho avuto il privilegio di vivere pienamente il boom di quella che poi dalla prima metà del Settanta esploderà con il nome di Salsa. Ora tutto è più rapido, però mi rallegro quando avvengono fusioni di stili diversi perché le ibridazioni avvicinano persone di culture differenti, eliminano i ghetti e aprono nuovi orizzonti, in tutti i sensi. Così si crea futuro!
Hai parlato di riscatto, di orizzonti diversi rispetto al tuo mondo di riferimento. Puoi dirmi invece come nacque la collaborazione con un cantautore «impegnato» e importante dell’ambiente pop-rock statunitense come Paul Simon, ma un po’ fuori dal tuo contesto?
Certo è vero che era fuori dal nostro giro, ma aveva ascoltato il disco «Dance City» che avevo prodotto e diretto per il ballerino portoricano Eddie Torres e così mi chiese di collaborare con lui come direttore e arrangiatore della musica di «The Capeman», un musical pop-rock in scena a Broadway e poi sono nate altre cose. Anche quello fu un periodo molto produttivo e fruttifero, ma dovevo sbattermi tantissimo perché allo stesso tempo lavoravo con altri.
Nella tua immensa produzione c’è qualche progetto o disco a cui sei particolarmente legato?
Sono molti, ma all’istante mi vengono in mente «Buscando America» di Rubén Blades, «Rican/Struction» con Ray Barreto e il primo disco della SHO «Un Gran Dia En El Barrio».
 Con la SHO (Spanish Harlem Orchestra) hai vinto tre Grammy per gli album «Across 110Th Street», «Viva La Tradicion» e nel 2019 con «Anniversary». Nel quinto album, «Spanish Harlem Orchestra», ho notato che ci sono anche due jazzisti di prima grandezza come ospiti: Chick Corea e Joe Lovano. Assieme avete fatto anche concerti?
Con la SHO (Spanish Harlem Orchestra) hai vinto tre Grammy per gli album «Across 110Th Street», «Viva La Tradicion» e nel 2019 con «Anniversary». Nel quinto album, «Spanish Harlem Orchestra», ho notato che ci sono anche due jazzisti di prima grandezza come ospiti: Chick Corea e Joe Lovano. Assieme avete fatto anche concerti?
E’ stata solo una collaborazione discografica, ma ci riempie ugualmente di orgoglio lavorare anche se solo in studio con pezzi da novanta del jazz mondiale come Chick e Joe.
La tua maratona musicale, partita da New York all’inizio del Settanta, è approdata a Los Angeles una decina di anni fa. E proprio nella mecca della cinematografia mondiale è avvenuto il tuo esordio discografico come solista pubblicando «The Art Of Latin Jazz» (2017). Passano due anni e ne sforni un altro, «Love The Moment». Prima di parlare del recentissimo disco puoi dirci perché hai deciso di trasferirti in California? Eppoi a cosa si deve questa tardiva discesa in campo come solista dopo aver inciso oltre duecento dischi per artisti di livello mondiale?
Sono venuto a vivere in California per problemi affettivi: mia moglie (da cui oggi sono divorziato) è di Los Angeles e quindi tredici anni fa decisi di spostarmi qui, dove ora ho anche una figlia che vive gran parte del tempo con me e quindi questa è la mia nuova città. Inoltre c’è un clima spettacolare che mi piace moltissimo. Tuttavia trascorro molto tempo anche a New York, dove vado sei o sette volte all’anno per concerti e non solo. A Los Angeles poi c’erano anche dei motivi interessanti in campo lavorativo come compositore di musiche per la televisione e per il cinema e quindi anche questo influì per tale scelta. Per rispondere alla seconda domanda, ti dico che di Latin avevo già pubblicato un paio di dischi come direttore del gruppo Seis del Solar, ma non da solista. Poi mi piaceva e mi piace ancora lavorare e condividere in modo collettivo. Col tempo cambiano le cose e cambiamo anche noi ed è successo che a Los Angeles ho incontrato dei musicisti favolosi e tutti provenienti da diversi paesi dell’America Latina ma che vivono a Los Angeles. Insomma si è creato un feeling speciale in questo gruppo che ora ti presento: parto dal grande Justo Almario, che tra l’altro visse molto tempo anche a New York, ma è stabile in questa zona dalla fine degli anni Settanta. Justo è una leggenda del jazz, un punto di riferimento per il mio quintetto, è una persona con moltissima esperienza, musicalmente ha una sonorità solida, fantastico flautista, clarinettista e soprattutto eccellente sassofonista sia al tenore sia al soprano. Completano il quintetto Alma Libre, il bassista Oskar Cartaya, il percussionista Christian Moraga, il batterista Jimmy Branly. Eppoi in questo disco ho due ospiti eccezionali: la violinista Dayren Santamaría (presente in un brano) e il trombettista Gilbert Castellanos (in tre pezzi).
L’uscita ravvicinata di questi due dischi a tua firma mi fa sospettare che a Los Angeles tu abbia scoperto la formula magica per fare dischi con facilità.
Sembra incredibile, ma è vero: questo è il mio secondo album da solista nel giro di due anni e dopo una lunga carriera come sideman, con centinaia di dischi incisi con artisti e gruppi di livello mondiale e trasversale ai generi. Ma ti confesso di non aver trovato nessuna formula magica: è solo che in questa fase le cose mi vengono meglio, in modo del tutto naturale, e allora ho deciso di sfruttare tale flusso. Che indubbiamente è frutto di molti anni di lavoro, di esperienza: l’insieme viene dal suono che ascolto nella mia testa, lo traduco attraverso il piano e gli arrangiamenti. Certamente oggi le cose sono facilitate da programmi, software e applicazioni che mi permettono di sviluppare molto più velocemente le idee, l’integrazione di ritmi, l’elaborazione armonica. Rimangono però stabili le diverse modalità da cui nascono le mie ispirazioni compositive: a volte mi siedo al pianoforte e sento un certo disegno ritmico o una melodia oppure un suono armonico, e questo vale per ogni tipo di musica in cui mi muovo, nel latin, nella salsa e anche quando scrivo per altri interpreti. Io poi sono sempre più convinto che l’abilità creativa è dovuta anche al talento che il Signore mi ha dato per sviluppare la musica che ho ascoltato fin da piccolo attraverso i protagonisti più grandi del firmamento salsero e del jazz di impronta latina che praticavano e si esibivano nel Barrio. La New York latina era una calamita per tantissimi musicisti latinoamericani e tutti assieme l’hanno trasformata nella mecca di tutti gli stili musicali e ritmi afro-caraibici, venendo a mancare Cuba perché oscurata dal mercato dopo il trionfo dei Barbudos castristi. Il Barrio poi è stato un laboratorio che ha consentito a tanti giovani di sperimentare nuove sonorità mescolando culture di comunità differenti e in quel crogiolo ho sviluppato la mia dimensione artistica e spirituale. Quindi è stato naturale scrivere pezzi come Latino Jazz e Danzón For Lisa, due delle mie dieci composizioni di «Love The Moment». Quello è un progetto in linea con il mio modo di fare latin jazz.
 In Danzón For Lisa la violinista Dayren Santamaria e il flautista Justo Almario fanno rivivere la tradizione tipica della charanga cubana e lo spirito danzonero con due assoli disegnati sul montuno del danzón che poi sfocia in cha cha. Da qui si capisce che la tua cifra continua a svilupparsi nel solco del jazz en clave. É così?
In Danzón For Lisa la violinista Dayren Santamaria e il flautista Justo Almario fanno rivivere la tradizione tipica della charanga cubana e lo spirito danzonero con due assoli disegnati sul montuno del danzón che poi sfocia in cha cha. Da qui si capisce che la tua cifra continua a svilupparsi nel solco del jazz en clave. É così?
Consentimi di spendere due parole su Dayren Santamaria, talentuosa musicista cubana cresciuta a Matanzas, di formazione classica, che ha suonato con la Camerata Romeu prima di trasferirsi a Tampa e poi a Los Angeles dove risiede da dieci anni. Non ha ancora raggiunto la popolarità che meriterebbe ma intanto le ho dato una mano come produttore e arrangiatore di un disco che si chiama «Belleza» e del progetto fa parte anche il bravissimo bassista Carlitos Del Puerto jr. Sul mio stile di Latin o cifra come la chiami tu non saprei dirti se ci sono delle caratteristiche diverse rispetto a quelle di altri solisti: forse io ci metto c’è meno percussività, ma non ne sono certo. La vera differenza del mio latin (ma anche della salsa con la SHO) direi che la fa il mosaico dei virtuosi strumentisti latinos che lavorano con me. Musicisti misconosciuti, tranne Almario, ma ti garantisco che danno del filo da torcere ai nomi più blasonati dei loro rispettivi strumenti. E un esempio scintillante l’hai fatto evidenziando il pezzo in stile charanga con due raffinatissimi assoli: musica per palati finissimi.
Fuori dal jazz c’è un artista con il quale gradiresti assolutamente incidere?
Ne avrei alcuni, ma il primo è Sting, un cantante geniale che ammiro per il suo ampio concetto di fare musica.
Sono un po’ stupito, e sai perché? E’ lo stesso desiderio di un altro boricua, il trombettista e bandleader Charlie Sepúlveda. Insomma, questa coincidenza interessante mi spinge a chiederti se credi in un Potere Superiore, per non dire Dio?
Effettivamente è curioso, Charlie è un amico e non ci vediamo da tantissimo tempo, lui adesso vive e suona a Puerto Rico e quindi si tratta di pura casualità. Io credo fermamente in Dio, sono cristiano ma un po’ critico verso il cattolicesimo nel quale sono cresciuto, è un discorso lungo che al momento tralasciamo.
Parliamo allora di Caraibi e delle due principali isole protagoniste del Jazz en Clave. La tua musica si mantiene sempre in bilico tra San Juan e L’Avana, due realtà di uno stesso mondo e che mi richiamano alla mente alcuni versi della poetessa portoricana Lola Rodríguez de Tió (morta a Cuba): «Puerto Rico e Cuba sono le due ali di un passero, ricevono fiori e pallottole nello stesso cuore». Li condividi questi versi? Puerto Rico è la terra dei tuoi antenati e spesso ci torni. Ma nella culla dell’afrocuban jazz e del son, se ci sei stato cosa ne pensi?
Vagamente ricordavo questi versi ma mi emozionano perché esprimono verità e ne condivido l’essenza anche se alcune cose hanno preso indirizzi diversi. A Cuba sono andato nel lontano 1995 al Festival Jazz dell’Avana con la band Seis del Solar, formazione con cui abbiamo inciso due dischi. Detto ciò, la realtà cubana, per quel po’ che visto, mi ha affascinato e soprattutto mi ha colpito lo spirito incrollabile di quel popolo nell’affrontare la vita quotidiana nonostante le dure difficoltà economiche e sociali che attanagliano il Paese da diversi decenni.
E invece nella Patria di bomba e plena, la Isla del Encanto dei tuoi genitori, che è più democratica rispetto al regime collettivista di Cuba, non hai mai pensato di andarci a vivere?
A Puerto Rico sono andato moltissime volte a suonarci e in vacanza poiché i miei erano nativi di quella terra, ma non mi piace la realtà politica che si respira nonostante la cittadinanza statunitense e altri vantaggi. Con Trump non so come andranno avanti le cose e non essendo in grado di leggere il futuro e tantomeno la politica, preferisco vivere al presente, senza dare troppi giudizi e crearmi delle aspettative perché in definitiva non mi conviene.
 Due isole divise da sistemi differenti, ma possiamo considerarle unite dalla salsa, come forma di evasione e liberazione? A Cuba nel «periodo especial» (anni Novanta) ha regnato la Timba, ritmo ballabile con arrangiamenti orchestrali molto elaborati e con testi graffianti contro i burocrati del governo: in questo trovi delle similitudini con la salsa degli albori? Ho letto poi che la tua SHO vuole preservare e diffondere la salsa dura. Ma da musicista cresciuto in quel laboratorio speciale, ti chiedo se le innumerevoli varianti di salsa ossia brava, gorda, romantica o erotica esprimono delle differenze sostanziali tra loro o è come dire «aria fritta» per gli allocchi scaturita dalle fantasie di insegnanti di ballo o di salseros creativi?
Due isole divise da sistemi differenti, ma possiamo considerarle unite dalla salsa, come forma di evasione e liberazione? A Cuba nel «periodo especial» (anni Novanta) ha regnato la Timba, ritmo ballabile con arrangiamenti orchestrali molto elaborati e con testi graffianti contro i burocrati del governo: in questo trovi delle similitudini con la salsa degli albori? Ho letto poi che la tua SHO vuole preservare e diffondere la salsa dura. Ma da musicista cresciuto in quel laboratorio speciale, ti chiedo se le innumerevoli varianti di salsa ossia brava, gorda, romantica o erotica esprimono delle differenze sostanziali tra loro o è come dire «aria fritta» per gli allocchi scaturita dalle fantasie di insegnanti di ballo o di salseros creativi?
La Timba cubana mi piace molto ma non è salsa: musicalmente è un linguaggio molto più complicato, suonato da eccellenti strumentisti e concordo sul fatto che esprimesse il disagio di quartieri “difficili”. Punti di contatti con la salsa delle origini ci sono indubbiamente. Parlando invece di salsa: io ho rispetto per tutti i salseros, ma le tue ultime parole su tali sfumature credo che siano giuste. Per esempio noi con la SHO suoniamo salsa dura, ossia uno stile che in qualche modo si collega alle musiche di Tito Puente, Machito, Ray Barreto, Tito Rodriguez, un sound robusto che non ha nulla di pop. Non mi piacerebbe farlo, ma mi sbilancio un po’ per non sfuggire alla domanda: i romantici della salsa, ad esempio, per me sono Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Victor Manuel, Eddie Santiago e tanti altri, ma non si possono paragonare musicalmente alla SHO, che ha arrangiamenti molto elaborati melodicamente e armonicamente, ritmi più marcati e meno commerciali, e lo ripeto, senza i colori del pop! Inoltre la SHO è considerata da moltissimi la migliore orchestra a livello mondiale di questo genere a cavallo tra salsa e jazz.
E tra il jazz e il Latin jazz quali differenze ci sono secondo te?
Il latin jazz è sostanzialmente jazz elaborato su ritmo afro-latino, ma per suonarlo bene è fondamentale conoscere i ritmi latini. E ti dirò di più ma senza generalizzare: se prendi un jazzista che suona soltanto jazz e lo metti dentro un ambiente Latin ,il più delle volte quel musicista fa cilecca perché non é abituato a concepire quel tipo di swing latino. Al contrario la maggioranza di noi jazzisti latinos sappiamo destreggiarci meglio con il jazz perché ne abbiamo studiato la tradizione, la storia, la granmatica e io lo sto ascoltando da sessant’anni. A diciott’anni, quando iniziai la carriera musicale, io suonavo già moltissimi standard di jazz e i bandleader mi mettevano alla prova ogni sera.
Quali sono i club jazzistici di Los Angeles e dintorni che frequenti o dove suoni quando non sei in tournée?
I principali clubs di Los Angeles sono il Catalina’s Jazz Cafe, The Blue Whale, LACMA Music series, Just Jazz Music Series /Mr. Music Head Gallery e Vitellos. Comunque con il nostro gruppo suoniamo poco a Los Angeles nonostante ci sia una ricca scena musicale di salsa: io non posso accettare di andare ovunque a suonare con dei compensi davvero molto bassi. A fronte di queste condizioni non siamo disponibili a suonare, sono cifre davvero ridicole. E allora preferisco fare meno serate ma dignitose. Poi con la SHO facciamo solo tour in tutti gli States e all’estero e abbastanza in area ispanica.
Ma quali sono i paesi dell’ America Latina dove accolgono particolarmente bene i tuoi progetti? E stai progettando qualcosa di nuovo?
A parte Puerto Rico, i paesi sudamericani che apprezzano maggiormente i miei progetti sono la Colombia e il Messico, che contrariamente a quanto si pensa è un paese con grandi cultori di musica, e qui la SHO è acclamatissima dal pubblico. Nel mese di aprile del 2020 con la SHO uscirà il titolo «The Latin Jazz Project», disco che è già stato registrato e presentermeo anche in Europa e speriamo di venire anche in Italia, dove l’ultimo concerto l’abbiamo fatto circa cinque anni fa al festival Latinoamericano di Milano.
E quale musica ascolti ultimamente?
Come vedi distaccarmi dalla musica è difficile, ma quando posso mi piace visitare musei e seguire lo sport. Ascolto di tutto, jazz, classica, latin, ma anche artisti pop come Bruno Mars, che attualmente è uno dei miei preferiti.
Gian Franco Grilli
Vietata la riproduzione dell’intervista senza previa autorizzazione.



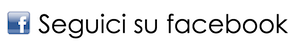






 Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.
Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.












 presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.
presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.