MARCO PIGNATARO, il global jazz del bostoniano di Bologna

Da una dozzina di anni il musicista bolognese Marco Pignataro è diventato “bostoniano” per dirigere i programmi del Berklee Global Jazz Institute che puntano a migliorare la società civile e il Pianeta a suon di jazz. L’abbiamo raggiunto per farci raccontare la sua vicenda umana e artistica (nata sotto le Due Torri ma quasi del tutto sconosciuta ai felsinei). Tra i suoi ultimi lavori, il bellissimo album “Almas Antiguas” e il progetto “Jazz for The Planet”, come contributo alla salvaguardia della biodiversità e che sarà presentato virtualmente il 1° novembre 2021 alla Conferenza Internazionale di Glasgow.
Intervista di Gian Franco Grilli, condivisibile esclusivamente con il mensile Musica Jazz.
Vietata la riproduzione
MARCO PIGNATARO, il global jazz del bostoniano nato a Bologna
Sassofonista, compositore e docente, Marco Pignataro è dal 2009 il braccio destro del pianista panamense Danilo Pérez, direttore artistico del Berklee Global Jazz Institute (BGJI). Nonostante questo importantissimo incarico e prestigiose collaborazioni (Eddie Gomez, John Patitucci, Joe Lovano, George Garzone, Billy Drummond, Brian Lynch, Adam Cruz…), Pignataro è purtroppo poco conosciuto anche nel microcosmo dei jazzofili di Bologna, città dove invece è nato, cresciuto e ha sviluppato i suoi primi interessi musicali tra punk-rock, musica classica e jazz prima di fare il grande salto verso Boston passando prima per Miami e San Juan di Puerto Rico. Il suo nome non circola nemmeno nell’ambiente jazzistico perché si allontanò da Bologna e dall’Italia oltre trent’anni fa e l’unico musicista italiano che invece conosce bene il protagonista di questa intervista è il pianista Teo Ciavarella «di cui sono molto amico – ci spiega subito Pignataro – e con il quale ho fatto concerti in Sudamerica e alla Berklee. La nostra collaborazione di lunga data mi portò a suggerire il nome di Teo al bandleader Eddie Gomez per un tour di qualche anno fa in Italia con un quintetto dove imbarcammo anche il batterista Massimo Manzi. Con quella formazione, più Matt Marvuglio al flauto, registrammo nel 2009 al Groove Factory di Castelmaggiore (Bologna) il cd «Per Sempre» pubblicato con l’etichetta losangelina BFM Records. Mentre in Italia non saprei dirti che risposta commerciale ha avuto, negli Stati Uniti il disco andò benissimo come vendite e con bellissime recensioni. Tra i brani ci sono anche due mie composizioni e di cui una si chiama Bologna d’Inverno». Solo un paio di dischi incisi finora come bandleader tra cui «Almas Antiguas», album davvero molto bello che ci spronati ad avvicinare questo simpatico e talentuoso musicista, dirigente anche di una delle più autorevoli accademie jazz del mondo. Orgoglioso della sua molteplice identità emiliana-partenopea-portoricana-statunitense, Marco è animato da una profonda sensibilità ambientale, preoccupato per gli effetti del cambiamento climatico, il riscaldamento globale e come suo contributo utilizza il jazz, potente mezzo artistico per iniziative in difesa del Pianeta e della biodiversità. Con il Marco Pignataro Jazzet completato da Terri Lyne Carrington (batteria), Joe Lovano (sax), John Patitucci (basso), Chico Pinheiro (chitarra), Anastassiya Petrova ( pianoforte) e Nadia Washington (voce) ha appena realizzato “Jazz for The Planet”, concerto live registrato con i patrocinio della rinomata Fondazione Tällberg interpetando sue composizioni originali, di John Patitucci e di Joe Lovano. Il concerto sarà presentato in anteprima virtuale alla Conferenza internazionale di Glasgow sui cambiamenti climatici il 1° novembre 2021 e successivamente negli Stati Uniti, in Africa e in Giappone. Nell’attesa vi suggeriamo questa lunghissima, ma utile e anche divertente chiacchierata esclusiva per MiCaribe e Musica Jazz.
Qualche tempo fa, Danilo Pérez nell’illustrarmi il Berklee Global Jazz Institute di Boston (BGJI) mi disse che al suo fianco c’era l’italiano Marco Pignataro. Quando mi sottolineò che eri bolognese io caddi letteralmente dalle nuvole. Turbato da questa mia grave lacuna, realizzai un veloce sondaggio tra addetti ai lavori e mi resi conto che, salvo un paio di eccezioni, non ero l’unico “sprovveduto” e soprattutto sotto le Due Torri. Marco, dopo questa confessione e ammissione di colpa, partirei proprio omaggiando il pianista panamense che mi ha permesso di scoprirti: come e quando sei arrivato a collaborare con Danilo Pérez?
Mi piace la storia che racconti, ma ti sentirai giustificato e assolto quando tra poco ti spiegherò alcuni dettagli importanti sul mio conto. Intanto ti dico subito che conobbi Peréz circa diciassette anni fa a Puerto Rico, nella capitale San Juan, dove io stavo dirigendo il Programma di Musica Jazz e Caraibica in quel conservatorio che oltretutto ha una storia molto interessante: fu fondato negli anni Cinquanta dal violoncellista e compositore catalano Juan Pablo Casals, il quale allo scoppio della Guerra civile spagnola si rifugiò a Puerto Rico dopo essersi nettamente schierato contro la dittatura spagnola dei franchisti.
Storia interessante! Ma a Puerto Rico il jazz si studiava già nel Conservatorio?
Giustissima osservazione. Infatti per inquadrare la situazione, bisogna fare un passo indietro e tenere presente che i Conservatori da quelle parti erano molto più rigidi e arretrati rispetto quelli italiani in fatto di aperture verso nuove espressioni musicali, e quindi niente jazz. Accadde invece che due anni prima del mio arrivo a Puerto Rico i dirigenti del conservatorio avevano invitato Danilo Peréz per tracciare un percorso sul jazz e alla fine questo musicista formidabile, ma anche eccezionale uomo dotato di spirito umanitario, con il suo carisma riuscì ad aprire il primo dipartimento di jazz in quel conservatorio. Poi Danilo ritornò a San Juan, per una serie di concerti e attività educative, andai ad ascoltarlo, gli parlai e lui venne a vedermi suonare in un locale del centro storico della città: da quella sera incominciò tra noi una collaborazione magnifica che dura appunto da diciassette anni, e su più fronti. Abbiamo suonato insieme varie volte e per me fu fondamentale il Panama Jazz Festival dove fui invitato alla terza edizione dalla Fondazione di Danilo che organizza la manifestazione. Altro momento impagabile in questo rapporto fu quando mi consigliò di presentarmi al concorso per un nuovo progetto del Berklee College: così dal 2009 lavoriamo assieme nel BGJI dove Danilo è il direttore artistico, mentre io sono il direttore esecutivo, una sorta di amministratore delegato e curo anche vari aspetti del programma con i docenti.
 Com’è Danilo Perez nel ruolo di direttore? E poiché sei uno dei pochi italiani che ha suonato al Panama Jazz Festival ti chiedo la tua impressione su quella rassegna?
Com’è Danilo Perez nel ruolo di direttore? E poiché sei uno dei pochi italiani che ha suonato al Panama Jazz Festival ti chiedo la tua impressione su quella rassegna?
Lavorare al fianco di un genio come Danilo è interessantissimo: noi siamo diversi in tante cose ma ci completiamo, collaboriamo sviluppando un concetto abbastanza rivoluzionario a livello pedagogico in quanto apre delle strade agli studenti una volta terminati gli studi. Il nostro è un lavoro di gruppo e io cerco di dare praticità alla grande visione artistica di Peréz, e se vuoi possiamo parlare anche dei progetti del BGJI. Riguardo al Panama Jazz Festival, che si svolge in gennaio, posso dire che si tratta di un evento internazionale che va oltre la musica perché non è solo intrattenimento sonoro, ma coinvolge tutta la realtà sociale attraverso momenti di condivisione culturale tra musicisti internazionali, giovani artisti locali, studenti e pubblico. E anche qui emerge su tutto un ottimo lavoro educativo.
Prima di questo tuo approdo definitivo nelle Americhe, credo ci sia stato dell’altro tra le Due Torri e Puerto Rico: è giusto?
Hai ragione e forse è meglio spiegare la mia vicenda umana e artistica facendo salti in avanti e indietro. Nel 1991 dopo aver terminato studi classici al Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena (all’epoca era una sezione staccata del Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna) andai a studiare jazz nell’Università di Miami e lì cominciai a suonare professionalmente nei club della città. Andò avanti così per circa dieci anni. In quegli anni il Conservatorio di Puerto Rico aprì una cattedra di sassofono classico e di educazione musicale e poiché io desideravo fare nuove esperienze e studiare anche la musica latina decisi di partecipare al concorso aggiudicandomi così quella cattedra. Grazie poi al solco iniziale tracciato due anni prima da Danilo Pérez, come detto poc’anzi, incominciai a creare un programma sul jazz e sulle musiche latinoamericane realizzando un centro musicale tra i più importanti della vasta area sudamericana. Questo mi consentì di viaggiare molto in America latina, dal Messico a Panama, dalla Repubblica Dominicana alla Costa Rica per fare audizioni, suonare e accompagnarvi dei miei studenti.
Tra Bologna e Cesena studiavi musica classica e per capire il jazz sei volato a Miami. E perché non scegliere Parigi, Boston o New York?
Al conservatorio studiavo il sax alto, mentre parallelamente e privatamente prendevo lezioni di tenore da Renato D’Aiello, napoletano che viveva a Bologna, un tipo superattivo, bravissimo a mio parere e poi portava numerosi jazzisti in città, dove tra l’altro si facevano già notare giovani promesse come Piero Odorici, Carlo Atti e altri ancora: eravamo a metà degli anni Ottanta. D’Aiello, che considero il mio primo maestro di jazz, tra l’altro ricordo che aveva vinto una borsa di studio a Boston, ma invece preferì Bologna creandovi un bel movimento di giovani artisti e anche una big band nella quale suonai anch’io. Ricordo delle serate al Chet Baker jazz club di via Polese e in altri locali bolognesi; comunque D’Aiello era diventato insegnante di tutti i giovani sassofonisti emergenti e tra questi, ad esempio, c’era Achille Succi di cui ero molto amico.
 Il Chet Baker, che hai appena citato, e quel “clima” mi richiama alla mente che verso la fine degli Ottanta circolava in città un sassofonista statunitense, che a suo tempo era stato partner di Chet, di Miles Davis, poi di Petrucciani e altri big, sempre se non ricordo male. Hai capito di chi sto parlando?
Il Chet Baker, che hai appena citato, e quel “clima” mi richiama alla mente che verso la fine degli Ottanta circolava in città un sassofonista statunitense, che a suo tempo era stato partner di Chet, di Miles Davis, poi di Petrucciani e altri big, sempre se non ricordo male. Hai capito di chi sto parlando?
Ma certo, e me lo stavo dimenticando, stavi parlando del grande Steve Grossman che viveva a Bologna, un sassofonista micidiale con una straordinaria musicalità e capace di ibridare Coltrane e Rollins, una vera cattedra di jazz per tutti noi. Ho avuto il privilegio di prendere diverse lezioni da Steve, oltre che da Aiello. Ricordo che con Piero Odorici, Carlo Atti ed altri eravamo tutti alunni di Grossman, una grandissima influenza per tutti e la sua casa poi era diventata un punto di riferimento, una specie di “mecca” del bebop locale. Piero e Carlo erano già molto avanti rispetto a me. Comunque Grossman ha lasciato un’impronta particolare a tutti gli allora giovani jazzisti bolognesi.
Il doveroso quadretto jazzistico bolognese è interessante e utile, però ci siamo allontanati da Miami, cioè non hai risposto alla mia domanda.
Effettivamente l’ho presa un po’ larga sui miei anni bolognesi prima di partire nel 1991 verso la Florida. Avevo fatto l’esame di ammissione all’Università di Miami, che allora aveva uno dei programmi di jazz più importanti degli Stati Uniti e con un ottimo dipartimento storico di jazz: lì si erano preparati dei grandissimi come Pat Metheny, Rick Margitza, sassofonista meraviglioso che adesso credo che viva a Parigi, e se non sbaglio anche Jaco Pastorius studiò in quel dipartimento di cui si sapeva pochissimo dalle nostre parti, mentre sulla bocca degli esperti c’era esclusivamente il Berklee. E’ vero, verissimo che tanti andavano anche a Parigi, ma io andai in America per varie ragioni che allora mi frullavano in testa come il fatto incontrovertibile sull’origine del jazz e allora quale posto migliore che non andare negli Stati Uniti. A questo punto, avendo in tasca (si fa per dire) due borse di studio, una della Berklee di Boston e l’altra dell’Università di Miami, optai per quest’ultima sede in quanto più vicina a Puerto Rico, isola dove prima o poi speravo di andare a studiare meglio i ritmi latinoamericani. Avevo 25 anni e ricordo ancora non solo il giorno che andai in un’agenzia di viaggi a Bologna, ma anche lo sbigottimento dell’impiegata quando le dissi che volevo acquistare un volo di sola andata per Miami.
Presumo che tu avessi già le idee chiare, un buon bagaglio culturale, la padronanza della lingua e una copertura economica, è così o sbaglio?
Macché, non sapevo un ca…volo di niente, parlavo un inglese supermaccheronico, il portafoglio era magrolino, ma oramai avevo questa molla dentro. Sono cose che fai da giovane e posso dirti che ero completamento andato fuori di testa, in senso buono. Allora non esisteva internet e cercavo dappertutto il modo di andarmene via inviando delle musicassette con un paio di brani interpretati da me. E pensa che dalla prima lettera che mandai da Bologna all’Università Miami al giorno della mia partenza erano passati due anni, mentre adesso si risolve tutto in tre mesi. Quindi riuscii a vincere una borsa di studio, partii per Miami dove ho vissuto dieci anni, poi mi trasferii per sette anni a Puerto Rico e da lì, come ti ho raccontato all’inizio, nel 2009 mi sono stabilito a Boston dove vivo tuttora.
Torniamo a Bologna. Parlaci della tua infanzia, dei primi passi musicali, insomma regalaci un piccolo autoritratto.
Questa è la carta d’identità: Marco Tullio Pignataro, nato a Bologna il 2 dicembre 1965, cresciuto vicino alla meravigliosa chiesetta di Casaglia, perché a mio padre piaceva stare sui colli, a due passi dal Colle della Guardia dove c’è il santuario di San Luca. Ho fatto tutti gli studi, dalle elementari al liceo, presso l’esclusivo Collegio San Luigi di via D’Azeglio, vicinissimo a Piazza Maggiore. Quindi tutta la mia infanzia e la gioventù con tantissimi amici l’ho vissuta sotto le Due Torri, una realtà che mi manca da morire, un posto pazzesco, e dopo aver girato il mondo mi rendo conto di quanto Bologna sia straordinariamente bella. In famiglia non c’era nessun musicista ma si ascoltava moltissima musica: mio padre, di origine napoletana, amava la buona musica; mia madre, portoricana, mulatta, ovviamente ci faceva sentire musica latina.
PUERTO RICO, già. Ecco trovato il bandolo che chiarisce il tuo amorevole percorso verso l’isola caraibica, alcune scelte maturate in un ambiente come quello bolognese. Tra l’altro, apro una parentesi, è già una notizia sapere di una donna portoricana a Bologna all’inizio degli anni Sessanta e direi rarissimo vedere in quegli anni una mulatta circolare nel capoluogo emiliano. Cosa ne pensi?
Non ci avevo mai pensato, ma probabilmente era così come hai detto tu. Forse era la prima portoricana in città e stiamo parlando della fine degli anni Cinquanta perché i miei genitori si erano conosciuti all’Expo di Bruxelles (1958) dove mia madre rappresentava la sua patria e mio padre era lì come visitatore.
Storia abbastanza curiosa e comunque di qualche interesse.
Debbo dire che le storie di mio padre mi hanno sempre fatto ridere, e quella pagina portoricana poi è magnifica: un bel giorno il babbo disse a suo padre, cioè mio nonno, che sarebbe andato a Puerto Rico a sposare una bellissima ragazza. All’istante il nonno, da buon napoletano, pensò che suo figlio fosse impazzito poiché lui non sapeva nemmeno dove e se ci fosse stato quel luogo nella cartina geografica (Marco, ride!), Puerto Rico?. Il viaggio deve essere stato una vera avventura perché si doveva passare da New York su un aereo con le eliche eccetera…. Mio padre si sposò quella ragazza, la portò a Bologna.

Marco Pignataro e il pianista cubano Chucho Valdés
Non vorrei avere perso un passaggio. Il nonno era napoletano e tuo padre?
Mio babbo da Napoli si trasferì a Bologna poiché faceva il designer di scarpe e tutta la famiglia paterna era abbastanza famosa nel mondo delle calzature così qui si stabilirono. Tornando a quel viaggio verso Porto Rico, dobbiamo tenere presente che in quegli anni erano di moda i ritmi latini e allora mi è passato qualche volta per la mente il dubbio che quella storia fosse stata favorita da una infatuazione legata a quei ritmi sensuali. Riflettendo poi meglio con il passare del tempo ho dedotto che a mio padre non gliene fregava un bel niente del jazz afrocubano, del cha cha chá, del mambo, del bolero, della bomba ecc. ma a lui interessava soltanto mia madre, che l’aveva fulminato! Inoltre quando penso alle storie che lui mi raccontava, mi scappa ancora da ridere immaginando un napoletano che va a Puerto Rico perché in quegli anni era andare a scoprire veramente l’America, un confronto di culture così diverse eccetera. Per me era comunque divertente solo pensare a quelle situazioni affrontate da mio padre.
Se vogliamo dirla tutta, oggi (e forse anche sessant’anni fa) ritengo che un napoletano verace non abbia nulla da invidiare in fatto di vivacità a un cubano o a un caraibico. Per questo, e dico forse, i napoletani che sbarcano all’Avana, San Juan o a Santo Domingo si inseriscono in quelle realtà esotiche molto meglio di tantissimi italiani del nord.
Credo che tu abbia proprio ragione, perché ci sono delle connessioni tra queste realtà, e senza generalizzare aggiungerei che i cubani che ho conosciuto, rispetto ai dominicani e ai portoricani, sono sveglissimi, “intraprendenti”, di grande ritmo e anche dinamici allo stesso modo dei napoletani.
Apriamo una piccola parentesi sul Latin. Quando da Miami decidesti di spostarti a San Juan eri già ferrato sulle sonorità boricua e afrocaraibiche?
Per nulla, in quegli anni non conoscevo niente di jazz latino e quello che ascoltavo su questo versante era la musica salsa, la musica popolare e tradizionale latina che piaceva a mia madre in gioventù. Quei ritmi e suoni erano comunque legati alla mia infanzia perché da Bologna tutte le estati mia madre ci portava un paio di mesi a Puerto Rico e così succedeva che gli amichetti bolognesi mi avevano soprannominato “il portoricano”. In tutti quei mesi caraibici da bambino non imparai a suonare nessuno di quegli strumenti tipici, a percussione, però ero attratto dai ritmi afroportoricani più noti come la bomba o la plena, mi piacevano musicisti come Luis Perico Ortiz, ma non suonavo ancora nulla.
Qual è stato il tuo primo strumento musicale?
Comprai una chitarra nel negozio Borsari & Sarti di via Farini, a Bologna, quando avevo tredici anni e iniziai così a prendere lezioni di chitarra classica. Poi mi innamorai della musica rock che circolava in quel periodo in Italia. All’inizio degli anni Ottanta venivano gruppi punk dall’estero, ma a Bologna c’era un movimento straordinario di punk rock. Ti ricordi gli Skiantos? Ma io tifavo per i Gaznevada, gruppo storico il cui chitarrista era Ciro Pagano (Robert Squibb) e pensa che tutte le settimane andavo a lezione a casa sua in via Torino. Così mi innamorai dell’ambiente rock bolognese, del new wave e Bologna era un po’ la capitale italiana di questa nuova ondata musicale.
Insomma, seguace di una musica abbastanza surreale, a mio modesto avviso, che si muoveva dentro il movimento della contestazione e che di jazz non aveva un bel nulla. E allora quando e come avvenne il tuo avvicinamento alla musica afroamericana?
Infatti in quel periodo il jazz non l’ascoltavo proprio, ero completamente immerso nella realtà giovanile bolognese del rock e dell’underground. Possiamo dire che galeotto fu il sassofono come porta d’entrata al jazz, e ti spiego con chi e quando. A metà del Sessanta, quando io non ero ancora nato o giù di lì, mio padre aveva comprato lo storico ellepì di «Getz/Gilberto featuring Antônio Carlos Jobim» che giaceva nella sua raccolta. Non so come sia successo ma un bel giorno degli anni Ottanta rimasi fulminato dal suono del sassofono di Stan Getz che usciva dal giradischi di mio padre. Non conoscevo il nome di Getz, non sapevo niente di jazz, ma da quel momento decisi di passare dalla chitarra al sassofono e mi iscrissi a una scuola di musica in via Marconi di cui non ricordo il nome.
Sono sicuro che si tratta di Res-Rubini, negozio di strumenti che aveva l’entrata della scuola in via Polese, quasi di fronte al Chet Baker club, e il corso di sassofono lo teneva lo statunitense Michael Brusha, che tra l’altro si diplomò qui al conservatorio di Bologna. Vuoi altri dettagli? Michael, i cui nonni erano di origini siciliane, è ancora attivo come insegnante della scuola Merry Melodies, ha una big band. Posso testimoniare che quando sbarcò a Bologna manifestò desiderio di saperne un po’ di più di ritmi afrolatini, di clave, del martillo boleristico, di bongo, congas eccetera. Così tra un tortellino e un bicchier di vino lo illuminai un pochino sui fondamentali di quei ritmi esotici.
Caspiterina, è incredibile quello che mi racconti, ma come fai a conoscere tutto questo? Questi dettagli non li sapevo, magico. Io comprai appunto il primo sax da Rubini e iniziai a studiarlo proprio con Brusha, il primo maestro che mi insegnò a leggere la musica, le basi della teoria musicale, i primi rudimenti del sassofono, perché fino a quel momento suonavo la chitarra rock ad orecchio e non avevo mai letto una nota. Mi preparò per l’esame di ammissione al conservatorio di Bologna per studiare sassofono classico e poiché i posti erano limitati mi accettarono come allievo al Conservatorio Bruno Maderna di Cesena dove studiai per cinque anni con il professore di sassofono Gilberto Monetti. Comunque, come già detto, studiavo privatamente sia con Renato D’Aiello che con Grossman quando decisi infine di iscrivermi al dipartimento jazz di Miami, anche se a Bologna tutti conoscevano il Berklee di Boston e alcuni dei loro manuali di tecniche jazz.

Teo Ciavarella, Marco Pignataro, Massimo Manzi , Eddie Gomez
A Bologna con quali metodi di sassofono studiavi? Per caso ti sei preparato con testi come quelli della Berklee Series –Saxophone di Joseph Viola e Andy McGhee? Oppure con la serie di Metodi Play-A-Long di Jamey Aebersold?
Diciamo prima questo: diplomarsi al conservatorio ci volevano sette anni e quindi studiavo con tutti i metodi di sassofono francesi come il Marcel Mule. A quei tempi non era facile trovare i metodi giusti di jazz e allora mi affidavo a Renato D’Aeillo, mi insegnava jazz, era un musicista che suonava jazz ad orecchio. A parte questo, non dirmi che conosci quei libri fondamentali come il Viola, uno dei professori storici della Berklee e che ha fatto tre volumi per sassofono rispettivamente per scale, accordi e ritmica, e sono metodi che si usano ancora alla Berklee. Poi dell’ottantaduenne Aebersold posso dirti che l’ho conosciuto e lui ha fatto una fortuna con quei metodi che tutti usavamo. Di Viola ti racconto una storia che ho a mia volta raccolta da Emilio Lions, un salernitano emigrato negli Usa negli anni Cinquanta quando aveva diciassette anni e qui è diventato uno dei più importanti riparatori di strumenti a fiato, soprattutto espertissimo di sassofoni. E pensa che moltissimi grandi musicisti del mondo sono stati suoi clienti: ad esempio jazzisti come Stan Getz, Sonny Rollins, Wayne Shorter, Paquito D’Rivera. Comunque ogni volta che vado da Emilio mi racconta una sacco di aneddoti su Stan poiché erano molto amici e tra loro c’era molta confidenza. Un aneddoto bello su Getz riguarda il periodo che voleva dedicarsi al soprano e allora quando chiese a Emilio il nome di un insegnante per prendere qualche lezione, senza tanti indugi lo mandò da Viola, ma alla fine sappiamo che Getz non si espresse molto con il soprano. Questo per dire dell’importanza di Viola, una celebrità del sax.
Ma negli anni bolognesi, cioè tra Settanta e Ottanta, hai conosciuto dei jazzisti diciamo della vecchia guardia bolognese che cito a memoria, Sergio Mandini, Annibale Modoni, Marco Di Marco, Piergiorgio Farina, Nardo Giardina, Checcho Coniglio, Henghel Gualdi, Gustavo Pallotta, Silvano Salviati, Enzo Gilioli, Enzo Minuti, e ancor prima un eccellente sassofonista- violinista di nome William Righi?
Sorbole ragazzi, pazzesco, purtroppo devo confessare che quel mondo precedente non lo conosco bene, erano jazzisti di generazioni diverse dalla mia e poi il jazz per me è arrivato dopo il punk rock, come dicevo. D’altra parte quando ero giovane vedevo il jazz come uno stile musicale, una musica molto intellettuale, invece quando arrivai negli Usa mi accorsi subito che qui il jazz è una musica molto legata alla cultura afroamericana, e per loro, estremizzando il concetto, è un po’ come la nostra musica leggera. All’Università di Miami c’erano dei ragazzini neanche ventenni (io ne avevo già venticinque) che suonavano come dei dannati perché negli States il jazz lo studiano da giovanissimi. Quando cominci a conoscere questa musica capisci molti aspetti del jazz dal punto di vista culturale, come espressione di un popolo molto legato a un certo modo di pensare e di vivere. Sono molto contento della scelta fatta a so tempo anche se all’inizio fu durissima. Cominciai poi a vedere il tutto sotto un altro punto di vista e questo mi ha cambiato la visione di come capisco il jazz, un cambio che fu molto forte. Ricollegandomi ai metodi per suonare jazz debbo aggiungere che studiai con un sassofonista molto importante che è Gary Campbell: insegnava all’Università di Miami ed è anche uno dei quattro autori di Patterns For Jazz, un metodo che allora circolava molto anche in Italia.
Facciamo un primo parziale riassunto del percorso per non perderci: Bologna, Miami, San Juan e infine Boston, dove hai un incarico importante al BGJI e di cui ti chiedo di parlarci dei progetti e di come vengono condotti.
Danilo Peréz, che è il direttore artistico, viene praticamente una volta al mese e passa una settimana qui. Io, come direttore esecutivo, curo tutti gli aspetti giornalieri del programma, dei corsi, dettagli logistici, mi occupo della parte amministrativa ma anche didattica. Poi lavoro con tutti questi meravigliosi artisti che una volta al mese, a rotazione, vengono per una settimana a fare lezioni, che sono, oltre a Danilo, Joe Lovano, John Patitucci, George Garzone, Terry Lyne Carrington, Ben Street, Adam Cruz, insomma i professori del mio programma.
Ci spieghi la differenza tra il BGJI e il Berklee College Music?
Il BGJI è un programma specifico del Berklee College. Noi abbiamo due programmi: un programma per laurea breve e poi un master. Per la laurea, prima bisogna essere ammesso alla Berklee e poi devi fare un’audizione per entrare nel nostro programma BGJI riservato a venti studenti selezionati da noi per studiare con i nostri docenti. E’ molto selettivo e lo capisci dai numeri: alla Berklee ci sono più di quattromila studenti ma noi ne prendiamo soltanto venti nei due livelli. Il programma è fondato su due punti molto importanti: primo punto, tornare al vecchio modello di imparare il jazz non da un libro ma da un artista, imparare il mestiere suonando e non leggere un libro. Vogliamo tornare a quella tradizione orale del jazz prima della accademia, dove i ragazzi sono esposti a grandi artisti che diventano i loro mentori e gli insegnano l’arte del jazz in modo pratico e non didattico, un concetto educativo eliminando vecchie barriere. Per fare questo, ovviamente, dobbiamo scegliere dei ragazzi che abbiano già un livello tecnico avanzato. Il secondo punto è molto diverso e voglio spiegarlo bene: tu conosci Danilo, che oltre a essere un grande musicista ha una visione umanitaria molto particolare, lui crede profondamente alle potenzialità degli artisti e si batte per creare un impatto nella società non solamente con la musica…

Danilo Perez
Vuoi dire, una sfida di come l’arte, nelle sue varie espressioni, può assumere una responsabilità sociale ed eliminare le differenze?
Esattamente, la tua sintesi coincide con il pensiero ideale del BGBJ. Quindi Danilo è stato riconosciuto Artista per la Pace dall’Unesco, inoltre è Ambasciatore Culturale di Panamá e un importantissimo educatore con specifici programmi al BGJI: come direttore artistico lavora per formare nuovi “ambasciatori della musica” da inviare in giro per il mondo, ossia ambasciatori che a loro volta saranno formatori a beneficio dell’umanità. Questo significa impegnarsi concretamente per togliere i ragazzini dalla strada e dalle gang regalandogli delle lezioni di musica.
Uno spirito molto simile al Sistema, il progetto del maestro Abreu in Venezuela?
Certo, il Sistema ha un programma sinfonico-classico, invece Pérez, pur avendo una filosofia di base abbastanza vicina, lo fa con il jazz. E questo è un punto molto importante nel nostro programma: noi diamo una preparazione musicale di altissimo livello e allo stesso tempo portiamo gli alunni a suonare a Panama, al Blue Note, a New York a Parigi, ma anche nelle prigioni, negli ospedali. La mission è creare grandi musicisti ma anche leader in grado di lavorare poi su progetti innovativi per cambiare socialmente la realtà. Ti faccio un esempio: prima della pandemia sono stato in Serbia per presentare il mio disco Almas Antiguas, ma ho lavorato anche sul programma con attività didattica e sociale, abbiamo fatto un concertino per i bambini e tutto ciò punta a cambiare le cose.
Come vengono coperti i costi di queste trasferte internazionali?
Il Berklee College ha ricevuto una dozzina di anni fa una donazione da un membro del suo comitato direttivo e queste risorse alimentano il nostro programma che è tra i più importanti della Berklee, scuola che comunque economicamente gode di una situazione molto solida.
Prima di parlare del tuo disco, «Almas Antiguas», il cui titolo sprizza di Latinoamerica, ti chiedo se ti consideri più un musicista di jazz o di latin?
La musica che suoniamo la chiamiamo global jazz, che si ispira al programma, e vuol dire musica molto legata alle nostre radici, che nel mio caso è cultura mediterranea e latina mescolata al bebop, al jazz che ho studiato per anni. A proposito del disco, dico subito che non è latin jazz comunemente inteso, ma senti l’influenza latina, e chi lo ascolta riconoscerà immediatamente l’influsso italiano molto forte, tutti pezzi con melodie di un certo spessore dove spicca la mia enorme passione per il sassofonismo di Stan Getz.
Quel Getz di un periodo che fu molto criticato dai soliti puristi, da jazzofili intransigenti con il Jazz Samba e che accusarono Stan di debolezze per fini commerciali, di perdita di integrità artistica. E invece per te, galeotto fu quel sax!
Esatto, fui proprio rapito. Su quelle critiche, non condivisibili, posso solo dire che stiamo parlando del Sessanta quando io non ero ancora nato. E vent’anni dopo l’uscita di quei dischi, cioè nel momento che io scoprii Stan, non sapevo proprio nulla di quel che era accaduto tra i jazzofili con posizioni davvero poco intelligenti se penso ai preziosi gioielli musicali che sono stati e sono ancora oggi quei dischi di bossa nova, musica di una tale bellezza che… Beh, lasciamo perdere, ma sminuire quel sax, unico come sonorità, era come avere il prosciutto nelle “orecchie”, si direbbe dalle nostre parti. Ma sappiamo che i cambiamenti e le novità non tutti li metabolizzano. Continuando sul global jazz, ispirato al lavoro che facciamo a Boston, aggiungo che si tratta di una visione globale della musica perché ci interessano i ritmi africani, quelli afrolatini, le armonie europee, i concetti avanzatissimi di George Garzone eccetera. E’ un’essenza globale frutto di un approccio nuovo e diversificato.
Detto questo, il tuo «Alma Antiguas» – che tra l’altro mi è piaciuto molto per sonorità, accenti e linguaggi trasversali – sembra dunque connesso al programma BGJI: è così?
Certamente. In questo caso ho cercato di esprimere la mia italianità e la mia latinità attraverso l’essenza del jazz che deriva da lunghi anni di studio di Getz, Coltrane, Rollins e successivamente dalle influenze di Garzone e Lovano. Il mio non è più bebop, non è più musica latin, è un ibrido che viene da questa visione di ricercare espressioni musicali nuove rielaborando le culture di provenienza di ognuno di noi, e questo è anche ciò che insegniamo agli studenti. Se ad esempio un allievo dei nostri corsi viene dalla Costa Rica lo incoraggiamo a creare un nuovo sound mescolando jazz e ingredienti musicali della sua terra. Analogo discorso vale se viene da Francia, Marocco o Giappone.
Possiamo dire che all’interno dell’orizzonte della globalizzazione del jazz viene preservato anche il concetto glocal, cioè valorizzare e proteggere identità e tradizioni locali? Insomma è come cucinare nuove ricette impastando jazz e blues con aggiunta di ingredienti e aromi dei luoghi in cui ci si trova.
Direi proprio che in effetti il nostro modo incorpora e salvaguarda anche il glocal a cui non avevo pensato in questi termini. Comunque interpretiamo il mondo accettandone le varie culture con la lente del jazz. Come italiano e italo-portoricano la mia musica riflette questi caratteri identitari, caratteri però influenzati da un ventennio di studi jazzistici e l’ascoltatore se ne accorge che sono un jazzista e lavoro con l’improvvisazione.
Per tante persone dire jazz e improvvisazione non fa differenza e per questo è bene specificare che l’improvvisazione è una pratica centrale del jazz ma non esclusiva dello stesso. Perché “vedo” già mani alzate per dibattere sul tema rimandandoci alla storia della musica, antica, classica e/o moderna. A questo punto mi sembra corretto e necessario chiederti cos’è per te il jazz?
Per me l’improvvisazione nel jazz è quel momento in cui si fonde in un tutt’uno l’interpretazione e il pubblico. Poi tutto ciò che ruota attorno a questo argomento lo vedo interessantissimo ma ci vorrebbe lo spazio di un libro per parlarne. Quello che per me è jazz può essere un po’ diverso per te, ma Duke Ellington, Charlie Parker eccetera sono lì, la storia del jazz è una sola e quindi se un artista è serio deve studiarla e conoscerla indipendentemente che uno suoni global jazz o avant-garde. Una cosa però da cui un jazzista non può scappare o non può prescindere è lo studio della tradizione. Questo è ciò che fa la differenza e concordo con quanto mi disse un giorno Jerry Bergonzi: «Quando studi questa musica e la sua storia, il suo insieme diventa parte del tuo dna», e quindi tutto ciò che suoni avrà sempre un po’ di quel dna. Io ho passato vent’anni studiando a fondo questa musica facendomi un c… come del resto tutti i maestri che ci hanno preceduto. In sintesi direi così: il jazz è un’espressione artistica creativa molto aperta, però tu musicista hai la responsabilità di conoscere la tradizione, le origini.
A proposito di origine non vorrei aggiungere legna sul fuoco, perché come saprai è in corso una discussione sulla paternità del jazz, una spinosa controversia concernente l’origine e i suoi unici, e non principali, depositari di questo linguaggio. Insomma una partita tra puristi specializzati in “origini” dei fenomeni e moderni aperturisti. Tu cosa ne pensi dell’acronimo BAM inventato da Nicholas Payton e di tutto ciò che ne consegue?
Io sono molto d’accordo con chi sostiene che gran parte delle radici del jazz é afro-americana e penso sia assolutamente doveroso rispettare e studiare questo pensiero. Con Danilo Pérez e altri colleghi abbiamo fatto un tour in Africa visitando sei nazioni dell’area occidentale tra Benin, Camerun e altri paesi per studiare e ricercare le varie interconnessioni e le sorgenti di quelle musiche. Tuttavia non sono d’accordo con quel movimento quando si chiude, fa barriera, si mette di traverso e se una musica non risponde a certi canoni per alcuni di quel movimento non è jazz. Noi abbiamo invece una visione globale, studiamo la radice africana e non la puoi disconnettere, poi la storia del jazz è sempre un’innovazione che va avanti e non indietro. Pertanto il rischio di quel movimento è di diventare ultraconservatore e questo, secondo me, è contrario allo spirito del jazz, alle cui radici è necessario attenersi per rispettarle e portarle avanti. Costoro fanno un discorso intellettuale, validissimo, perché è vero che molti bianchi negli Stati Uniti vogliono disconnettersi dalla parte africana, e io non lo ritengo giusto, ma non si può nemmeno avere un atteggiamento intransigente e opposto dall’altra parte, cioè che il jazz è soltanto afroamericano. Io vedo invece l’importanza del jazz globale, una maniera di assicurare al jazz di crescere, evolversi e non cristallizzarsi.
In linea con il concetto generato dal miracoloso incontro tra Dizzy Gillespie e Chano Pozo, concetto che consentì di riscoprire una parte di africanità che nel jazz si era smarrita, con tamburi di varie forme, canti e ritmi afro-cubani. Tanto che con molto stupore anche maestri come Gillespie e Blakey presero atto di non conoscere una parte delle loro radici. Sei d’accordo?
Sono d’accordissimo, e per me quella è proprio l’essenza di quello che noi chiamiamo jazz globale, cioè che accetta tutte queste radici in una maniera progressiva per fare del nuovo. Il jazz latino allora era qualcosa di completamente diverso, poi si è trovato lo stimolo di unire le cose. E la cosa bella del jazz nasce proprio da un mix di culture tra l’Africa, New Orleans, Chicago eccetera. Il jazz va avanti se non ci si si irrigidisce. Ad esempio, il problema dei beboppari è stato quello di affermare il jazz con il bebop e basta. Ma non è vero, il bebop è una parte importante del jazz ma non ti puoi fermare lì altrimenti diventa musica “classica” o tradizione tipo il liscio romagnolo, come accennavi poco fa scherzandoci su. Quindi è importante rinnovare, e il mio concreto punto di vista sonoro lo puoi riscontrare in «Almas Antiguas».
 Benissimo, analizziamo allora il disco «Almas Antiguas», le composizioni e le varie influenze che si possono percepire.
Benissimo, analizziamo allora il disco «Almas Antiguas», le composizioni e le varie influenze che si possono percepire.
Il disco si apre con Panarea, tema scritto dall’amico Teo Ciavarella e da Flavio Piscopo, che ho arrangiato in stile global jazz con un concetto romantico, cantabile e, a mio modo di vedere, innovativo. Questa composizione la ascoltai la prima volta da Teo in occasione di un mio concerto a Bologna e quando tornai a Boston gli creai un nuovo arrangiamento, ma il tema principale resta uguale all’originale, e non è la prima volta che suono questo pezzo. Il brano é dedicato alla piccola isola delle Eolie, ma quello che voglio evidenziare è che in Panarea senti subito dalle prime note il mio punto di vista musicale, ti accorgi che siamo jazzisti molto moderni mettendo in risalto i concetti cromatici che respiriamo a Boston, voglio dire molto contemporanei come suoni.
Cioè?
Suoni contemporanei, nel senso che non senti il bebop, ma una nuova versione di bop, di hard bop, e non direi neanche più avanzato. Si comincia a sviluppare una nuova espressione in modo da non legarti a una sola tradizione o linguaggio che poi ti limita. Delle undici composizioni dell’album, sei sono mie, e poi ci sono canzoni di altri autori tra cui la napoletanissima Voce ‘E Notte che suono al soprano e George Garzone al tenore. Questo è un brano che ho completamente ristrutturato in chiave latin e con influenze nordafricane. Il terzo brano della scaletta, che è mio, si chiama Otranto, suddiviso in due movimenti, e l’ho composto dopo una tournée con Eddie Gomez nel Sud italiano: il primo movimento, denominato Il Mare, è ad andamento lento; mentre il secondo è un riferimento a Estate di Bruno Martino, con un tocco molto latineggiante, accenti di flamenco ed io entro ed esco velocemente da questa magnifica melodia. Letter to My Son è dedicato a mio figlio che stava passando un periodo personale molto difficile. Tra l’altro, per completare la mia scheda biografica, ho tre figli, e i primi due, avuti dalla moglie spagnola, sono bolognesi. Son For Lucy è dedicato alla mia seconda moglie. Poi scommetto che ti piace il pezzo di Baden Powell e Vinicius de Moraes Samba Em Preludio, brano che ho conosciuto per la prima volta nella versione italiana di Ornella Vanoni assieme a Toquinho e Vinicius.
Dal Brasile salti poi in Argentina con Alfonsina y el mar, pezzo del folklore argentino reso famoso dalla leggendaria Mercedes Sosa, ma ripreso anche da diversi jazzisti e il primo che cito a memoria è il venezuelano Ed Simon…
Quella canzone stupenda l’ho scoperta suonando in duo a Panama con Danilo Pérez e, tra l’altro, credo che lui l’abbia registrata in un suo album. Da allora me ne sono innamorato sia per la melodia che per il testo dedicato alla storia della scrittrice-poetessa Alfonsina Storni, straordinaria intellettuale argentina (di origini italiane), donna di talento e di grande dignità che, di fronte a un male incurabile, scelse di morire suicida nel Mar de la Plata.
Con Xalapa ci accompagni invece in Messico, paese che a quanto mi risulta frequenti spesso, o sbaglio?
Verissimo!. A Xalapa, città dello stato di Veracruz, ho suonato la prima volta con Eddie Gomez molti anni fa a un festival del jazz ancora prima di andare alla Berklee. E proprio attraverso questo festival mi conobbero quasi tutti i miei attuali colleghi. In quel luogo ho tanti amici e nel 2015, dopo l’ennesimo invito, al rientro pensai di scrivere una canzone per quella città molto importante nella mia carriera. Così l’anno dopo ritornai in quintetto invitando anche Teo Ciavarella, George Garzone e altri colleghi della Berklee. In duo con Teo presentai quella composizione ottenendo un’accoglienza straordinaria e chi vuole potrà vedere il concerto al Teatro del Estado nel video postato YouTube (minuto 30’15” – https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=6Et1zOy94JE).
Ho notato delle caratteristiche melodiche molto simili, una certa cantabilità, nonostante le loro diverse provenienze con un fraseggio coniato dal romanticismo che è anche alla base del bolero jazz, di certe ballad. Detto questo hai indagato anche la tradizione popolare di lingua catalana o comunque spagnola con Vou, Veri Vou, brano che conobbi molti anni fa al Dams dall’indimenticabile professore, etnomusicologo, Roberto Leydi parlando di ninne nanne. Ce ne parli?
Molto interessante e convincente quello che dici perché è la verità. Io non ho conosciuto Leydi, ma si tratta di una ninna nanna catalana, e più specificamente di Maiorca delle isole Baleari. Vou, Veri Vou me la fece conoscere un pianista della Catalogna che stava studiando nel nostro programma del BGJI: pezzo semplicissimo ma di una bellezza sconvolgente che la prima volta che l’ascoltai mi sembrò di sentire una melodia napoletana e quindi l’ho voluto nel disco per sottolineare questa dimensione mediterranea. Poi sul romanticismo e il bolero sono d’accordo con il tuo pensiero, infatti tutti i brani del disco hanno una forte componente romantica (e non intendo lo spirito della telenovela!), un’altra cosa che si è persa nel jazz.
Il tuo giudizio, a mio modestissimo parere (ma come critico lavoro sui concetti mentre voi artisti sulle forme), sembra molto forte rispetto all’argomento, non credi?
Penso di non esagerare quando dico che molto (non tutto) del jazz moderno è un po’ disconnesso dall’umanità, dalla parte romantica che può essere triste e allegra, quando sostengo che c’è molta musica cerebrale. Io ho voluto fare un salto indietro, o meglio imbastire un discorso che tornasse a questi valori musicali che il jazz ha sempre avuto. In sintesi, il filo conduttore del disco ha questa dimensione “vocale” che lega tutti i brani del disco.
Vuoi spiegare cosa significa l’aggettivo “vocale” in quel contesto?
Mi riferisco alla qualità della voce dello strumento, in questo caso del sax. E prendo spunto da un discorso su tale argomento fatto poco fa con Lee Konitz, artista che ebbe un effetto potente, impressionante su di me con la sua vocalità strumentale quando lo ascoltai nel 2009 dal vivo al Teatro dei Rozzi di Siena. Un sax che cantava. Da lì in avanti mi è venuto il pallino della voce, elemento che quelli della sua generazione tendevano ad avere creando connessioni con i cantanti. E una simile impressione su questa cognizione vocale l’ho avuta a Panama quando suonai con Wayne Shorter. Questa dimensione la sento meravigliosamente in Joe Lovano, ma lui stesso dice che ascoltava molto Caruso, e per lui i riferimenti non erano solo i cantanti jazz ma anche quelli lirici italiani. Invece quando ascolto molti giovani jazzisti questa dimensione non la riscontro se non rarissimamente. Quindi per tornare al mio disco: ho realizzato brani che mi permettessero di suonare delle melodie molto forti, e secondo me questa è la chiave del successo dell’album che è piaciuto molto in America come rileva anche la recensione di Downbeat sottolineando «che sono tantissimi i jazzisti che suonano divinamente, ma finalmente qualcuno che si collega ai temi dell’amore, dell’umanità eccetera». Questo mi ha fatto molto piacere in quanto era proprio quello che stavo cercando di fare, ascoltando solo la mia anima e non ideato a tavolino.
Nella tua produzione discografica, o nelle collaborazioni, c’è qualcosa di puramente latin? Mentre il tuo disco d’esordio come solista, «Sofia’s Heart», è ispirato da cosa?
 Parto dalla seconda domanda. «Sofia’s Heart», album di grande lirismo, è dedicato a mia figlia Sofia, nata a Puerto Rico, affetta dalla sindrome di Down e con un difetto cardiaco per cui ha subíto quattro operazioni a cuore aperto. In quel progetto, che realizzai nel 2011, avevo al mio fianco due grandi musicisti e amici come Eddie Gomez e Billy Drummond. Invece parlando di latin (ma non di scuola afrocubana) direi che è il disco uscito nel 2018 intitolato «Puerto de Buenos Aires 1933» e che abbraccia espressioni come tango, milonga, candombe combinati con il jazz. Quell’album è firmato dal batterista, compositore ed educatore argentino Guillermo Nojechowicz e l’abbiamo presentato in anteprima mondiale al Festival Jazz della Repubblica Dominicana. In questo progetto io sono ospite speciale assieme al grandissimo trombettista Brian Lynch, oltre al bassista argentino Fernando Huergo, al pianista brasiliano Helio Alves, e anche alla stupenda vocalist Kim Nazarian dei New York Voice. Ma ci tengo a sottolineare il grande significato del disco, e soprattutto questo vale per Nojechowicz, in quanto gli è stato ispirato dal passaporto di sua nonna ebrea quando fuggì con il figlio (il padre di Guillermo) da Varsavia, attraversò tutta l’Europa in treno per andare in Argentina nel 1933, il viaggio che li ha risparmiati dall’Olocausto.
Parto dalla seconda domanda. «Sofia’s Heart», album di grande lirismo, è dedicato a mia figlia Sofia, nata a Puerto Rico, affetta dalla sindrome di Down e con un difetto cardiaco per cui ha subíto quattro operazioni a cuore aperto. In quel progetto, che realizzai nel 2011, avevo al mio fianco due grandi musicisti e amici come Eddie Gomez e Billy Drummond. Invece parlando di latin (ma non di scuola afrocubana) direi che è il disco uscito nel 2018 intitolato «Puerto de Buenos Aires 1933» e che abbraccia espressioni come tango, milonga, candombe combinati con il jazz. Quell’album è firmato dal batterista, compositore ed educatore argentino Guillermo Nojechowicz e l’abbiamo presentato in anteprima mondiale al Festival Jazz della Repubblica Dominicana. In questo progetto io sono ospite speciale assieme al grandissimo trombettista Brian Lynch, oltre al bassista argentino Fernando Huergo, al pianista brasiliano Helio Alves, e anche alla stupenda vocalist Kim Nazarian dei New York Voice. Ma ci tengo a sottolineare il grande significato del disco, e soprattutto questo vale per Nojechowicz, in quanto gli è stato ispirato dal passaporto di sua nonna ebrea quando fuggì con il figlio (il padre di Guillermo) da Varsavia, attraversò tutta l’Europa in treno per andare in Argentina nel 1933, il viaggio che li ha risparmiati dall’Olocausto.
Per differenziare il tuo latin hai chiamato in causa la scuola afrocubana. Ma soggiornando a Miami, Puerto Rico e altre località caraibiche il concetto di clave non ti ha mai sfiorato?
Questa domandona è molto interessante: infatti l’argomento della clave non va vincolato solo alla musica latina. Su questo aspetto è stato importantissimo lavorare a fianco di Danilo Pérez poiché è lui che mi ha aperto gli occhi su questo punto, che francamente io non vedevo. Il jazz e anche la clave provengono dall’Africa e adesso la clave non la associo soltanto alla musica latina ma anche al jazz. Poi se analizziamo ritmicamente la clave abakuá, trasportata poi a Cuba, ti rendi conto che è africana e la trovi nello swing del jazz. Facendo attenzione l’ho poi riscontrata anche in progetti di Herbie Hancock, ma ancora prima del bebop la clave abakuà la senti nel jazz precedente. Ascoltando bene e attentamente tutti i grandi afroamericani la trovi, mentre è più semplice identificarla nella musica latina poiché è in superficie. Importantissimi sono stati i miei anni a Puerto Rico dove ho suonato con quasi tutti i più importanti percussionisti locali, a cominciare da Paoli Mejias poi in generale con jazzisti come Charlie Sepulveda. Inoltre il programma che svolgevo al Conservatorio di San Juan era proprio dedicato a Jazz e alle musiche caraibiche, esperienze indimenticabili.
AFRICA. Hai parlato di Danilo e dell’Africa per spiegare la scoperta della clave e ricerca sul campo, cioè?
Durante i viaggi in Africa con Danilo abbiamo fatto molti concerti con musicisti africani e lì si capiscono bene le connessioni e tutti i ritmi che noi conosciamo sotto altre vesti. Abbiamo scoperto che vengono tutti dal continente nero, è pazzesco. Immaginati l’emigrazione forzata di schiavi, le diverse destinazioni una volta attraversato l’Atlantico: quelli che sbarcarono nei Caraibi, altri negli Stati Uniti, in Brasile, Colombia e dai diversi intrecci ne sono uscite delle sintesi differenti. Una cosa curiosa che ci capitò in questi incontri africani fu questa: quando ringraziammo i percussionisti che ci avevano permesso di approfondire i loro ritmi, sai cosa ci hanno risposto?: «Perché ci ringraziate? Questi non sono nostri ritmi ma vengono dalla terra». Da quel momento sorrido quando sento inutili diatribe sulla paternità di diversi ritmi afro-americani tra cubani, portoricani, brasiliani eccetera. Il dna è lo stesso ma siamo noi che tendiamo a dividere tutta questa musica figlia della medesima fonte che si chiama Africa, e a cui attingiamo tutti quanti.
E più che mai, se non erro, per scrivere nuove pagine di global jazz?
Sicuramente, infatti l’idea del global jazz deriva appunto da questo pensiero di come fare artisticamente connessioni appropriate basate su queste conoscenze e riscoprendo quel patrimonio. Secondo me, questo è quello che i giovani dovrebbero imparare nelle scuole di musica proprio per non cristallizzarsi negli stili già consolidati, bebop, hardbop eccetera perché il bello del jazz è di essere aperto a tutte queste diversità.
Prima abbiamo parlato del tuo ruolo al Berklee Global Jazz Institute la cui mission è far avanzare il potere della musica come strumento per il miglioramento della società. Ma ai vertici dell’accademia della Berklee ci sono altri italiani con un ruolo importante quanto il tuo?
Diciamo che nessuno ha un incarico di responsabilità come il mio, ma ci sono dei docenti molto validi come il batterista e compositore Marcello Pellitteri, siciliano che vive a New York e insegna da molti anni alla facoltà della Berklee. Con Marcello, persona squisita, abbiamo suonato parecchio assieme. Sempre come professori di jazz della Berklee ci sono altri italiani: il bassista Lello Molinari e la cantante-pianista Daniela Schachter, che è messinese anche se il cognome è tedesco. Lei vive da vent’anni negli Stati Uniti e ha vinto diversi premi tra cui il “The Mary Lou Williams Jazz Piano Competition”
Ricollegandomi al concetto BAM di Payton, ti chiedo se puoi chiarirmi un dubbio che mi frulla in testa e cioè: con tanti musicisti afroamericani bravi non è strano che siano degli italiani ad insegnare quel linguaggio nella terra dove il jazz è sorto? Mettendola giù con un paragone più semplice, sarebbe come concedere una cattedra di gastronomia bolognese sotto le Due Torri a un coreano, seppur eccellente dietro ai fornelli, piuttosto che a una sfoglina o a un cuoco nostrano. Cosa ne pensi?
Rido, perché è divertente il paragone e non so cosa risponderti. Ma una caratteristica degli americani veramente bella è questa: loro hanno molti difetti, però se tu hai qualcosa da offrire di qualità non ti chiudono la porta, anzi… E’ un criterio che non ho riscontrato in altri paesi dove ho viaggiato, mentre negli States se hai del talento ti aiutano a svilupparlo. Gli statunitensi hanno capito che questo atteggiamento fa parte della loro storia e sul fatto di chi insegna jazz, che sia un americano o uno straniero, a loro non gliene frega molto: l’importante è essere bravo e basta, direi che non sono campanilisti come noi.
E tra insegnanti stranieri e americani, non c’è nessuna chiusura di tipo sindacale, corporativo, sul piano professionale come invece accadeva molti anni fa?
Da quando sono a Boston nessuno mi ha mai fatto percepire che non avrei dovuto essere qui, che occupo un posto di altri. Al contrario: il fatto di essere italiano mi ha sempre consentito di avere porte aperte. Quello che dici tu invece accade veramente a Puerto Rico e io lo sentivo con fastidio sulla mia pelle quando dirigevo in quei luoghi. Però oggi qui a Berklee, per quanto mi riguarda, la risposta è assolutamente no. Gli afroamericani è vero che si sentono un po’ defraudati in generale dai bianchi perché loro si ritengono gli unici depositari di quell’arte, di quel patrimonio che oggi è di tutti ma che i bianchi l’hanno commercializzato di più e meglio. Molto spesso i neri non si sentono rappresentati in maniera giusta rispetto alla musica creata da loro e questo lo noto quando mi capita di parlare con dei musicisti afroamericani, ma posso dirti che tutto ciò non esiste con gli italiani.

Pignataro e Ciavarella
E alla Berklee non sono mai sorti conflitti di questo tipo nel corpo dei docenti?
Mi piace risponderti perché proprio di ciò stiamo parlando in questo periodo. Ad esempio qui la percentuale degli insegnanti di colore è abbastanza bassa, ma c’è un punto specifico che viene sempre più preso in considerazione, si tenta di incrementare non solo il numero degli afroamericani ma anche delle donne di colore poiché negli Stati Uniti è in corso un dibattito sullo sbilancio “razziale”, sull’allargamento dei diritti a tutti i cittadini, su quote diciamo “rosa” eccetera. In generale anche nelle scuole si sta affrontando l’argomento in modo serio, se ne parla nel paese perché in definitiva, e i numeri lo dimostrano, i neroamericani hanno tante ragioni per essere incazzati, scusa del “francesismo”. Effettivamente è una situazione ingiusta che va cambiata. Nel caso della Berklee bisogna avere più persone di colore, più donne e più donne di colore nella facoltà. E in questo senso l’ultimo progetto creato dalla Berklee è stato affidato alla grande batterista Terry Lyne Carrington creando uno spazio specifico al femminile che cerca di colmare le differenze delle donne nel jazz. Però, ricordiamoci sempre che Boston non è tutta l’America, perché nel centro degli Stati Uniti, ad esempio in Alabama (ma anche in altre regioni) ti accorgi che tira della bruttissima aria. Addirittura fa presa il nazionalismo bianco di Trump contro i latinos, contro tutti gli emigranti, roba da matti, e in alcune parti del paese l’atmosfera che si respira è da cowboy con la pistola sempre in mano.
Purtroppo, come diceva qualcuno, la storia è un gioco di cui si sono smarrite le regole. E alcuni, i vincitori, cercano di inventare e imporre delle nuove regole creando massacri e atteggiamenti disumani. Senza filosofeggiare tanto e anche solo con un po’ di presunzione basterebbe oggigiorno osservare il volto e gli atteggiamenti di certi leader politici (soprattutto biondicci), per intravedere in trasparenza i tratti e i misfatti di certi loro nefasti antenati.
Mi piace questa tua brillante “fotografia” per dire che dovremmo tutti ascoltare di più ma soprattutto leggere e rileggere la storia, un esercizio che ci aiuterebbe a guardare in avanti con maggior fiducia verso gli altri. E nel nostro piccolo il BGJI si muove in questa direzione per cercare punti di connessione extramusicali. In generale più viaggi nel mondo e più osservi le differenze con gli altri; ma se apri bene gli occhi ti rendi conto anche delle enormi interconnessioni tra le varie culture e, a volte, in modo sorprendente. Per esempio, per me siamo più cugini con i brasiliani che con i francesi oppure… E questo, a parte brasiliani o meno, lo constatai nel nostro meridione quando ero a fare concerti in Calabria con John Patitucci e Dado Moroni. Gli antenati si sono riconnessi con John conferendogli la cittadinanza onoraria nel paesino di Torano Castello (Cosenza) dove i nonni partirono per le Americhe. Quel concerto, bellissimo, lo ricordo con grande emozione.
Stai già pensando o realizzando altri progetti?
In mente ne ho due che vorrei assolutamente realizzare in tempi brevi: il primo con composizioni ispirate a canzoni napoletane arrangiate da John Patitucci per archi e soprano; il secondo invece sulla musica tradizionale argentina per proseguire la bella esperienza fatta con Nojechowicz.
Vorrei concludere questa maratona di parole chiedendoti se oltre a Stan Getz ci sono altri sassofonisti che in qualche modo ti hanno influenzato. E il sax nel latin?
Getz è stato il primo, e galeotto fu quel disco di bossa nova, dopodiché ho scoperto Sonny Rollins di cui sono stato attratto dalle sue radici antillane e, ancora a proposito di clave, in Rollins la trovi dappertutto. Poi Coltrane per aver rivoluzionato il concetto estetico e armonico del sassofono jazz. Dei maestri moderni ammiro moltissimo Joe Lovano, George Garzone, Charles Lloyd. Tra quelli latin ci metto due che hanno veramente creato un’estetica originale e sono i meravigliosi David Sánchez e Miguel Zenón. Prima mi citavi Paquito D’Rivera, che è un grandissimo maestro con il quale tra l’altro ho suonato, però David e Miguel hanno elaborato un linguaggio molto più collegato al jazz e sono artefici di una piattaforma innovativa e prospettivamente più importanti aprendo nuove strade al latin jazz. Tra l’altro loro stessi non lo definiscono neanche latin. Prima di chiudere la bellissima chiacchierata debbo ringraziare te per avermi risvegliato e aiutato a levare fuori dalla mia memoria dei ricordi e alcune fasi della mia preparazione bolognese, della mia storia musicale nata sotto le Due Torri, e pertanto mi faceva piacere far conoscere in particolare a miei conterranei tutto ciò. E grazie di questa intervista che sono certo mi farà scoprire agli italiani con il mio modo di fare jazz, che risente molto del mio innamoramento per l’America Latina, della fusione della mia parte mediterranea (napoletana, bolognese) e un po’ delle mie radici materne portoricane. Da qui viene il mio global jazz.
Gian Franco Grilli
VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTA INTERVISTA.



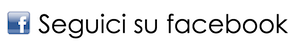













 Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.
Cinema Odeon (P.za Strozzi)-Festival Film Etnomusicale: domenica 18 novembre, ore 18, proiezione CHICO & RITA di Fernando Trueba.












 presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.
presenta Grandes Exitos de CUBA interpretati dai cantanti-chitarristi Roberto Gascón e José Ramon Cepeda (Son del Caribe – www.italvox.com): 14 successi della musica cubana. Da non perdere.